Piano Faunistico Provinciale Prima Revisione - Dicembre 2010
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

2A Serie Speciale - N
7-3-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 19 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/17 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2018 che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2018) 8527] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, considerando quanto segue: (1) La regione biogeografica alpina, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende i territori dell’Unione delle Alpi (Germania, Francia, Italia, Austria e Slovenia), dei Pirenei (Spagna e Francia), degli Appennini (Italia), delle montagne della Fennoscandia settentrionale (Finlandia e Svezia), dei Carpazi (Polonia, Romania e Slovacchia), delle Alpi Dinariche (Slovenia e Croazia) e dei monti Balcani, Rila, Pirin, Rodopi e Saštinska Sredna Gora (Bulgaria), secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito dall’articolo 20 di tale direttiva («comitato Habitat»). (2) Con la decisione 2004/69/CE (2) della Commissione è stato adottato l’elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Tale elenco è stato aggiornato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/42 (3) della Commissione. (3) I siti compresi nell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina fanno parte della rete Natura 2000, che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nell’Unione. -
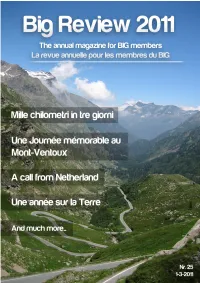
Revue 2011.Pdf
BIG Review 2011 Inhoudsopgave/Table of contents/ La table des matières Author Subject Pages Zone BIG Review Cover Colle del Nivolet Nr. 25 La table des matieres/Table of contents 1 Daniel GOBERT Le mot du president 2 01-03-2011 Dominque JACQUEMIN Carrefour/Crossroad 2011 3 Superliste 4-7 Distribuée à tous les Classement général 8-11 membres en règle. Classement claims 2010 12 Sent to all members regularly Daniel GOBERT Challenges paralleles 13-18 subscribed. Christian le CORRE Balance sheet 19-21 Brevet International du Daniel GOBERT Iron BIG 22-28 Grimpeur Anja von HEYDEBRECK Operation 2525 29 International Axel JANSEN Operation 2525 II 30-32 Cycloclimbing Diploma Daniel GOBERT The 25th birthday of my Baby BIG 33-34 Zwischenstaatliches Gianni CUCCONI La salita ci svela chi siamo 35-36 Kletterer Zeugnis Pete THOMAS Lake District 37-38 2 Internationaal Wim van ELS Engeland 39-40 2 Klimmersbrevet Brevetto Internazional Daniel GOBERT Les plus hautes routes des iles Britanniques 41-45 2 dello Scalatore Various autors UK meeting 46-51 2 Diploma Internacional del Helmuth DEKKERS Italian day in the Netherlands 52-56 3 escalador Gabriele BRUNETTI A call from Netherland 57-58 3 Helmuth DEKKERS Hungarian day in the Netherlands 59-62 3 Association des Monts de Gabor KREISCI September rain 63-64 3 France Super Grimpeur Franco- Roland SCHUYER 20 BIG’s in 4 dagen 65-68 3 Belge Dominique JACQUEMIN Rosier 69 3 Willem VODDE De West Vlaamse heuvels 70-71 3 Editeur/Editor : Daniel GOBERT Central Germany 72 4 Martin Kool Rob BOSDIJK Nebelhorn 73-74 -

Report 2010-11
Research Report 2010-2011 Research at Museo delle Scienze Science Science at Museo delle Scienze | Research Report 2010-2011 Science at Museo delle Scienze Research Report 2010-2011 MUSEO DELLE SCIENZE President Giuliano Castelli (Marco Andreatta since October 16th, 2011) Director Michele Lanzinger MdS Research Report 2010-2011 © 2012 Museo delle Scienze, Via Calepina 14, 38122 Trento, Italy Managing editor Valeria Lencioni Editorial committee Marco Avanzini, Costantino Bonomi, Marco Cantonati, Giampaolo Dalmeri, Valeria Lencioni, Paolo Pedrini, Francesco Rovero Editorial assistant Nicola Angeli Cover and layout design Roberto Nova Printing Tipografia Esperia Srl - Lavis (TN) 978-88-531-0019-1 SCIENCE at MUSEO DELLE SCIENZE RESEARCH REPOrt 2010-2011 5 Preface Part 1 7 1. Introducing MdS as museum and research centre 11 2. The research programmes 12 Programme 1R Ecology and biodiversity of mountain ecosystems in relation to environmental and climate change 12 Programme 2R Documenting and conserving nature 13 Programme 3R Plant conservation: seedbanking and plant translocation 13 Programme 4R Tropical Biodiversity 14 Programme 5R Earth sciences 14 Programme 6R Alpine Prehistory 15 3. The research staff and activities 19 4. The scientific collections 23 5. The main results and projects Part 2 57 Appendix 1: The staff of the scientific sections 85 Appendix 2: The staff of the science communicators 91 Appendix 3: Research projects, high education and teaching 105 Appendix 4: Publications 127 Appendix 5: Collaborations: the research national network 131 Appendix 6: Collaborations: the research international network Science at Museo delle Scienze: Research Report 2010-2011 1R 2R 3R 4R 5R 6R 4 Preface Fully developed as a natural history museum since the beginning of the 1900, the Museo Tridentino di Scienze Naturali, since May 2011 named Museo delle Scienze (MdS) over the past decade has developed a new cultural approach through innovative exhibitions and public programmes which prompted a wi- der interpretation of its strictly naturalistic institutional scope. -

I Parchi Nazionali Italiani
DETERMINAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE A LIVELLO DI SITO: I PARCHI NAZIONALI ITALIANI Rapporto tecnico finale Progetto svolto su incarico del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare Aprile 2009 Relazione LIPU a cura di: Marco Gustin (Responsabile Specie e ricerca, LIPU – BirdLife Italia); Claudio Celada (Direttore Conservazione Natura, LIPU – BirdLife Italia) Con il Contributo di: Dott. Enrico Bassi, Redazione della scheda sul Parco Nazionale dello Stelvio; Dott. Mauro Bernoni, Redazione della scheda sul Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise; Dott. Andrea Pirovano, Redazione della scheda sul Parco Nazionale Gran Paradiso; Dott. Marco Zenatello, Redazione della scheda sul Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli Valutazione dello stato di conservazione dei Parchi Nazionali italiani INDICE 1. Introduzione 3 2. Metodi 3 3. Trattazione dei singoli Parchi Nazionali 4 3.1. Parco Nazionale del Gran Paradiso 5 3.2. Parco Nazionale dello Stelvio 12 3.3. Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 84 3.4. Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna 119 3.5. Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano 151 3.6. Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 170 3.7. Parco Nazionale della Majella 219 3.8. Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena 242 3.9. Parco Nazionale del Circeo 269 4. Conclusioni 277 Ringraziamenti 283 2 LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli Valutazione dello stato di conservazione dei Parchi Nazionali italiani 1. Introduzione -

Jahrgang 68/2001 Inhaltsverzeichnis Und Stichwortregister
Jahrgang 68/2001 Inhaltsverzeichnis und Stichwortregister Die jeweils erste Zahl gibt die Heftnummer an; die zweite Zahl nennt die Seite des entsprechenden Heftes Beiträge nach Autoren Garnweidner, Siegfried, Ahrntaler Skitouren 2-60 Dolomiten-Klettersteige 7-16 Auferbauer, Günter und Luise, Das Tuxer Tal – ein Alles zu seiner Zeit 1-26 Engels-Berge 9-40 Touren-Six-Pack 4-26 Der alpine Jahreslauf 9-24 Herrn Blümlis Mythen-Wanderung 10-66 Das Ausseerland 7-56 Die Berge rund um den Achensee 6-32 Hütten in den Südalpen 6-28 Die Neue Prager Hütte 9-60 Große Skigipfel (3. Watzmannkind, Sonnblick, Klettersteige 4-16 Einsame Hafnergruppe 9-34 Lisenser Fernerkogel, Piz Palü) 2-22 The other side of paradise 9-28 Große Skigipfel (Hoher Dachstein, Granatspitze, Mit Firngleitern ins Wettersteingebirge 3-32 Vie ferrate à la française 5-60 Großglockner) 2-18 Grimm, Peter, Ein Hauch von Méditerranée 1-60 Wendelstein im Herbst 11-28 Hütten in den Ostalpen 6-14 El Hierro, die kanarische Wanderinsel 5-92 Westalpen-Klettersteige 8-16 Im Zug durch den Vereina-Tunnel 2-84 Wanderträume im Herzen des Oberwallis 7-24 Zwei Urner Klettersteige 11-72 Loferer und Leoganger Steinberge 5-30 Unterwgs in Osttirol 11-60 Höbenreich, Christoph, Mit Ski auf den Ätna 4-84 Ihle, Jürgen, Auf dem »Bärentrek« durchs Berner Wandern auf der Insel Madeira 12-68 Hoffmann, Herbert, Der Highline-Trail in der Wind Oberland 12-24 River Range 7-90 Boenisch, Gunther, Traumtouren links und rechts Höfler, Horst, Die Berliner Hütte 8-38 Jung, Günter, Wanderparadies Sächsische Schweiz des -

21-2-2013 E 7 8 N 45 3 E 7 23 N 45 4 E 7 28 N 45 10 E 6 55 N 45 3 E 7 44 N 45 24 E 7 53 N 45 29 E 6 49 N 45
21-2-2013 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 44 REGIONE PIEMONTE Superficie Lunghezza Coordinate geografiche CODICE DENOMINAZIONE * (ha) (km) Longitudine Latitudine IT1110006 Orsiera Rocciavré * 10965 E78 N453 IT1110007 Laghi di Avigliana * 420 E723 N454 IT1110008 Madonna della Neve sul Monte Lera * 62 E728 N4510 IT1110010 Gran Bosco di Salbertrand * 3712 E655 N453 IT1110013 Monti Pelati e Torre Cives * 145 E744 N4524 IT1110021 Laghi di Ivrea * 1598 E753 N4529 IT1110022 Stagno di Oulx * 84 E649 N452 IT1110026 Champlas - Colle Sestriere * 1050 E650 N4457 Boscaglie di Tasso di Giaglione (Val IT1110027 * 340 E657 N459 Clarea) IT1110029 Pian della Mussa (Balme) * 3554 E79 N4517 Oasi xerotermiche della Val di Susa- IT1110030 * 1250 E77 N459 Orrido di Chianocco IT1110031 Valle Thuras * 978 E651 N4453 IT1110032 Pra - Barant * 4120 E73 N4445 IT1110033 Stazioni di Myricaria germanica * 132 E77 N4448 IT1110038 Col Basset (Sestriere) * 271 E652 N4458 IT1110039 Rocciamelone * 1966 E75 N4510 IT1110040 Oasi xerotermica di Oulx - Auberge * 1070 E649 N453 IT1110042 Oasi xerotermica di Oulx - Amazas * 339 E649 N451 IT1110043 Pendici del Monte Chaberton * 329 E646 N4457 IT1110044 Bardonecchia - Val Fredda * 1686 E648 N455 IT1110045 Bosco di Pian Prà (Rorà) * 93 E711 N4447 IT1110048 Grotta del Pugnetto 19 1 E724 N4516 IT1110049 Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle * 1328 E639 N454 IT1110052 Oasi xerotermica di Puys - Beaulard * 468 E644 N452 IT1110053 Valle della Ripa (Argentera) 328 E654 N4453 IT1110055 Arnodera - Colle Montabone * 112 E73 N457 IT1110057 Serra di Ivrea * 4572 E756 N4529 IT1110058 Cima Fournier e Lago Nero * 640 E647 N4454 IT1110080 Val Troncea * 10130 E658 N4458 IT1110081 Monte Musiné e Laghi di Caselette * 1524 E728 N457 IT1120003 Monte Fenera * 3348 E820 N4542 IT1120006 Val Mastallone * 1882 E89 N4554 IT1120028 Alta Val Sesia * 7545 E753 N4553 IT1130002 Val Sessera * 10787 E82 N4541 IT1140003 Campello Monti * 548 E813 N4556 IT1140004 Rifugio M. -

Montagna Insieme Numero 55 - Novembre 2019
Montagna Insieme Numero 55 - Novembre 2019 CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI CONEGLIANO Ad ogni piede il suo plantare NOVITÀ Test posturale computerizzato per creare la soletta propiocettiva adatta a te Le solette propiocettive, attraverso degli stimoli alla pianta del piede, possono aiutare a correggere eventuali difetti posturali e a migliorare la tua efficienza muscolo scheletrica. Ortopedia Giubilato Vincenzo di Giubilato Dr. Stefano & C. sas Via G. Garibaldi, 17 Via C. Colombo, 30 (show room) 31015 - Conegliano (TV) Tel. 0438 22598 [email protected] www.giubilato.com Montagna Insieme Anno XXXV Numero 55 - Novembre 2019 CLUB ALPINO ITALIANO PUBBLICAZIONE SOCIALE IN DISTRIBUZIONE GRATUITA AI SOCI sezione di CONEGLIANO Nabois Grande ........................................................ 70 SOMMARIO La Val Travenanzes ................................................. 72 Vita di Sezione Ferrata dei Campanili .............................................. 73 Tempi...interessanti.................................................... 3 Viel del Pan ............................................................. 75 Consiglio Direttivo ..................................................... 4 Bivacco Carnielli - De Marchi .................................. 77 Rifugi e opere alpine ................................................. 5 Crode de San Pietro ................................................ 79 Tesseramento 2020 ................................................... 6 Marmolat................................................................. -

Phleum Commutatum and Ph. Rhaeticum (Poaceae) in the Eastern Alps: Characteristics and Distribution List of Seen Specimens
Phleum commutatum and Ph. rhaeticum (Poaceae) in the Eastern Alps: Characteristics and Distribution List of Seen Specimens By Kurt ZERNIG Abteilung für Botanik, Landesmuseum Joanneum, Raubergasse 10, A-8010 Graz, e-mail: [email protected] Published May 9, 2005 For details see: Phyton (Horn, Austria) 45 (1): 65–79. Summary The two species of Phleum alpinum group – Ph. commutatum GAUDIN and Ph. rhaeticum (HUMPHRIES) RAUSCHERT – were investigated. They can be differentiated morphologically by the presence (Ph. rhaeticum) or absence (Ph. commutatum) of ciliae on the awns on the glumes. But this character turned out to be insufficient for populations which have one or few cilia on the base of awns. Some other morphological characters were tested, if and to what extent, they provide additional features to facilitate correct determination. The length of the anthers shows distinct differences between the two species: anthers of Ph. commutatum are (0.6) 0.7–1.2 (1.3) mm long, while those of Ph. rhaeticum measure (1.0) 1.3–2.0 (2.3) mm. Collection sites of more than 1200 revised herbarium specimens are localized and shown in dot maps. Ph. rhaeticum is very common and frequent in the central and southern regions of the Eastern Alps, towards the north it becomes rarer. It prefers pastures in the subalpine and alpine belt. Ph. commutatum, in contrast, grows especially in the alpine belt of the Central Alps, there forming part of the snow-bed vegetation. Towards the north it becomes more common, where it grows in moderate altitudes from 1500 m upwards. -

WCO-Lite: Online World Catalogue of Harvestmen (Arachnida, Opiliones)
WCO-Lite: online world catalogue of harvestmen (Arachnida, Opiliones). Version 1.0 Checklist of all valid nomina in Opiliones with authors and dates of publication up to 2018 Warning: this paper is duly registered in ZooBank and it constitutes a publication sensu ICZN. So, all nomenclatural acts contained herein are effective for nomenclatural purposes. WCO logo, color palette and eBook setup all by AB Kury (so that the reader knows who’s to blame in case he/she wants to wield an axe over someone’s head in protest against the colors). ZooBank register urn:lsid:zoobank.org:pub:B40334FC-98EA-492E-877B-D723F7998C22 Published on 12 September 2020. Cover photograph: Roquettea singularis Mello-Leitão, 1931, male, from Pará, Brazil, copyright © Arthur Anker, used with permission. “Basta de castillos de arena, hagamos edificios de hormigón armado (con una piscina en la terraza superior).” Miguel Angel Alonso-Zarazaga CATALOGAÇÃO NA FONTE K96w Kury, A. B., 1962 - WCO-Lite: online world catalogue of harvestmen (Arachnida, Opiliones). Version 1.0 — Checklist of all valid nomina in Opiliones with authors and dates of publica- tion up to 2018 / Adriano B. Kury ... [et al.]. — Rio de Janeiro: Ed. do autor, 2020. 1 recurso eletrônico (ii + 237 p.) Formato PDF/A ISBN 978-65-00-06706-4 1. Zoologia. 2. Aracnídeos. 3. Taxonomia. I. Kury, Adriano Brilhante. CDD: 595.4 CDU: 595.4 Mônica de Almeida Rocha - CRB7 2209 WCO-Lite: online world catalogue of harvest- men (Arachnida, Opiliones). Version 1.0 — Checklist of all valid nomina in Opiliones with authors and dates of publication up to 2018 Adriano B. -

Escursioni Al Lago Di Garda
collanasentierid’autore 25 Escursioni al Lago di Garda Dove le Alpi Sponda Lombarda profumano di Alto Garda Valle di Ledro Mediterraneo Valle del Sarca Sponda Veneta idea Montagna editoria e alpinismo l Introduzione INTRODUZIONE SEGUI IDEA MONTAGNA SU: Il Lago di Garda è diventato, nel corso dei decenni, un luogo simbolo dello sport all’aria aperta, www.facebook.com/ideamontagna un vero e proprio punto di riferimento, in tutta Europa, per chi ama camminare, correre, arram- picare, pedalare, volare, nuotare. I percorsi pedonali e ciclabili si inoltrano in ogni piccola valle, 03 plus.google.com/+IdeamontagnaIt04 www.pinterest.com/ideamontagna costeggiano, a breve distanza o dalle cime sovrastanti, i quasi 160 chilometri di sviluppo costiero www.slideshare.net/IdeaMontagna del più grande lago d’Italia. Centinaia sono le vie d’arrampicata della Valle del Sarca, molte le 05 06 ferrate e i sentieri attrezzati, così come numerosi i luoghi famosi per tuffarsi nelle fresche acque del lago o dei suoi tanti impetuosi immissari oppure per lanciarsi dagli erbosi crinali con il parapendio. Ma ridurre questo straordinario solco di acqua a un grande, immenso parco giochi 07 Scarica08 l’APP Idea Montagna! sarebbe ingiusto e riduttivo. Questo specchio azzurro circondato da rocce argentate, è prima di tutto uno straordinario scrigno di biodiversità, che non ha eguali in tutto il Vecchio Continente, è pure un luogo dove FOTOGRAFIE 09 Tutte le fotografie10 utilizzate sono dell’autore, dove non specificato in didascalia. gustare i profumi del Mediterraneo ai piedi delle Alpi, dove appoggiare i piedi nello stesso 01 02 luogo dove hanno lasciato le loro orme gli uomini preistorici che costruivano palafitte, hanno marciato le legioni romane verso i confini dell’impero, hanno combattuto condottieri come Garibaldi e i soldati della Prima Guerra Mondiale e dove artisti come Dürer hanno lasciato il Prima edizione: marzo 2018 loro segno. -

Museo Storico Italiano Della Guerra - Rovereto Via Castelbarco, 7 38068 Rovereto (TN) Tel
N° 14/16Museo Storico Italiano 2006-2008 della Guerra ANNALI © Museo Storico Italiano della Guerra - Rovereto via Castelbarco, 7 38068 Rovereto (TN) Tel. 0464 438100 - fax 0464 423410 [email protected] www.museodellaguerra.it Direttore responsabile: Camillo Zadra Redazione: Nicola Fontana, Alberto Miorandi, Anna Pisetti, Fabrizio Rasera (coordinatore), Lodovico Tavernini, Camillo Zadra, Antonio Zandonati Associato all’USPI Unione Stampa Periodica Italiana 2 INDICE STUDI E RICERCHE MARCO BELLABARBA: Prete e reclutatore: don Giovanni Battista Bevilacqua al servizio dell’esercito prussiano 7 LAWRENCE COLE: Veterani militari e patriottismo popolare nell’Austria imperiale (1870-1914) 25 FILIPPO CAPPELLANO, BASILIO DI MARTINO: L’arma della “fraternizzazione” nella Grande Guerra. Qualche riflessione sul caso del piccolo posto di Val Camugara (Monte Cimone), febbraio-marzo 1918 51 GERALD STEINACHER: Dall’Amba Alagi a Bolzano. Tracce d’Africa in Alto Adige 75 PAOLO POZZATO: Il Genio italiano e la fortezza di Serrada 91 LODOVICO TAVERNINI: L’Albo dei caduti trentini nella Grande Guerra Criteri e modalità della ricerca 103 DIDATTICA ANNA PISETTI: Incontrare la storia nel museo. Riflessioni sulle esperienze didattiche nei musei storici italiani 119 ARCHIVI ISABELLA BOLOGNESI, NICOLA FONTANA, SABINA TOVAZZI: Fonti per la storia del combattentismo in Trentino nell’archivio del Museo della Guerra 141 3 COLLEZIONI CAMILLO ZADRA: Note sul riallestimento del Museo della Guerra. Un nuovo patto tra museo e visitatore 181 JOSCHI SCHUY: La rivoltella d’ordinanza M. 1877 sistema Gasser. Un raro revolver d’ordinanza austriaco nella collezione del Museo 195 RENATO TRINCO: La donazione dei calchi in gesso della seconda Campana dei Caduti 203 ANGIOLINA MASTRANGELO: Il lungo viaggio di un ex voto. -
Monographische Studien Über Die Gattung Saxifraga
© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at ^ 3-3» DUPLICATA DE LA BD3LIOTHEQtTE DU CONSERVATOIRE BOTANTQUE DE GENE Dr. A. v. Hayek. vendu en 1922 MONOGRAPHISCHE STUDIEN ÜBER DIE GATTUNG SAXIFRAGA I. DIE SEKTION PORPHYRION tausch. VON Med. et Phil. Dr. AUGUST v. HAYEK. Mit 2 Tafeln und 2 Karten. BESONDERS ABGEDRUCKT AUS DEM LXXVII. BANDE DER DENKSCHRIFTEN DER MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHEN KLASSE DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. WIEN 1905. AUS DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSDRUCKEREI. IN KOMMISSION BEI ALFRED HOLDER BUCHHÄNDLER DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER mSSONSOHAETEN WIEN, I., Rntenturmstrrulo 18. © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at MONOGRAPHISCHE STUDIEN ÜBER DIE GATTUNG SAXIFRAGA I. DIE SEKTION PORPHYRION tausch. von Med. et Phil. Dr. AUGUST v. HAYEK. Mit 2 Tafeln %md 2 Karten. BESONDERS ABGEDRUCKT AUS DEM LXXVII. BANDE DER DENKSCHRIFTEN DER MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHEN KLASSE DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. NEW \0'.'K ROTANtCAl, WIEN 1905. AUS DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSDRUCKEREI. IN KOMMISSION BEI ALFRED HOLDER BUCHHÄNDLER I)ER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN WIEN, I., Rotunturinstraßa IS. © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at #3? © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at r u MONOGRAPHISCHE STUDIEN ÜBER DIE GATTUNG SAXIFRAGA I. DIE SEKTION PORPHYRION tausch. VON Med. et Phil. D^ AUGUST v. HAYEK. Mit 2 Tafeln und 2 Karten. VORGELEGT IN DER SITZUNG AM 15. DEZEMBER 1904. - Einleitung . Die Veranlassung zu nachfolgender Arbeit war eine ganz zufällige. Im Sommer des Jahres 1901 sammelte ich nämlich in den Alpen Obersteiermarks zwei Saxifragen aus der Sectio Porphyrion Tausch, welche auf den ersten Blick als zwei verschiedene Arten zu erkennen waren.