Piano Strutturale Comunale Quadro Conoscitivo Quadro Conoscitivo Quadro
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Scarica Il Documento
REGIONE EMILIA ROMAGNA AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara Sud sulla A13 PROGETTO DEFINITIVO INDAGINI ARCHEOLOGIA Relazione I N D I C E 1 PREMESSA ................................................................................................................................................ 4 2 SINTESI ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO ............................................................................................. 5 3 VERIFICA DI OTTEMPERANZA DELLE PRESCRIZIONI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO ............. 7 3.1 DOCUMENTI ESAMINATI ...................................................................................................................... 7 3.2 ANALISI DELL’ITER PROCEDURALE E PRESCRITTIVO .................................................................... 8 4 REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELLE INDAGINI ARCHEOLOGICHE ......................................... 11 4.1 DOCUMENTI ESAMINATI .................................................................................................................... 11 4.2 RICERCA BIBLIOGRAFICA E D’ARCHIVIO 2012-2019 ...................................................................... 13 4.2.1 Comune di Mezzani – MZ ............................................................................................................ 16 4.2.2 Comune di Parma – PR ............................................................................................................... 16 4.2.3 Comune di Sorbolo – SB ............................................................................................................ -

Relazione Tecnica
Relazione Tecnica ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE E GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE MAPPATURA ACUSTICA DELLA RETE DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N° 194 AGGIORNAMENTO DELLE IMMISSIONI DELL’INTERA RETE RELAZIONE TECNICA – AGGIORNATA ALLE LINEE GUIDA DEL 2 OTTOBRE 2017 Luglio 2018 1° emissione Giugno 2017 Relazione Tecnica - Mappatura Acustica aggiornamento Luglio 2018 INDICE 1. INTRODUZIONE GENERALE ................................................................................................................. 4 2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ............................................................................................ 7 3. DESCRIZIONE DELL’INFRASTRUTTURA STRADALE ..................................................................... 10 3.1. Dati di traffico e loro distribuzione ...................................................................................... 10 3.1.1. Principio di funzionamento SicVe (Tutor) ................................................................................... 10 3.2. Elenco assi stradali principali e Flussi di traffico ................................................................ 12 3.2.1. ASSE IT_a_rd0002001 ............................................................................................................... 12 3.2.2. ASSE IT_a_rd0002002 ............................................................................................................... 14 3.2.3. ASSE IT_a_rd0002003 .............................................................................................................. -
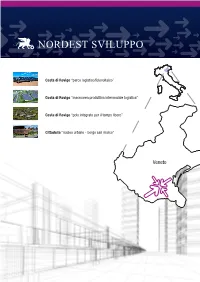
The New Macro-Area Is One of the Most Important Productive Area of the Venetian Territory in the South of Padova
Costa di Rovigo “parco logistico/fotovoltaico” Costa di Rovigo “macroarea produttiva intermodale logistica” Costa di Rovigo “polo integrato per il tempo libero” Cittadella “nucleo urbano - borgo san marco” Veneto Le società che si presentano con il logo NordEst Sviluppo hanno fatto proprio questo concetto, concentrando il proprio interesse nell’area del Nord Est. Dispongono di aree per lo sviluppo della Logistica e delle attività terziarie e secondarie. Costa Sviluppo Spa nel Comune di Costa di Rovigo (Ro) sta sviluppando un Parco Logistico di circa mq 1.200.000 ed un Parco Tematico Polo per il Tempo Libero per circa mq 1.150.000; Vibrocemento Veneta Spa sta sviluppando aree per la logistica a Monselice (Pd) per mq 500.000 circa, a Motta di Livenza (Ve), Cessalto (Tv) e Teglio Veneto (VE). Sirio San Marco Spa sta sviluppando nell’Alta Padovana e più precisamente nel centro urbano di Cittadella (Pd) un’area Residenziale/Commerciale di circa mq 170.000 per mc 400.000. Il gruppo dispone di una adeguata e competente struttura tecnica per la soluzione delle problematiche afferenti allo sviluppo delle aree proposte. Societies introduced with the NordEst Sviluppo logo have made just this concept, concentrating just the interest in the area of the North East. They have areas for the development of Logistics and in tertiary and secondary activities. Costa Sviluppo Spa is developing in Costa di Rovigo (Ro) a logistics park of around mq 1.200.000 and a theme park polo for free time of about mq 1.150.000; Vibrocemento Veneta Spa is developing areas for logistics in Monselice (Pd) for around mq 500.000, in Motta di Livenza (Ve), Cessalto (Tv) and Teglio Veneto (Ve). -

35127 Padova (Italy) Email: [email protected]
Come raggiungere la nostra sede How to reach our head offices La sede dell'azienda è facilmente raggiungibile The company head offices have an easy sia arrivando dall'autostrada Milano-Venezia che access from the Milan-Ven ice motorway, as percorrendo la Bologna-Padova: well as from the Bologna-Padova motorway: Arrivando dall'autostrada A4 Milano-Venezia Arriving from the A4 Milan-Venice motorway Usciti dal casello autostradale Padova Est (1) si svolta a destra, Once outside the "Padova Est" motorway toll-house (1) go tenendo la sinistra si svolta a sinistra in via Venezia si prosegue straight on and turn right and then turn left in via Venezia. per circa 500 metri e si gira ancora a sinistra, si entra in via After 500 meters turn left and arrive in via Delle Grazie. Delle Grazie e la si percorre per 500 metri. Arrivati alla After 500 meters, when you are at the roundabout in front rotatoria davanti all’Hotel Sheraton, si gira a destra e ci si of the Sheraton Hotel, turn right in to Corso Argentina, where immette in corso Argentina. L'uscita da prendere è la seconda you'll find directions for "Camin-Vigonovo": go down the ed è contrassegnata dalla segnalazione per "Camin-Vigonovo". second exit. Turn left into Via Vigonovese and turn left again Allo stop si incrocia quindi via Vigonovese dove si svolta a after 300 meters at number 123 into the Alkè offices (3). sinistra, 300 metri e, sempre sulla sinistra, al 123, si trova la sede degli uffici Alkè (3). Arrivando dall'autostrada A13 Bologna-Padova Arriving from the A13 Bologna-Padova motorway Appena usciti dal casello autostradale di Padova Interporto (2) Once outside the "Padova Interporto" motorway toll-house si svolta verso sinistra in corso Stati Uniti percorrendolo quasi (2), turn left into Corso Stati Uniti and go str aight on until interamente e, non appena passato il sottopasso di corso you pass under Corso Argentina and, some 50 meters after, Argentina, ci si immette sulla destra in via Uruguay. -

Piano Regionale Dei Trasporti Del Veneto Quadro Infrastrutturale Del Veneto
Piano Regionale dei Trasporti del Veneto Quadro infrastrutturale del Veneto 10 QUADRO INFRASTRUTTURALE DEL VENETO 10.1 Corridoi 10.1.1 Definizione di “Corridoio” e alcuni precedenti I Corridoi vengono qualificati oggi come "multimodali", indicando così che essi non corrispondono semplicemente ad un tracciato ma sono dei connettori globali attraverso cui passa il trasporto di merci, di persone, di energia e di sistemi di telecomunicazione. I Corridoi multimodali dovranno altresì incentivare la creazione o il potenziamento di poli di sviluppo nelle aree da essi attraversate al fine di rendere il progetto, nel tempo, economicamente sostenibile L'idea dei Corridoi nasce con la caduta del Muro di Berlino per favorire la cooperazione economica fra Europa e paesi dell'Est e predisporre così le basi della loro futura integrazione nell'Unione Europea. Inizialmente concepiti come paneuropei, i Corridoi hanno finito per acquistare ormai un significato transcontinentale, in previsione dei collegamenti che essi dovranno stabilire con la regione del Caspio e con l'Asia centrale per garantire i futuri approvvigionamenti energetici dell'Europa. In questa prospettiva i Corridoi transeuropei rappresentano l'ossatura portante del disegno geopolitico e di integrazione economica tra l'Europa comunitaria. La rete originaria era imperniata essenzialmente sul Corridoio V (Trieste-Lubiana- Budapest-Kiev), recentemente completato dal progetto della bretella verso l'Adriatico (Budapest-Sarajevo-Ploce); sul Corridoio n. IV, che agganciandosi al nodo di Budapest doveva mettere in comunicazione l'Europa comunitaria con il porto di Costanza sul Mar Nero attraverso la Bulgaria; sul n. VII, costituito dal sistema fluviale danubiano e reso economicamente più importante dopo il collegamento al sistema fluviale del Reno tramite alcuni canali; sul n. -

MIRAMARE IT DE Gb FR IT DE Gb FR IT DE Gb FR Miramarecampingcamping VILLAGE .Com
CAMPING VILLAGE MIRAMARE IT DE Gb FR IT DE Gb FR IT DE Gb FR miramareCAMPINGcamping VILLAGE .com REGOLAMENTO INTERNO ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN Il regolamento viene consegnato agli ospiti al momento del loro arrivo; è affisso sia all’ingresso che all’interno del Villaggio Vorliegende Interne Vorschriften werden unseren Gästen bei der Anmeldung ausgehändigt und sind sowohl am Eingang wie CAMPING VILLAGE COME CAMPING VILLAMIRAMARGE E turistico. L’atto d’ingresso al Villaggio implica, da parte dell’ospite, la sua completa accettazione ed osservanza. Nell’interesse auch im Innern der Ferienanlage sichtbar ausgehängt. Bei Betreten der Anlage akzeptiert der Gast diese Vorschriften ohne contatti CAMPING VILLAGE di tutti, la Direzione si riserva il diritto di allontanare e perseguire penalmente coloro che omettano l’osservanza anche di Recht auf Vorbehalt. Im Interesse aller Gäste behält sich die Direktion das Recht vor, jeden,der diese Bestimmungen in auch ARRIVARE un solo punto del presente regolamento oppure che, con il loro comportamento, pregiudichino il mantenimento dell’ordine e nur einem einzigen Punkt nicht beachtet oder durch sein Verhalten die Ruhe und die Ordnung im Feriendorf beeinträchtigt, della quiete all’interno del Villaggio. von der Anlage zu verweisen und strafrechtlich zu verfolgen. Für einen unbeschwerten und angenehmen Aufenthalt ist die ...tutto quello che cerchi La collaborazione dei nostri Ospiti è indispensabile per garantire un soggiorno sereno e piacevole a tutti. Mitarbeit aller unentbehrlich. MIRAMARE ART.1: ACCESSO AL VILLAGGIO ART. 1: ZUGANG ZUR FERIENANLAGE 1. Der Zugang zur Ferienanlage und zum Strand ist allein denjenigen gestattet, die durch Vorlage eines gültigen Auswei- ANNIVERSARY 1. L’ingresso al Villaggio e alla spiaggia è consentito soltanto a chi è stato regolarmente autorizzato, dopo aver esibito un IN AUTO MIT DEM AUTO documento per le registrazioni così come richiesto dalla legge. -

Occhiobello Outlet Village Mira a Coniugare Shopping E Turismo
Urbanistica, real estate & cci ALLO STUDIO L’ACCESSO ALLA STRUTTURA ANCHE PER VIA FLUVIALE, con un piccolo porto sul po Occhiobello Outlet Village mira a coniugare shopping e turismo Roberto Pacifico inizio dei lavori di scavo e co- struzioni è previsto per no- L’vembre 2009, con apertura in pro- gramma per la primavera 2010. Il progetto realizzato da Costruzio- ni Generali Italia prevede due prin- cipali fasi: la prima consiste nella realizzazione dell’Occhiobello Ou- tlet Village che prevede, su una Gla di 20.000 mq, 74 punti di vendita, 1. Il factory outlet center aprirà nella primavera Promotore e costruttore: Costruzioni Generali Italia Direzione generale dei lavori: KBoard 2010, in provincia di cesso in circa un’ora d’auto. L’outlet Commercializzazione: DB Retail sarà infatti accessibile sia attraver- Rovigo. A 5 minuti Superficie totale: (prima fase) 120.000 mq so la strada regionale Eridania 6, Superficie di ampliamento: (seconda fase) 112.000 mq da Ferrara sia mediante l’uscita Occhiobello Superficie lorda affittabile: 20.000 mq 2. Target: famiglia dell’autostrada A13 attraverso 3 in- Superficie di vendita: 12.480 mq nesti di rotatorie dedicate in grado di 4 persone, di ceto Superficie fabbricati: 19.709 mq di garantire il regolare deflusso del Di cui: Negozi: 17.179 mq medio-alto traffico sull’asse nord-sud Manto- Uffici: 760 mq va-Ferrara. L’outlet sarà d’interesse Servizi: 535 mq per tutti gli abitanti di alcune delle Porticati : 3.100 città più ricche d’Italia come Pado- Parcheggi: 1.640 posti auto cui seguirà una fase successiva di va, Mantova, Bologna Ferrara. -

L'autostrada Regionale Cispadana
L’AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA Aggiornamento situazione a marzo 2014 Aspetti programmatori La previsione della Cispadana trova specifica collocazione nelle politiche regionali di settore (PRIT del 1986, PRIT del 1998): essa è pertanto un’opera infrastrutturale strategica di interesse regionale, coerente con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale. La L.R. 3/1999 e successive modifiche prevede la possibilità di programmare, come autostrade regionali, alcune infrastrutture di interesse regionale previste dal PRIT, sulla base di uno specifico studio di fattibilità. Pertanto, nel 2006 la Regione ha realizzato uno studio di fattibilità che ha collocato l’autostrada Cispadana all’interno del medesimo corridoio individuato in sede di pianificazione regionale e in particolare nel progetto preliminare predisposto mentre si stava elaborando il PRIT86. Tale studio di fattibilità ha quindi risposto all’esigenza di conservare quanto più possibile il tracciato plano- altimetrico dei lotti del tracciato originario di “Cispadana” già previsti o realizzati, secondo quanto indicato nel PRIT98. Sulla base dello Studio di Fattibilità elaborato, l’Assemblea Legislativa regionale ha approvato, in data 5 luglio 2006, con deliberazione n. 64, il programma delle autostrade regionali contenente l’Autostrada Cispadana da Ferrara a Reggiolo – Rolo, stabilendo quale modalità di realizzazione lo strumento del “Project Financing”, secondo le procedure previste dalla normativa vigente e con un’eventuale partecipazione finanziaria regionale massima pari a 350.000.000 Euro. A seguito dell’approvazione di tale programma, il 1° agosto 2006 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la ricerca sul mercato di un soggetto privato in grado di proporsi per il finanziamento, nonché per la realizzazione e gestione dell’opera, fissando il 2 gennaio 2007 come scadenza per la presentazione delle proposte. -

Autostrada A13 Bologna – Padova Tratta Funzionale Ferrara Sud – Bologna Arcoveggio
PROGETTODEFINITIVO DIPARTIMENTOPERLEINFRASTRUTTURE,GLIAFFARIGENERALIEDILPERSONALE STRUTTURADIVIGILANZASULLECONCESSIONARIEAUTOSTRADALI AAUUTTOOSSTTRRAADDAA AA1133 BBOOLLOOGGNNAA –– PPAADDOOVVAA Ampliamento alla terza corsia dell’Autostrada A13 Bologna – Padova Tratta funzionale Ferrara Sud – Bologna Arcoveggio Progetto Definitivo Studio di traffico Dicembre 2016 STUDIO DI TRAFFICO Pagina 1 Ing. Stefano Santambrogio Ing. Roberto Piovano con la consulenza di: Ing. Enrico Bernardis Ing. Gianpiero Bruno Sticchi Ing. Omar Luison Ing. Renato Crosato STUDIO DI TRAFFICO Pagina 2 STUDIO DI TRAFFICO Pagina 3 CONTENUTI 1 INTRODUZIONE ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 2 QUADRO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI ...................................................................................................................................................................................................................................7 2.1 IL NODO AUTOSTRADALE DI BOLOGNA NEL CONTESTO DELLA RETE AUTOSTRADALE REGIONALE .......................................................................................................................................................................................................................................7 -

X Prof. Ing. Renato Vitaliani Curriculum O
. xx Prof. Ing. Renato Vitaliani Curriculum o Prof.Ing.Renato Vitaliani CURRICULUM SCIENTIFICO E DIDATTICO DEL PROF.ING.RENATO VITALIANI GENERALITÀ Prof. ing. Renato Vitaliani, nato a Piove di Sacco (Pd) il 23 giugno 1946, residente a Padova in Via Portello n. 38 int. 13, studio presso il Dipartimento di Costruzioni e Trasporti dell’Università di Padova in via Marzolo 9 – Tel. 0498275622 – Fax 0498275612 – e-mail [email protected] ; studio professionale a Padova in Via Lisbona n. 28/A – Tel. 049 8724244 – Fax 049 8724247 – e-mail [email protected] , pec [email protected] Professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso Facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova, a tempo definito; Laurea in Ingegneria Civile, Sezione Trasporti, presso l'Università di Padova con punti 110/110 e lode (luglio 1971); Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Prov. di Padova al n. 768 dal 10/11/72; Iscritto nell’Elenco di cui al D.M. 25.03.1985 - Legge 818/84 Iscritto nell’elenco Regionale dei collaudatori Tecnici al n° 797 dal 1992; Abilitato in materia di sicurezza ai sensi D.Lgs 81/2008 art. 98; - Attualmente titolare del corso di “Tecnica delle Costruzioni 2” e di “Progetto di Strutture” per la Laurea Magistrale in Ingegneria Civile presso l’Università di Padova; a partire dal 1977 è stato titolare presso stessa Facoltà dei corsi di: “Strutture Speciali in Cemento Armato”, “Calcolo Automatico delle Strutture”, “Costruzione di Ponti”, “Strutture prefabbricate”, “Tecnica delle Costruzioni 2”,“Tecnica delle Costruzioni”, e del corso di “Consolidamento ed Adattamento degli Edifici” presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia; - Titolare di uno studio professionale, presidente della Società di Ingegneria Iconia s.r.l. -
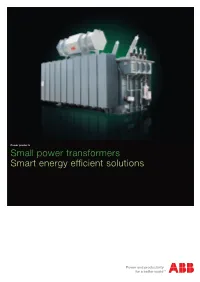
Small Power Transformers Smart Energy Efficient Solutions Table of Contents
Power products Small power transformers Smart energy efficient solutions Table of contents A world class transformer factory...................................................................................................................................... 4 Technology Center ............................................................................................................................................................. 6 High Temperature Class Transformers .............................................................................................................................. 7 Standard features of power transformers .......................................................................................................................... 8 Production ....................................................................................................................................................................... 10 Quality ............................................................................................................................................................................. 12 Customer complaints resolution process ........................................................................................................................ 12 Improvement Projects, 4Q, Quality School ...................................................................................................................... 13 Service ............................................................................................................................................................................ -
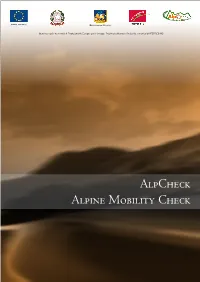
Alpcheck Alpine Mobility Check
Questo progetto ha ricevuto il Finanziamento Europeo per lo Sviluppo Regionale attraverso l’iniziativia comunitaria INTERREG IIIB AlpCheck Alpine Mobility Check Curato da: REGIONE VENETO - Unità Complessa Logistica, SISTEMI OPERATIVI S.r.l. Grafiche e stampa a cura di: Studio Clipart - Venice, June 2008. AlpCheck - Alpine Mobility Check Progetto finanziato dall’Unione Europea, Programma INTERREG IIIB Spazio Alpino 2000-2006 REGIONE VENETO © tutti i diritti sono riservati. Sono vietate tutte le riproduzioni, anche parziali, se non espressamente autorizzate. AlpCheck - Alpine Mobility Check Il consorzio del progetto AlpCheck: Leader Partner: Regione Veneto – Unità Complessa Logistica Calle Priuli Cannaregio, 99, 30121 Venezia http: www.regione.veneto.it Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Agricoltura, Risorse Naturali e Protezione Civile - Direzione Protezione Civile - Servizio Interventi Operativi Palazzo Regionale - Piazza Deffeyes, 1 - 11100 Aosta – Italy Regione Autonoma Valle d’Aosta http: www.regione.vda.it/protezione_civile Carinthia Regional Government Administration (Department 7 - Common Law and Infrastructure) Miesstaler Strasse 1 – 9020, Klagenfurt, Austria Carinthia Regional Government Administration http: www.ktn.gv.at European Academy - Bolzano/Bozen Via Druso 1 – 30900 Bolzano / Bozen – Italy European Academy http: www.eurac.it University of Maribor, Faculty of Civil Engineering Smetanova 17 – 2000, Maribor - Slovenia http: www.fg.uni-mb.si University of Maribor Autorità Portuale di Venezia Zattere, 1401 – 30123,