Universita' Di Pisa Dipartimento Filologia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Attività 2010
2010 Fondazione Cassa di Risparmi Livorno - Attività 2010 - Edizione 2011 Fondazione Fondazione Cassa di Risparmi Cassa di Risparmi di Livorno di Livorno Attività 2010 Attività 2010 Edizione 2011 Edizione 2011 Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno Attività 2010 Edizione 2011 A cura di Stefania Fraddanni Debatte Editore 2 3 Maggiore COESIONE per scegliere insieme È un fatto indiscutibile, forse scontato, che nei momenti di crisi e difficoltà si debbano impiegare le risorse con l’obiettivo di intervenire sui bisogni emergenti di un territorio. Con questo impegno la nostra Fondazione, nell’anno 2010, ha rivolto particolare attenzione al mondo del volontariato e dei soggetti più deboli. Tale scelta, però, non ha fatto dimenticare le nostre responsabilità verso altre esigenze nel settore dell’arte, dell’istruzione, della sanità e della ricerca scientifica, come questa pubblicazione illustra in modo puntuale. Quest’anno, forse per la prima volta, siamo stati costretti a respingere, con rammarico, molte richieste che esprimevano progetti validi. Purtroppo, inevitabilmente, le scelte che abbiamo dovuto operare non sempre sono state percepite in modo positivo, ma il nostro compito è proprio quello di privilegiare e selezionare progetti che abbiano la capacità di portare benefici diffusi e attrarre, se possibile, ulteriori fonti di finanziamento. In questi anni, ben prima che la crisi esplodesse, avevamo più volte sottolineato come fosse necessario chiedere alle associazioni, in ogni settore, di superare le appartenenze e di intraprendere progetti comuni che aumentassero l’efficacia finale e rendessero più sostenibili i costi. Solo in pochi casi ciò è avvenuto; questa strada, invece, deve essere percorsa con maggiore impegno e determinazione e da parte nostra faremo quanto necessario per renderla praticabile. -

Leonardo Da Vinci Il Genio E Le Invenzioni
Anno III n. 4 BIMESTR ALE D’ARTE, LETTER ATUR A E CULTUR A Redazione, amministrazione: Via Feltre, 71 - 20134 Milano - Direttore responsabile: Lidia Silanos 2011 Edito da Associazione Culturale Zaffiro - Milano, Via Feltre, 71 - Telefono 02.215.50.24 Settembre / Ottobre La mostra a Palazzo della Cancelleria di Roma prorogata fino al 30 aprile 2012 Leonardo da Vinci Il genio e le invenzioni Un museo interattivo delle macchine inventate, e ora funzionanti, dallo sconfinato talento del Genio del Rinascimento italiano opo il grande successo in Germania al Palazzo della Cancelleria di Roma dove derlo resistente all’usura e indeformabile. De a Vienna con oltre 60.000 visitato- avrebbe dovuto rimanere per un anno, ma la Gli 800 mq. di superficie ospitano oltre 45 ri, con il patrocinio della Regione Lazio numerosa affluenza di pubblico ne ha fatto macchine, suddivise in 5 categorie rappre- la mostra “Leonardo da Vinci - Il genio prorogare la chiusura al 30 aprile 2012. sentanti i 4 elementi vitali: acqua, aria, ter- e le invenzioni” arriva nel 2009 in Italia L’ingegno e il talento di Leonardo da Vin- ra e fuoco, con l’aggiunta di meccanismi ci, riconosciuti univer- a seconda dell’elemento SOMMARIO salmente, hanno spazia- naturale che le carat- to in altissime forme di terizza: la sega idrau- LEONARDO DA VINCI – IL GENIO E LE INVENZIONI espressione nei campi lica e i galleggianti per di Mariella Galbusera pag. 1 dell’arte e della cono- camminare sull’acqua, I TOMMASI di Angelora Brunella Di Risio pag. 2 scenza: pittura, scultura, l’aliante e il paracadute, ITINER ARI D’ ARTE architettura, ingegneria, l’automa e la macchina a cura di Lidia Silanos pag. -

Mario Puccini “Van Gogh Involontario” Livorno Museo Della Città 2 Luglio - 19 Settembre 2021
Mario Puccini “Van Gogh involontario” Livorno Museo della città 2 luglio - 19 settembre 2021 ELENCO DELLE OPERE GLI ESORDI E IL MAESTRO FATTORI Giovanni Fattori, Ritratto di contadina, 1880 circa, olio su tavola, 34x31 cm, Museo Civico Giovanni Fattori Livorno Silvestro Lega, Busto di contadina, 1872-1873, olio su tavola, 40x26 cm, Gallerie degli Uffizi, Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti, Firenze Mario Puccini, Ave Maria, 1887 circa, olio su tela, 69x42 cm, Istituto Matteucci, Viareggio Plinio Nomellini, Ritratto di signora, 1885 circa, olio su tela, 33x16 cm, collezione privata Mario Puccini, La modella (La fidanzata), 1889-1890, olio su tela, 49,6x26,6 cm, collezione Fondazione Livorno Plinio Nomellini, Signora in nero, 1887, olio su tela, 43x20 cm, collezione Giuliano Novelli Mario Puccini, Ritratto della fidanzata all’uscita dalla chiesa, olio su tela, 31x21 cm, collezione Rangoni Mario Puccini, Lupo di mare, olio su tela, 38,5x26,2 cm, collezione Rangoni Mario Puccini, Ritratto di giovane, 1890, olio su tela applicata a cartone, 35x25 cm, collezione Rangoni Mario Puccini, Autoritratto con colletto bianco, 1912, olio su tela, 31x21,8 cm, collezione Rangoni Mario Puccini, Interno del mio studio, olio su cartone, 44x28 cm, collezione Rangoni Mario Puccini, Autoritratto, 1914, 47x33 cm, collezione privata Mario Puccini, Autoritratto in controluce, 1914, olio su tavola, 38,5x32,8 cm, collezione privata, courtesy Società di Belle Arti, Viareggio Giovanni Fattori, Nel porto, 1890-1895, olio su tavola, 19x32 cm, Museo Civico Giovanni -

Egli È Di Quelli Che Vissero Di Pensiero
numero 4 anno II | Ottobre 2019 nRivista semestrale del Caffè Michelangoiolo -Firenze i ISSN 2611-4089 Egli è di quelli che vissero di pensiero Noi Caffè Michelangiolo indice n.4 anno II Ottobre 2019 Rivista semestrale in copertina | Foto di Silvestro Lega (nd) - Silvestro Lega, “ L’adolescente” (nd) Pubblicata per conto di: Accademia degli Incamminati Via dei Frati, 19 | Modigliana (FC) Lucrezia Caliani pag. 06 www.accademiaincamminati.it “Mi fermo a Firenze” Associazione Culturale Caffè Michelangiolo Chiara Lotti pag. 08 Via degli Artigiani 45, 50041, Calenzano (Firenze) Le ramificazioni dell’arte www.caffemichelangiolo.it Massimo Innocenti pag. 10 Direttore responsabile: Il sole basso e... Andrea Del Carria Segretario di redazione: Erika Vita pag. 14 Maria Grazia Fantini La poetica del vero Redazione: Chiara Lotti Francesca Bertini pag. 18 Le bambine che fanno le signore Per la stesura della bibliografia: Lorenzo Tofi Maria Emirena Tozzi pag. 22 Silvestro Lega e le amicizie fiorentine Ufficio stampa: Giulia Bertelli Stefania Balocco pag. 24 Costanza Peruzzi Dello sguardo nel tempo. Occhi che sentono Redazione: Associazione Culturale Caffè Michelangiolo, Via degli Artigiani 45, 50041, Calenzano (Firenze) fuoripagina [email protected] Edizione: Associazione Culturale Caffè Michelangiolo, Andrea Del Carria pag. 28 Accademia degli Incamminati di Modigliana La frontiera Progetto grafico e impaginazione: Valentina Ciardelli pag. 30 Alessandro Innocenti - [email protected] Le Lamentazioni della famiglia Puccini Stampa: Leonardo -

MARIO PUCCINI Con Il Patrocinio Di La Passione Del Colore Da Fattori Al Novecento
Mostra realizzata da MARIO PUCCINI Con il patrocinio di La passione del colore da Fattori al Novecento SERAVEZZA PALAZZO MEDICEO Con il contributo finanziario di PATRIMONIO MONDIALE UNESCO since 1821 11 luglio · 2 novembre 2015 Mostra a cura di Nadia Marchioni e Elisabetta Matteucci Palminteri 12 luglio · 6 settembre dal lunedì al venerdì 17 - 24 | sabato e domenica 10.30 - 12.30 e 17 - 24 Ufficio stampa Catalogo ILOGO, Prato Maschietto Editore 7 settembre · 2 novembre www.ilogo.it www.maschiettoeditore.com dal giovedì al sabato 15 - 20 | domenica 10.30 - 20 Ingresso intero 6.00 euro · ridotto 4.00 euro PONTE STAZZEMESE Biglietto famiglia: 12 euro (2 adulti con ragazzi fino a 14 anni) SERAVEZZA STRADA PROVINCIALE 9 STAZZEMA Ultimo ingresso 30 minuti prima dell’orario di chiusura. PALAZZO MEDICEO VIA SERAVEZZA Fondazione Terre Medicee STRADA PROVINCIALE 42 MARIO PUCCINI Palazzo Mediceo di Seravezza - Patrimonio Mondiale Unesco Viale L. Amadei, 230 (già Via del Palazzo) 55047 Seravezza LU VIA ALPI APUANE La passione del colore tel. 0584 757443 · [email protected] · www.palazzomediceo.it STRADA PROVINCIALE 8 Treno. Fermata di Forte dei Marmi · FORTE VIA AURELIA DEI MARMI Seravezza · Querceta da Fattori al Novecento Ufficio Informazioni Turistiche tel. 0584 757325 Collegamento con autobus di linea. [email protected] · www.prolocoseravezza.it Da Querceta per Seravezza: ogni ora PIETRASANTA VIA G.B. VICO A12 USCITA VERSILIA a partire dalle 6:55. Ultima corsa a 20:55 Visite guidate per singoli o gruppi: tutti i giovedì 21.00-22.30. Su prenotazione. (fermata Piazza Alessandrini, di fronte SERAVEZZA Disponibili su prenotazione anche in giorni diversi durante l’orario di apertura alla stazione ferroviaria). -
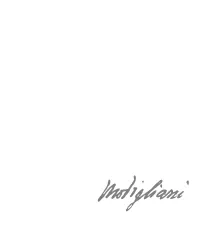
Modigliani-Cat-Prague.Pdf
Carlo Cambi Editore Editorial Project Carlo Cambi Editore Editorial Department Valentina Sardelli Art Director Laura De Biasio Graphic layout and printing Tap Grafi che - Poggibonsi (SI) Translation StudioLingue2000 - Molfett a (Italy) Robin Cassling - Prague (Czech Republic) Cover Amedeo Modigliani, Carnet Armenien with preliminary sketches “promemoria” for oil painting, depicting a man, woman, Symbol of Cabala, Paris Reproduction and diff usion of this book or any part of it by electronic storage, hardcopies, or any other means, are not al- lowed unless a writt en consent is obtained from publisher and copyright holders. © Giacomo Balla by SIAE 2011 © Max Jacob by SIAE 2011 © František Kupka by SIAE 2011 © Marevna by SIAE 2011 © Chana Orloff by SIAE 2011 © Succession Picasso by SIAE 2011 © Carlo Cambi Editore 2011 www.carlocambieditore.it ISBN: 978-88-6403-084-5 Carlo Cambi Editore Ondřej Pecha Bývalý radní pro kulturu hlavního města Prahy a současný předseda Výboru pro kulturu ZHMP Former Culture Councillor of the City of Prague and currently Chair of the Committee for Culture of Prague City Council Mgr. Tomáš Vacek Generální ředitel akciové společnosti Obecní dům General Director of the Municipal House a.s. Fabio Pigliapoco Jeho Excelence italský velvyslanec v České Republice H. E. Italian Ambassador to the Czech Republic Jaakov Levy Jeho Excelence Izraelský ambasador H. E. Israeli Ambassador to the Czech Republic Ondřej Pecha Magistrát hlavního města Prahy se dlouhodobě snaží o vytvoření vysokého Mgr. Tomáš Vacek Národní kulturní památka Obecní dům patří k nejvýznamnějším secesním stavbám bývalý radní pro kulturu hlavního standardu kulturní nabídky v našem hlavním městě, a proto podporuje generální ředitel akciové společnosti v Praze. -

Visita Alla Casa Natale Di Modigliani
Visita alla Casa natale di Modigliani Sabato 12 aprile, alle ore 17, è in programma una visita guidata alla Casa natale di Amedeo Modigliani in Via Roma, 38 a Livorno. La famosa casa di via Roma, che per una serie di circostanze fortuite non è stata modificata, conserva an- cora tutto il fascino vintage di un appartamento della borghesia livornese all’indomani dell’Unità d’Italia, con i suoi pavi- menti in graniglia a motivi floreali, i suoi vetri sottili, la vecchia cucina con il lavello in marmo bianco e le dispense in mu- ratura. Questa è la casa dove è nato Dedo, ormai 130 anni fa, e dove ha iniziato i primi esperimenti artistici. E’ allestita come un museo con riproduzioni di vecchie foto e documenti della famiglia Modigliani, che ci aiutano a ricostruire la vita del pittore, dalla nascita “assistita da un ufficiale giudiziario” ai suoi legami con la città, la vita parigina, gli amori, gli amici, e la morte tragica a soli 36 anni. A Livorno Amedeo frequenta il Ginnasio Guerrazzi, in via Ernesto Rossi, a pochi passi da casa, ma in seguito a problemi di salute abbandona gli studi classici per andare a scuola da Guglielmo Micheli, dove conoscerà tantissimi ragazzi che presto diverran- no i suoi amici più cari: Gino Romiti, Oscar Ghiglia, Aristide Sommati, Benvenuto Benvenuti, Renato Natali, Llewelyn Lloyd, Manlio Martinelli, Lando Bartoli. Sabato 12 aprile sarà, quindi, l’occasione per trascorrere un bel pomeriggio di primavera a contatto con l’arte e la storia di Livorno, ma soprattutto per respirare il fascino di un ambi- ente ricco di emozioni, e ripercorrere la vita del livornese più amato e più famoso al mondo: Amedeo Modigliani. -

Llewelyn Lloyd
IL “POETA” DELL’ELBA (LIVORNO, 1879 – FIRENZE, 1949) LLEWELYN LLOYD WRITER: PATRIZIA LUPI | IMAGES: CATALOGO MOSTRA “LLOYD. PAESAGGI TOSCANI DEL NOVECENTO’, FIRENZE, PALAZZO BARDINI BARCHE AL MOLO DI MARCIANA MARINA - OLIO SU TELA - 1926 114 Marciana Marina comprò una e bought a small house in Mar- n Marciana Marina kaufte er ein casetta, la chiamava “Il Paradi- ciana Marina, he called it “Il kleines Haus und nannte es “Il Pa- A so”. Piena di luce. A pochi passi H Paradiso”. Full of light. A few I radiso”. Es war voller Licht und nur dal mare, là dove le vigne sembravano tuf- steps from the sea, where the vineyards ein paar Schritte vom Meer entfernt, wo farsi nell’acqua cristallina. Vi trascorreva seemed to dive into the crystal-clear wa- die Weinberge in das kristallklare Wasser immancabilmente l’estate. I melograni, le ter. The summer invariably passed throu- einzutauchen schienen. Er verbrachte aiuole di gerani rossi, la bouganvillea, in- NO P[ 7VTLNYHUH[LZ ÅV^LYILKZ VM YLK jeden Sommer dort. Granatäpfel, Blu- corniciavano scene domestiche, gli amici geraniums, bougainvillea, framed dome- mentöpfe mit roten Geranien und Bou- in visita, il pittore all’opera. Gli facevano stic scenes, visiting friends, the painter at gainvillea rahmten den Alltag, der vom compagnia echi lontani, il frangere sulla work. Distant echoes kept him company, Besuch von Freunden geprägt war und passeggiata delle onde nelle giornate di the breaking of the waves on the mistral vom Werken des Malers. Echos die von THLZ[YHSLSL]VJPKLPIHTIPUPJOLZP[\ăH- days, the voices of the children diving weit her drangen leisteten ihm Gesel- vano dal molo, le mazzuole dei calafati, i from the pier, the mallets of the caulkers, lschaft. -

9-10 Ottobre 2017 FIRENZE
GONNELLI CASA D’ASTE FIRENZE GONNELLI CASA D’ASTE 9-10 Ottobre 2017 9-10 Ottobre ASTA 23 ASTA ASTA 23 LIBRI E GRAFICA PARTE I: Stampe, Disegni, Dipinti Via Ricasoli, 6-14/r | 50122 FIRENZE CASA D’ASTE tel +39 055 268279 fax +39 055 2396812 | www.gonnelli.it - [email protected] 9-10 Ottobre 2017 Gonnelli Casa d’Aste è un marchio registrato da Libreria Antiquaria Gonnelli FIRENZE GONNELLI Charta 153.qxp_[Gonnelli 195x280] 27/07/17 14:04 Pagina 1 GONNELLI CASA D’ASTE Via Ricasoli, 6-14/r | 50122 FIRENZE tel +39 055 268279 fax +39 055 2396812 www.gonnelli.it - [email protected] LEGENDA Ove non diversamente specificato tutti i testi (2): il numero fra parentesi dopo la descrizione del lotto indica la e le immagini appartengono a Gonnelli Casa quantità fisica dei beni che lo compongono. Ove non indicato si d’Aste, senza alcuna limitazione di tempo e di intende che il lotto è composto da un singolo bene. confini. Pertanto essi non possono essere ripro- dotti in alcun modo senza autorizzazione scritta Annibale Carracci: è nostra opinione che l’opera sia eseguita di Gonnelli Casa d’Aste. dall’Artista; Annibale Carracci [attribuito a]: è nostra opinione che l’opera sia probabilmente eseguita dall’Artista; Annibale Carracci In copertina particolare del lotto 967 [alla maniera di] [scuola di] [cerchia di]: l’opera per materiali, stile- mi, periodo e soggetti è accostabile alla scuola dell’Autore indicato; Annibale Carracci [da]: indica che l’opera è tratta da un originale riconosciuto dell’Autore indicato, ma eseguita da Autore diverso anche, eventualmente, in periodo diverso. -

Iconografia Della Toscana: Viaggio Per Immagini
piano paesaggistico logo REGIONE TOSCANA iconografia della toscana: viaggio per immagini 3 2 Introduzione di Ambrogio Lorenzetti all’interno del Palazzo Pubblico di sedimentazione di un’idea, magari nuova, di bellezza. Se Siena (Gli effetti del Buon Governo/Gli effetti del Cattivo non ci fosse stato, infatti, l’investimento dei macchiaioli a Governo, 1338-40, Siena, Palazzo Pubblico). In esso, trova lavorare per una vita intera sulla costa e sulla maremma, L’invenzione del paesaggio toscano - quello che espressione figurata la politica agraria comunale, tutta dovuto a particolari e anche complesse congiunture di occhieggia in ogni forma di pubblicità, dalle cartoline tesa all’autosufficienza e incentrata sullo stretto rapporto poetica, sensibilità, urgenze private e sovranazionali, digitalmente modificate alle home page dei siti turistici tra città murata e contado: i colli prossimi all’abitato sono Castiglioncello non sarebbe quel luogo mitico che ancora ai set cinematografici anche nostrani - è un fenomeno ben ricoperti da vigneti, nel fondovalle si coltivano i cereali oggi gli si riconosce di essere. O ancora, se lo sguardo sul studiato: si fonda sull’astrazione dei paesaggi regionali (semina, trebbiatura e battitura con correggiati, trasporto paesaggio non si fosse sganciato dai parametri materiali dalla complessità reale e sulla loro riduzione al modello del raccolto tramite teoria di muli), mentre verso i monti per assumere neoromantiche ed esistenziali valenze, le unico del paesaggio (eccezionale) dei dintorni di Firenze. restano indomiti boschi, dirupi e sterpaglie. Il paesaggio spoglie Crete “senza dolcezza d’alberi” (Mario Luzi) non Lentamente diventando fuori moda, il paesaggio dei promosso è sintetica resa di più lavori stagionali (l’aratura sarebbero oggi quel luogo superbo immancabile persino nei dintorni di Firenze da una decina d’anni lascia la palma e la semina sono illustrati contemporaneamente alla calendari da chiosco. -
Guida Alla Visita
GUIDA ALLA VISITA PINACOTECA il DIVISIONISMO © Fondazione CR Tortona Edo Edizioni Oltrepò Voghera Stampa Tipografia Pime - Pavia Febbraio 2019 Il Divisionismo è nato nell’ultimo decennio dell’Otto- cento dalle istanze innovative della tecnica pittorica introdotte da artisti come Giovanni Segantini, Gae- tano Previati, Angelo Morbelli, Giuseppe Pellizza da Volpedo, Emilio Longoni, Plinio Nomellini, sostenuti dalle posizioni critiche di Vittore Grubicy de Dragon. L’uso del colore diviso giunge a corollario di altre esperienze pittoriche di trasformazione dei principi INTRODUZIONE accademici vigenti nell’arte dell’Ottocento e prelude agli sviluppi in senso moderno che le correnti del pri- mo Novecento, fino al Futurismo, hanno progressi- vamente messo in atto. La collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona costituisce l’unico progetto museale inte- ramente dedicato al Divisionismo, che viene preso in esame attraverso opere selezionate tra quelle che hanno contribuito alle vicende artistiche del periodo o hanno avuto un ruolo nella storia del movimento, in relazione alla molteplicità delle sue componenti, a partire dalle premesse riconoscibili nelle tendenze più avanzate della seconda metà dell’Ottocento, per seguirne gli sviluppi attraverso i temi e i protagonisti, e considerare quindi la sua continuità nei primi de- cenni del Novecento. Centrale è la figura di Giuseppe Pellizza da Volpe- do, che ha compiuto la sua parabola di vita in uno stretto rapporto con il territorio in cui la sua arte è maturata. Il nucleo delle sue opere è il maggiore per estensione in una collezione di destinazione pubbli- ca. Accanto a lui, un altro “tortonese”, Angelo Bara- bino, è ben rappresentato in un percorso che vuole riflettere le ragioni e i caratteri di una raccolta unica nel suo genere. -

19TH CENTURY EUROPEAN VICTORIAN and BRITISH IMPRESSIONIST ART Wednesday 14 March 2018
19TH CENTURY EUROPEAN VICTORIAN AND BRITISH IMPRESSIONIST ART Wednesday 14 March 2018 19TH CENTURY EUROPEAN, VICTORIAN AND BRITISH IMPRESSIONIST ART Wednesday 14 March at 2.00pm New Bond Street, London VIEWING BIDS ENQUIRIES PHYSICAL CONDITION OF Friday 9 March +44 (0) 20 7447 7447 Peter Rees (Head of Sale) LOTS IN THIS AUCTION 2pm to 5pm +44 (0) 20 7447 7401 fax +44 (0) 20 7468 8201 Saturday 10 March To bid via the internet please [email protected] PLEASE NOTE THAT THERE IS 11am to 3pm visit bonhams.com NO REFERENCE IN THIS Sunday 11 March Charles O’Brien CATALOGUE TO THE PHYSICAL 11am to 3pm Please note that bids should be (Head of Department) CONDITION OF ANY LOT. Monday 12 March submitted no later than 4pm on +44 (0) 20 7468 8360 INTENDING BIDDERS MUST 9am to 4.30pm the day prior to the sale. New [email protected] SATISFY THEMSELVES AS TO Tuesday 13 March bidders must also provide proof THE CONDITION OF ANY LOT 9am to 4.30pm of identity when submitting bids. Emma Gordon AS SPECIFIED IN CLAUSE 14 Wednesday 14 March Failure to do this may result in +44 (0) 20 7468 8232 OF THE NOTICE TO BIDDERS 9am to 12pm your bid not being processed. [email protected] CONTAINED AT THE END OF THIS CATALOGUE. SALE NUMBER TELEPHONE BIDDING Alistair Laird 24741 Bidding by telephone will only +44 (0) 20 7468 8211 As a courtesy to intending be accepted on a lot with a [email protected] bidders, Bonhams will provide a CATALOGUE lower estimate of or in written Indication of the physical £25.00 excess of £1,000 Deborah Cliffe condition of lots in this sale if a +44 (0) 20 7468 8337 request is received up to 24 ILLUSTRATIONS Live online bidding is available [email protected] hours before the auction starts.