Adolf M. Hakkert Editore 27.2009
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

CHRIST CHURCH LIBRARY NEWSLETTER Volume 7, Issue 3 Trinity 2011
CHRIST CHURCH LIBRARY NEWSLETTER Volume 7, Issue 3 Trinity 2011 ISSN 1756-6797 (Print), ISSN 1756-6800 (Online) The Aeschylus of Richard Porson CATALOGUING ‘Z’ - EARLY PRINTED PAMPHLETS Among the treasures of the library of Christ Church is It is often asserted that an individual is that which an edition of the seven preserved plays of they eat. Whether or not this is true in a literal sense, Aeschylus, the earliest of the great Athenian writers the diet to which one adheres has certain, of tragedy. This folio volume, published in Glasgow, predictable effects on one’s physiology. As a result, 1795, by the Foulis (‘fowls’) Press, a distinguished the food we consume can affect our day to day life in publisher of classical and other works, contains the respect to our energy levels, our size, our Greek text of the plays, presented in the most demeanour, and our overall health. And, also as a uncompromising manner. I propose first to describe result, this affects how we address the world, it this extraordinary volume and then to look at its affects our outlook on life and how we interact with place in the history of classical scholarship. The book others. This is all circling back around so that I can contains a title page in classical Greek, an ancient ask the question: are we also that which we read? To life of Aeschylus in Greek, and ‘hypotheses’ or an extent, a person in their early years likely does summaries of the plays, some in Greek and some in not have the monetary or intellectual freedom to Latin. -

CHRIST CHURCH LIBRARY NEWSLETTER Volume 12, Issue 1 2020 - 2021
CHRIST CHURCH LIBRARY NEWSLETTER Volume 12, Issue 1 2020 - 2021 ISSN 1756-6797 (Print), ISSN 1756-6800 (Online) The Salusbury Manuscripts: Notes on Provenance A Scarlatti Operatic Masterpiece Revisited MS 183 and MS 184 are two manuscripts which Among the many rare and precious holdings of belonged to the Salusbury family. They contain Christ Church Library, Oxford, is a manuscript of heraldry, and poems in Welsh and English, dating unusual importance in the history of music: Mus 989. from the turn of the sixteenth to the seventeenth It preserves a complete musical setting by composer century. Christ Church has no particular Welsh Alessandro Scarlatti of the text of poet Matteo Noris’ associations to explain why it should have been drama Il Flavio Cuniberto. given two manuscripts largely in the Welsh language. By many musicologists’ reckoning, Scarlatti was the The Salusbury family of Denbighshire is celebrated most important Italian opera composer of his time, in both codices. Members of that family were and a complete score of one of his operas is students at Oxford’s Jesus College and one at therefore a document of uncommon significance. Braesnose, in the sixteenth and seventeenth And although perhaps less well-known, Matteo Noris centuries. The two volumes arrived in Christ Church was a librettist of considerable importance. in the mid-eighteenth century but their donor is Historians of opera depend upon various kinds of unrecorded and it may be that the Library did not primary sources to write the performance history of quite know what to make of them. particular works in the repertory. -

The Foulis Exhibition
Downloaded from THE FOULIS EXHIBITION. (HOUGH constituted so recently as 21 st February, 1912, the Glasgow http://library.oxfordjournals.org/ 1 Bibliographical Society found itself (strong enough before the end of that year to organise an exhibition illustra- tive of the life and work of the brothers Foulis, the venture being suggested by the fa<5l that 23rd November, 1912, was the bicentenary of the birth of Andrew, the junior member of the firm. The exhibition was intended as the Society's at University of California, San Fransisco on March 16, 2015 tribute to two eminent sons of Glasgow who have been strangely neglected, and was made the occasion of an attempt to bring together material, manu- script and printed, that would ultimately be used in compiling an adequate biography of the brothers and a complete bibliography or their press. The authorities of the University of Glasgow readily granted the necessary accommodation, and on 12th April, before a Large gathering, the exhibi- tion was opened with an address on the Foulises by the President of the Society, Mr. David Murray, LL.D.1 That the exhibition should have been held in the University was appropriate on various grounds. 1 The address, illustrated and much extended, has been issued in Yolume form by Messrs. James MacLehose & Sons, Glasgow. THE FOULIS EXHIBITION. 307 The brothers, when young men, were more or less regular students in its classes. Robert began business as a bookseller in 1739, probably in the premises ' within the College' from which, two years later, he published a book having that address Downloaded from in the imprint. -

University of Florida Thesis Or Dissertation Formatting
SMATHERS LIBRARIES’ LATIN AND GREEK RARE BOOKS COLLECTION UNIVERSITY OF FLORIDA 2016 1 TABLE OF CONTENTS page LECTORI: TO THE READER ........................................................................................ 20 LATIN AUTHORS.......................................................................................................... 24 Ammianus ............................................................................................................... 24 Title: Rerum gestarum quae extant, libri XIV-XXXI. What exists of the Histories, books 14-31. ................................................................................. 24 Apuleius .................................................................................................................. 24 Title: Opera. Works. ......................................................................................... 24 Title: L. Apuleii Madaurensis Opera omnia quae exstant. All works of L. Apuleius of Madaurus which are extant. ....................................................... 25 See also PA6207 .A2 1825a ............................................................................ 26 Augustine ................................................................................................................ 26 Title: De Civitate Dei Libri XXII. 22 Books about the City of God. ..................... 26 Title: Commentarii in Omnes Divi Pauli Epistolas. Commentary on All the Letters of Saint Paul. .................................................................................... -

Contribution a L'histoire Intellectuelle De L'europe : Réseaux Du Livre
CONTRIBUTION A L’HISTOIRE INTELLECTUELLE DE L’EUROPE : RÉSEAUX DU LIVRE, RÉSEAUX DES LECTEURS Edité par Frédéric Barbier, István Monok L’Europe en réseaux Contribution à l’histoire de la culture écrite 1650–1918 Vernetztes Europa Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens 1650–1918 Edité par / Herausgegeben von Frédéric Barbier, Marie-Elisabeth Ducreux, Matthias Middell, István Monok, Éva Ring, Martin Svatoš Volume IV Ecole pratique des hautes études, Paris Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris Centre des hautes études, Leipzig Centre européen d’histoire du livre de la Bibliothèque nationale Széchényi, Budapest CONTRIBUTION A L’HISTOIRE INTELLECTUELLE DE L’EUROPE : RÉSEAUX DU LIVRE, RÉSEAUX DES LECTEURS Edité par Frédéric Barbier, István Monok Országos Széchényi Könyvtár Budapest 2008 Les articles du présent volume correspondent aux Actes du colloque international organisé à Leipzig (Université de Leipzig, Zentrum für höhere Studien) en 2005, sur le thème « Netzwerke des Buchwesens : die Konstruktion Europas vom 15. bis zum 20. Jh. / Réseaux du livre, réseaux des lecteurs : la construction de l’Europe, XVe-XXe siècle ». Secrétariat scientifique Juliette Guilbaud (français) Wolfram Seidler (allemand) Graphiker György Fábián ISBN 978–963–200–550–8 ISBN 978–3–86583–269–6 © Országos Széchényi Könyvtár 1827 Budapest, Budavári palota F. épület Fax.: +36 1 37 56 167 [email protected] Leipziger Universitätsverlag GmbH, Leipzig Oststr. 41, D–04317 Leipzig Fax.: +49 341 99 00 440 [email protected] Table des matières Frédéric Barbier Avant-propos 7 Donatella Nebbiai Les réseaux de Matthias Corvin 17 Pierre Aquilon Précieux exemplaires Les éditions collectives des œuvres de Jean Gerson, 1483-1494 29 Juliette Guilbaud Das jansenistische Europa und das Buch im 17. -

CHRIST CHURCH LIBRARY NEWSLETTER Volume 4, Issue 2 Hilary 2008
CHRIST CHURCH LIBRARY NEWSLETTER Volume 4, Issue 2 Hilary 2008 ISSN 1756-6797 (Print), ISSN 1756-6800 (Online) HEARING MORLEY’S PUZZLES Dating Wolsey’s Lectionaries The beautiful 1608 edition of Thomas Morley’s A Among the most stunningly beautiful volumes Plaine and Easie Introduction to Practicall Musicke housed at Christ Church is the Epistle Lectionary, a was a striking part of the Michaelmas term exhibit at 16th century manuscript richly illuminated in the the Christ Church Library. Indeed, “Sacred Music” Flemish style. This large folio still sparkles brightly in and “Hidden Treasures” made it well worth a hunt all the colours of the rainbow and is - literally - heavy through Morley’s treatise. The cruciform puzzle with gold. The book contains readings from the canon from Part III of the treatise is the sort of visual Epistles for a number of feast days throughout the stimulus to attract both the musician and non- year. Another Lectionary, containing the texts from musician alike; likewise the scholar and the casual the Gospels, illuminated in precisely the same observer. manner and including the same selection of feast days, is now at Magdalen College in Oxford. Morley’s treatise, first published in 1597 and then re- issued in 1608 (of which edition the Christ Church About the provenance of the Epistle Lectionary at copy is one), became a leading theoretical work in Christ Church, there is only a brief entry in the Renaissance England and for many decades Donors’ Book. This simply records that the following. In the treatise, Morley lays out his material manuscript was given by John Lante, in 1614, along as a pleasant dialogue between a Master and two with three printed medical books: “Magister Ioannes eager students. -

Rare & Fine Books
RaRe & Fine Books including Recent Acquisitions Rulon-Miller Books Saint Paul, MN Winter 2017 Rulon-Miller Books 400 Summit Avenue Saint Paul, MN 55102-2662 USA *** Catalogue 154 Rare & Fine Books Including Recent Acquisitions To order call toll-free (800) 441-0076 Outside the U.S. please call 1 (651) 290-0700 Email: [email protected] Web: rulon.com All major credit cards accepted We will gladly supply pictures for any item TERMS • All books are guaranteed genuine as described, and are returnable for any reason during the first week after receipt. Please notify us as soon as possible if an item is being returned, so that we might make it available to another customer. • Prices are net, plus sales taxes where applicable. Shipping charges are extra and are billed at cost. • Foreign accounts should make payments in US dollars by wire, credit card, or postal money order, or with a check in US dollars drawn on a US bank. Bank charges may apply. Note to our Readers While the NUC (National Union Catalogue) counts in our catalogue descriptions remain accurate, as well as those from other hard-copy sources, OCLC (Online Computer Library Center) counts, and those from other online databases, may not be. While we have taken the time to check items in this catalogue where online counts are cited, and assume them to be correct, we also recognize that searches using different qualifiers will often turn up different results, and most all should probably be taken as measure of approximation. Cover Image: Item #396 Back Cover Image: Item: #62 Catalogue 154 1 Preface This catalogue is dedicated to the memory of Bob Fleck, words in a different context, and saw images through first and foremost my trusted friend and colleague, and a different lens. -

The Scottish Historical Review
The Scottish Historical Review VOL. XIV., No. 54 JANUARY 1917 Some Letters of Robert Foulis noble array of books issued from the press of Robert THEFoulis, and of his firm of R. and A. Foulis, is a worthy memorial of his skill and taste as a printer, of his eager desire to promote learning and to diffuse a taste for literature. We have, however, comparatively little information regarding himself and the incidents of his life, and anything which supplements this information is welcome. The following letters tell something of his story, and will be read with interest. The first four are in the of G. Burnett of the possession Mr. J. Powis House, Aberdeen ; other two are in my own possession. The earliest letter is addressed to Lord Aberdour, 1732-74, afterwards (1768) fourteenth Earl of Morton, who was a student at the University of Leyden, under the charge of Mr. John Leslie, 1727-90, subsequently professor of Greek in King's College, Aberdeen, of whom Mr. Burnett gave a sympathetic account in this Review (S.H.R. xiii. 30). Lord Aberdour had been a student at the University of Glasgow during the years 1748 and 1749. The Messrs. Foulis, it will be remembered, were booksellers as well as printers and publishers, and their bookshop was a pleasant lounge, in which professors and students were accustomed to meet, dally with the books, talk over the topics of the day, and discuss questions of philosophy with the printer, criticise his most recent publications, and canvass his pro- posals for the future. -

Cultivating the Classics “In a Cold Climate”: the Foulis Press & Academy in Glasgow
Lamont, C. (2018) Cultivating the classics “in a cold climate”: the Foulis Press & Academy in Glasgow. Journal of the Edinburgh Bibliographical Society, 13, pp. 45-66. There may be differences between this version and the published version. You are advised to consult the publisher’s version if you wish to cite from it. http://eprints.gla.ac.uk/167329/ Deposited on 20 August 2018 Enlighten – Research publications by members of the University of Glasgow http://eprints.gla.ac.uk Cultivating the classics “in a cold climate”: the Foulis Press & Academy in Glasgow Craig Lamont Robert (1707-1776) and Andrew Foulis (1712-1775) rose to prominence in Glasgow as booksellers and publishers under the mentorship of Francis Hutcheson (1694-1746), the so-called ‘Father of the Scottish Enlightenment.’1 Despite no major study of the brothers since David Murray’s Robert and Andrew Foulis and the Glasgow Press (1913), recent scholarship has identified their role in the production of classical texts during the Scottish Enlightenment.2 Following Philip Gaskell’s comprehensive Bibliography of the Foulis Press (1986), art historian George Fairfull-Smith has been the most active researcher of the Foulis brothers: organising an exhibition on the Foulis Press and Academy in 2001; publishing a companion text; and, more recently, tracing the Academy’s impact on the fine arts in Glasgow in The Wealth of a City, v. 1 (2010). Yet problems remain with our understanding of the brothers. This is mostly due to the commonplace narrative of their rise and fall as printers: talented in the art of publishing but distracted by an overambitious scheme of becoming connoisseurs of the fine arts in a city with no appetite for it.3 The persistence of this story had led to the scholarly focus on the Foulis press 1 This epithet has been given to Hutcheson by many, as early as 1900 in William Robert Scott’s Francis Hutcheson: His Life, Teaching and Position in the History of Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 1900), p. -

Philobiblon Transilvan
JAKÓ ZSIGMOND PHILOBIBLON TRANSILVAN Traducerea: LIVIA BACÂRU Studiile Începuturile tipografiei de la Blaj şi Istoricul bibliotecii lui Timotei Cipariu au fost traduse de Kiss András Indice de nume: Luminiţa Stoichiţescu BIBLIOTECA KRITERION apare sub îngrijirea lui Domokos Géza JAKÓ ZSIGMOND PHILOBIBLON TRANSILVAN Cu o introducere de prof. dr. VIRGIL CÂNDEA EDITURA KRITERION Bucureşti, 1977 Coperta de VASILE SOCOLIUC INTRODUCERE Volumul de faţă cuprinde cele mai însemnate contri- buţii la cunoaşterea istoriei cărţii, tiparului şi biblioteci- lor maghiare din Transilvania publicate vreodată în limba româna. Ele sînt datorate unui cărturar care s-a devotat de mulţi ani, cu aceeaşi pasiune şi competenţă istoriei culturii, bibliologiei, codicologiei. Privilegiu rar în cîmpul ştiinţelor umane, Jakó Zsigmond întruneşte toate calităţile de erudiţie şi metodă capabile să-i în- găduie, cu autoritate, cercetarea domeniului atît de exi- gent al evoluţiei ideilor descifrată în documente, în manuscrise sau tipărituri vechi. Specialiştii şi în general iubitorii de cultură români, cărora li se adresează deopotrivă această carte, vor afla în toate paginile ei, şi mai cu seamă în studiul sintetic din încheiere, o amplă evocare a contribuţiei pe care cărturarii maghiari din Transilvania au adus-o la crea- ţia culturală prin scris şi tipar din ţara noastră, la răs- pândirea învăţăturii şi a ideilor prin cărţi şi biblioteci. Vechi scriptorii din mănăstirile catolice ardelene care au cultivat la noi, odată cu limba şi literele latine, stu- diul patristicei -
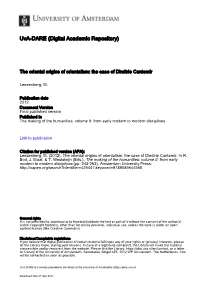
The Case of Dimitrie Cantemir
UvA-DARE (Digital Academic Repository) The oriental origins of orientalism: the case of Dimitrie Cantemir Leezenberg, M. Publication date 2012 Document Version Final published version Published in The making of the humanities: volume II: from early modern to modern disciplines Link to publication Citation for published version (APA): Leezenberg, M. (2012). The oriental origins of orientalism: the case of Dimitrie Cantemir. In R. Bod, J. Maat, & T. Weststeijn (Eds.), The making of the humanities: volume II: from early modern to modern disciplines (pp. 243-263). Amsterdam University Press. http://oapen.org/search?identifier=429447;keyword=9789089644558 General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl) Download date:25 Sep 2021 Th e Making of the Humanities Volume 11: From Early Modern to Modern Disciplines Edited by Rens Bod, Jaap Maat and Th ijs Weststeijn This book was made possible by the generous support of the J.E. -

The MAKING of the HUMANITIES
RENS BOD, JAAP MAAT & THIJS WESTSTEIJN (eds.) The MAKING of the HUMANITIES volume 11 From Early Modern to Modern Disciplines amsterdam university press the making of the humanities – vol. ii Th e Making of the Humanities Volume 11: From Early Modern to Modern Disciplines Edited by Rens Bod, Jaap Maat and Th ijs Weststeijn This book was made possible by the generous support of the J.E. Jurriaanse Foundation, the Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Foundation, and the Netherlands Organization for Scientific Research (NWO). This book is published in print and online through the online OAPEN library (www.oapen.org) Front cover: Hendrik Goltzius, Hermes, 1611, oil on canvas, 214 x 120 cm, Frans Hals Museum, Haarlem, long-term loan of the Royal Gallery of Paintings Mauritshuis, The Hague. Back cover: Hendrik Goltzius, Minerva, 1611, oil on canvas, 214 x 120 cm, Frans Hals Museum, Haarlem, long-term loan of the Royal Gallery of Paintings Mauritshuis, The Hague. Cover design: Studio Jan de Boer, Amsterdam, the Netherlands Lay-out: V3-Services, Baarn, the Netherlands isbn 978 90 8964 455 8 e-isbn 978 90 4851 733 6 (pdf ) e-isbn 978 90 4851 734 3 (ePub) nur 685 Creative Commons License CC BY NC (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0) Rens Bod, Jaap Maat, Th ijs Weststeijn/ Amsterdam University Press, Amsterdam, 2012 Some rights reserved. Without limiting the rights under copyright reserved above, any part of this book may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, record- ing or otherwise).