Castromaiore-E-Nimfisa.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Anacapri Capri
Informaciones turisticas Informaciones turísticas Oficina de objetos perdidos Oficina de Turismo Azienda Autonoma Cura CAPRI · 081 8386203 · ANACAPRI · 081 8387220 Soggiorno e Turismo Isola di Capri CAPRI · Piazzetta Ignazio Cerio 11 Correos, telégrafos www.capritourism.com · www.infocapri.mobi CAPRI · Via Roma, 50 · 081 9785211 081 8370424 · 8375308 · Fax 081 8370918 MARINA GRANDE · Via Prov.le M. Grande, 152 [email protected] 081 8377229 ANACAPRI · Viale De Tommaso, 8 · 081 8371015 A B C D E F G Info point CAPRI · Piazza Umberto I · 081 8370686 Deposito bagagli Marina Grande-Harbour · 081 8370634 CAPRI · Via Acquaviva ANACAPRI · Via G. Orlandi 59 · 081 8371524 MARINA GRANDE · Via C. Colombo, 10 · 081 8374575 Municipio Porte Transporte bultos a mano CAPRI · Piazza Umberto I, 9 · 081.838.6111 CO.FA.CA. · Piazza Martiri d’Ungheria · 081 8370179 Grotta Azzurra Punta ANACAPRI · Via Caprile, 30 · 081 8387111 Cooperativa Portuali Capresi del Capo Via Marina Grande, 270 · 081 8370896 Medical Assistance Punta dell’Arcera Hospital “G. Capilupi” Empresas de Navegación Piazza Marinai d’Italia Grotta ANACAPRI · Via Provinciale, 2 · 081 838 1205 Aliscafi SNAV · 081 8377577 Bagni della Ricotta CAREMAR · 081 8370700 di Tiberio Villa Lysis Monte Tiberio Emergencia sanitaria ·118 335 Guardia médica nocturna y días festivos Consorzio Linee Marittime Partenopee Villa Fersen Grotta Villa Jovis CAPRI · Piazza Umberto I, 9 · 081 8375716/8381238 081 8370819/8376995 v Palazzo del Bove Marino o i Damecuta p Chiesa a a ANACAPRI · Via Caprile, 30 · 081 8381240 -

Map 44 Latium-Campania Compiled by N
Map 44 Latium-Campania Compiled by N. Purcell, 1997 Introduction The landscape of central Italy has not been intrinsically stable. The steep slopes of the mountains have been deforested–several times in many cases–with consequent erosion; frane or avalanches remove large tracts of regolith, and doubly obliterate the archaeological record. In the valley-bottoms active streams have deposited and eroded successive layers of fill, sealing and destroying the evidence of settlement in many relatively favored niches. The more extensive lowlands have also seen substantial depositions of alluvial and colluvial material; the coasts have been exposed to erosion, aggradation and occasional tectonic deformation, or–spectacularly in the Bay of Naples– alternating collapse and re-elevation (“bradyseism”) at a staggeringly rapid pace. Earthquakes everywhere have accelerated the rate of change; vulcanicity in Campania has several times transformed substantial tracts of landscape beyond recognition–and reconstruction (thus no attempt is made here to re-create the contours of any of the sometimes very different forerunners of today’s Mt. Vesuvius). To this instability must be added the effect of intensive and continuous intervention by humanity. Episodes of depopulation in the Italian peninsula have arguably been neither prolonged nor pronounced within the timespan of the map and beyond. Even so, over the centuries the settlement pattern has been more than usually mutable, which has tended to obscure or damage the archaeological record. More archaeological evidence has emerged as modern urbanization spreads; but even more has been destroyed. What is available to the historical cartographer varies in quality from area to area in surprising ways. -

Cartina Gratuita De/Fr
Bureau des objects trouvés Informations CAPRI · 081 8386203 · ANACAPRI · 081 8387220 Postes, Telegraphs Syndicat d’Initiative CAPRI · Via Roma, 50 · 081 9785211 CAPRI · Piazzetta Ignazio Cerio 11 MARINA GRANDE · Via Prov.le M. Grande, 152 www.capritourism.com · ·www.infocapri.mobi 081 8377229 081 8370424 · 8375308 · Fax 081 8370918 ANACAPRI · Viale De Tommaso, 8 · 081 8371015 [email protected] Consigne Info point CAPRI · Via Acquaviva CAPRI · Piazza Umberto I · 081 8370686 MARINA GRANDE · Via C. Colombo, 10 · 081 8374575 A B C D E F G Marina Grande-Porto · 081 8370634 Transport de colis ANACAPRI · Via G. Orlandi 59 · 081 8371524 CO.FA.CA. · Piazza Martiri d’Ungheria · 081 8370179 Mairie Cooperativa Portuali Capresi CAPRI · Piazza Umberto I, 9 · 081.838.6111 Via Marina Grande, 270 · 081 8370896 ANACAPRI · Via Caprile, 30 · 081 8387111 Societé de Navigation du Golfe Hôpital “G. Capilupi” Piazza Marinai d’Italia Grotta Azzurra Punta ANACAPRI · Via Provinciale, 2 · 081 838 1205 Aliscafi SNAV · 081 8377577 del Capo Urgence sanitaire 118 CAREMAR · 081 8370700 Poste de secours, service de nuit et jours féeriés Punta dell’Arcera Consorzio Linee Marittime Partenopee Grotta CAPRI · Piazza Umberto I, 9 · 081 8375716/8381238 081 8370819/8376995 Bagni della Ricotta ANACAPRI · Via Caprile, 30 · 081 8381240 Monte Tiberio Aliscafi Alilauro Gruson · 081 8370819/8376995 di Tiberio Villa Lysis Commissariat de Police Fersen 335 Navigazione Libera del Golfo · 081 8370819 Villa Grotta Villa Jovis Via Roma, 70 · 081 8374211 · 113 Neapolis · 081 8377577 v del Bove Marino o i Damecuta Palazzo p a Chiesa Carabiniers a Metrò del Mare · 199600700 G a Mare C S. -

0 COVER Capri 31 Capri
31 COPIA OMAGGIO • COMPLIMENTARY COPY Con il patrocinio di: Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo Isola di Capri • www.capritourism.com ADAC Federalberghi Isola di Capri www.caprialberghi.com • [email protected] Periodico di turismo, cultura, attualità Anno XVIII - N. 31 - 2011 Registrazione al Tribunale di Roma n. 83/94 dell’11.3.94 Dentro l’isola 40 Oltre il cancello > di Antonello De Nicola 43 L’officina del ferro di Mario Zora 46 Ieri & Oggi > 22 di Francesco Durante 52 Pagine di storia > di Silvia Baldassarre Natura 55 La colonna sonora di un mito > 64 Una famiglia “verde” > di Silvia Baldassarre di Tullia G. Rizzotti 58 I giorni di Capri 60 Il giardino della memoria > Il mare di Renato Esposito Starring 78 Un mondo sommerso > 22 Roberto Bolle > di Enrico Desiderio Gourmet intervista di Alessadra Felini 84 A scuola di sub 150 La dolce Capri > 28 Bianca Guaccero > di Luciano Pignataro intervista di Pier Paolo Mocci 34 Ciak si gira! > di Antonello De Nicola People 86 Sentinella del mare > di Antonello De Nicola 93 Malaparte, Napolitano, Capri e non solo > di Rossana Arzone 78 3 Rubriche 7 News 13 La mostra 17 Libri 20 Zoom 71 Flowers! 127 In vetrina 139 Souvenir 96 143 Capri Kids 156 L’isola del gusto 15 domande a... 96 Adriana Di Fiore > intervista di Rossella Funghi Shopping www.caprireview.it 162 Una nuova Passerella Editore, Direzione e Redazione PRC Srl Arte 164 Capolavori in vetro Via Germanico, 197 - 00192 Roma 132 Lello Esposito > 166 Con il Sole addosso Tel. 06.3215923 - 06.3243010 di Ludovico Pratesi 168 Righe -

I Origine Calcarea, Capri L'isola Mediterranea Che Ha Visto Nel Tempo Transitare Intellettuali, Artisti E Scrittori, Tutti
CAPRI Il Comune di Capri dà il nome all’isola che comprende i comuni di Capri e di Anacapri. L’isola azzurra è il naturale prolungamento della penisola sorrentina, le rocce chiare dei Faraglioni sembrano essersi staccate dalla Baia di Ieranto e aver preso il largo, la comune natura carsica ne è testimonianza. Capri ha ispirato scrittori, poeti e registi che l’hanno scelta come location dei loro film. Una combinazione di natura, cultura e mondanità, intorno ad un mare che va dal blu al turchese dell’animata piazzetta e dei locali circostanti che fanno di Capri una meta irrinunciabile. Caratteristici di Capri sono i celebri Faraglioni, tre piccoli isolotti rocciosi a poca distanza dalla riva che creano un effetto scenografico e paesaggistico; ad essi sono stati attribuiti anche dei nomi per distinguerli: Stella per quello attaccato alla terraferma, Faraglione di Mezzo per quello frapposto agli altri due e Faraglione di Fuori (o Scopolo) per quello più lontano dall'isola[1]. Controversa è la questione etimologica. Le due ipotesi più accreditate sono quella latina di “Capreae” (capre), per la fauna predominante costituita da capre selvatiche, e quella greca di “Kapros” (cinghiale), del quale sono rinvenuti numerosi avanzi fossili. L’isola fu anche chiamata insula Telonis dal nome di Telone che, secondo Virgilio, era re dell’isola prima che Enea venisse in Italia. Capri offre tra gli itinerari più affascinanti, quello che conduce alla scoperta delle antiche ville, in origine dodici, volute da Augusto e Tiberio, ognuna delle quali, secondo la tradizione, fu dedicata ad una divinità dell’Olimpo. È proprio agli imperatori romani, infatti, che è legata la fama dei due comuni dell’isola, Capri e di Anacapri. -
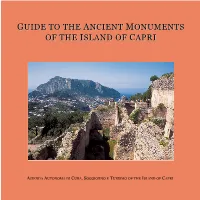
Guide to the Ancient Monuments of the Island of Capri
GGUIDEUIDE TOTO THETHE AANCIENTNCIENT MMONUMENTSONUMENTS OFOF THETHE IISLANDSLAND OFOF CCAPRIAPRI AZIENDA AUTONOMA DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO OF THE ISLAND OF CAPRI Index 2 History 6 Grotta delle Felci 7 Muro greco 7 Scala fenicia 8 Palazzo a Mare 10 Villa di Damecuta 12 Villa Jovis Villa Jovis. 15 Villa di Gradola - Grotta Azzurra 16 Grottoes and nymphaea 16 Grotta di Matermania 17 Grotta del Castiglione 17 Grotta dell’Arsenale 18 Detailed studies 19 Museums and libraries For up-to-date information on monument opening hours and itineraries, please contact Information Offices of Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo of the Island of Capri: Capri, piazza Umberto I - tel. +39 0818370686 Villa di Damecuta. Marina Grande, banchina del Porto - tel. +39 0818370634 Anacapri, via Giuseppe Orlandi - tel +39 0818371524 www.capritourism.com Guide produced by OEBALUS ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS Via San Costanzo, 8 - Capri www.oebalus.org with the collaboration of SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA Ufficio scavi Capri, via Certosa - Capri tel. +39 0818370381 Texts by EDUARDO FEDERICO (history) Grotta di Matermania. ROBERTA BELLI (archaeology) CLAUDIO GIARDINO (Grotta delle Felci) Photographs by MARCO AMITRANO UMBERTO D’ANIELLO (page 1) MIMMO JODICE (back cover) Co-ordination ELIO SICA Translations by QUADRIVIO Printed by Scala fenicia. SAMA Via Masullo I traversa, 10 - Quarto (NA) www.samacolors.com GUIDE TO THE ANCIENT MONUMENTS OF THE ISLAND OF CAPRI AZIENDA AUTONOMA DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO OF THE ISLAND OF CAPRI History Although rather poorly document- independent island history. ed by ancient authors, the history The history of Capri between the of Capri involves many characters 4th millennium BC and the 8th cen- of notable importance. -

Capri Exclusive
Capri Special maps Marina Grande EXCLUSIVEEXCLUSIVE Capri Centre MapsMaps Anacapri Centre Marina Piccola What to see - Where to stay - Where to eat - Shopping PUNTA DEL CAPO ! @#@ & Grotta Azzurra GROTTA BOTTE #$ @ BUS E TAXI L O F UNNO G RADOLA ! Villa Damecuta A RTIMO BN $ # GROTTA MARINA GRANDE VILLA FERSEN CN DELLA RICOTTA ! ELIPORTO L INARO i V d i a n GROTTA G la BL P ALAZZO A M ARE r r Villa DEL OVE ARINO o D AMECUTA O B M . SALTO DI tt San Michele BO a ( G the ^ TIBERIO A Via @ ia un Villa Jovis EM z L V % Porto Commerciale @ z a Fa . M BS u b ^ A BT Scala Fenicia % r b a V r r P. ZZA VITTORIA Vi ia a ic M BQ Porto V a & O ASI WWF CP i a a Sc r BM I L P OZZO al i Turistico ^ L O C APO G BM APODIMONTE Castello a Fenicia n BL C a r Capri in Miniatura ^ BQ* BU Chiesa CT o BP G * BR t Barbarossa ( V t S. Costanzo r ia a V IGNA Casa Rossa di Seggiovia a . C. Co n BL o n lombo Fortino A T BO a r ra rl Monte solaro d uri z v O u e uocco ai di Orrico z . V Chiesa S. Michele BN . c & n G. R . M u ign G % s Via Do a A r a ia o Vi r V Ch. S. Sofia V a i BM V p i C ESINA a a O RRICO # a a Vi S gn C . -

Guida Pratica Dell'isola & Informazioni Turistiche
GUIDA PRATICA DELL’ISOLA & INFORMAZIONI CAPRIè… TURISTICHE AZIENDA AUTONOMA CURA SOGGIORNO E TURISMO - ISOLA DI CAPRI CAPRIè... INDICE Acquedotto - servizio guasti .........pag 11 Gallerie d’arte .................................. pag 14 Agenzie immobiliari “ 15 Guardia di Finanza “ 9 Agenzie stampa “ 16 Guardia Medica “ 10 Agenzie viaggi e turismo “ 18 lnformazioni turistiche ................... pag 9 Alberghi “ 20-21 indiceInternet point “ 16 Antichità e Musei “ 35-41 Associazioni culturali, ambientali, Lavanderie .......................................pag 14 ecologiche e fondazioni “ 32-33 Librerie “ 14 Associazioni di categoria “ 33 Motocicli - Noleggio.......................pag 42 Autobus turistici “ 17 Motoscafi “ 18 Autolinee “ 17 Municipio “ 9 Azienda di Soggiorno e Turismo “ 9 Nautica - Noleggio .........................pag 41 Bagagli deposito .............................pag 11 Navigazione marittima “ 18 Banche “ 12 Bar e caffè “ 27-28 Oggetti smarriti ............................... pag 11 Barbieri “ 15 Ospedale - A.S.L. 5 “ 10 Biblioteche “ 32 Parrucchieri per signora ...............pag 15 Cambio ..............................................pag 12 Piano bar “ 42 Capitaneria di Porto “ 10 Polizia-Commissariato P.S. “ 9 Carabinieri “ 9 Polizia Municipale “ 9 Centri estetici “ 15 Porto Turistico “ 10 Chiese e cerimonie religiose “ 30 Posizione geografica dell’isola “ 6 Cimiteri “ 10 Poste-Telegrafo-Fax “ 11 Cinema “ 14 Pronto soccorso “ 10 Congressi e conferenze - Organizzazione e servizi “ 16 Ristoranti ..........................................pag -

Italy Itinerary May 2018
Italy Inerary May-June 2018 Thursday May 24th CLT-->NYK-->ROME 11:11 AM Depart 1:08 PM Arrive at JFK New York 5:45 PM Depart JFK New York Traveling Friday May 25th ROME-->NAPLES 8:20 AM Arrive in Rome 9:45 AM Depart Rome 10:40 AM Arrive in Naples; M&M pick us up at airport and take us to their apt NEEDS: Lunch & Dinner Plans Saturday May 26th NAPLES-->FLORENCE 8:25 AM Depart on Train (# 9916 Coach 5 Seats 5 & 6) to Florence 11:17 AM Arrive in Florence Lunch: OPEN PM: OPEN Dinner OPEN Lodging Airbnb - Borgo San Frediano 65 Florence, Toscana 50124 NEEDS: Lunch & Dinner Plans; rental car Sunday May 27th FLORENCE Breakfast OPEN AM Rent car & go to winerY PM OPEN Dinner Dine at CapeZZana Estate WinerY Lodging StaY at CapeZZana Estate WinerY; Via CapeZZana, 100 - 59015 Carmignano (PO) - ItalY NEEDS: Breakfast & Lunch plans Car rental Monday May 28th FLORENCE-->ROME Breakfast Buffet breakfast included at CapeZZana Estate AM Return to Florence via rental car AM-PM OPEN 4:13 PM Depart Florence on Train (8917 Coach 2 seats 5 & 6) 5:46 PM Arrive in Rome 6-7:30PM Travel via Metro Line A to Spagna stop; Check in to La Mason D'Art Spagna hotel 7:30-8PM Walk to Dinner (20 minute walk) Dinner 8PM reservaaons - I Sofa Restaurant Bar & Roof Terrace Via Giulia, 62 - 00186 Roma 9-10 PM Cab or walk back to hotel (20 minute walk) Lodging La Mason D'Art Spagna Via del Corso 112, Spagna, Rome 00187 Phone: +39 4549 3364 NEEDS: Florence mid-morning through late adernoon plan Rome metro & Bus maps Tuesday May 29th ROME Breakfast Breakfast provided at hotel 7AM Walk from hotel to Piazza di Spagna (square) 7:45AM Board Metro Line A at Spagna stop. -

Numero Sei – 2019 HAPPY HEARTS COLLECTION
Numero Sei – 2019 HAPPY HEARTS COLLECTION Roma: Boutique Chopard - Via Del Babuino, 22 www.chopard.com 002HH_480x310 WORLDWIDEEXCELLENCE ROMA STP.indd 1 31/05/19 12:21 HAPPY HEARTS COLLECTION Roma: Boutique Chopard - Via Del Babuino, 22 www.chopard.com 002HH_480x310 WORLDWIDEEXCELLENCE ROMA STP.indd 1 31/05/19 12:21 #MolteniGroup MILANO PARIS LONDONNEW YORK ATHENS BEIRUT BEIJING BRUSSELS BUDAPEST CHENGDU CHICAGO DUBAI GENEVA HELSINKI HONG KONGISTANBUL JAKARTA KIEV MADRID MANILA MEXICO CITY MIAMI MOSCOW NANJING OSAKA SEOUL SHANGHAI SINGAPORE TEHERAN TOKYO TORONTO PAUL SEATING SYSTEM— VINCENT VAN DUYSEN VICINO TABLE— FOSTER + PARTNERS D.156.3 ARMCHAIR— GIO PONTI RANDOM CARPET— PATRICIA URQUIOLA JAN COFFEE TABLES— VINCENT VAN DUYSEN ARTWORK— ALEK O. Hassler txUK_d PAU_019 ww.indd Tutte le pagine 28/06/19 11:27 #MolteniGroup MILANO PARIS LONDON NEW YORK ATHENSBEIRUT BEIJING BRUSSELS BUDAPEST CHENGDU CHICAGO DUBAI GENEVA HELSINKIHONG KONGISTANBUL JAKARTA KIEV MADRID MANILA MEXICO CITY MIAMI MOSCOW NANJING OSAKA SEOUL SHANGHAI SINGAPORE TEHERAN TOKYO TORONTO PAUL SEATING SYSTEM— VINCENT VAN DUYSEN VICINO TABLE— FOSTER + PARTNERS D.156.3 ARMCHAIR— GIO PONTI RANDOM CARPET— PATRICIA URQUIOLA JAN COFFEE TABLES— VINCENT VAN DUYSEN ARTWORK— ALEK O. Hassler txUK_d PAU_019 ww.indd Tutte le pagine 28/06/19 11:27 LIFE IS ABOUT MOMENTS baume-et-mercier.it Baumatic Automatico in-house Acciaio 40mm ROMA - Via Fulceri P. de Calboli, 5 - Tel. 06 3728288 LIFE IS ABOUT MOMENTS baume-et-mercier.it Baumatic Automatico in-house Acciaio 40mm ROMA - Via Fulceri P. de Calboli, 5 - Tel. 06 3728288 Editorial Roberto E. Wirth n un film per ragazzi, c'è una battuta In a family film there’s a line that che ben racconta il mio modo di well represents my way of looking at vedere la vita: “Non guardo mai al life: “I never look back, it distracts me Ipassato, mi distrae dal presente”. -

Villa Damecuta Innesti E Permanenze Tra Memoria E Archeologia
Villa Damecuta Innesti e permanenze tra memoria e archeologia SCUOLA DI ARCHITETTURA URBANISTICA INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI A.A. 2015/2016 RELATORE: Prof. Emilio Faroldi STUDENTI: Beatrice Canonaco Arianna Guarducci Livia Siciliano Grazie al professor Emilio Faroldi, che con amore e passione per l’architettura ci ha condotte al raggiungimento di questo risultato. ABSTARCT illa Damecuta è un complesso archeologico romano di e recinto, definisce la leggibilità del palazzo Vspettacolare bellezza sito sull’isola di Capri e costruito romano e degli innesti ricettivi e museali, tra per volere di Tiberio. La sua posizione strategica, ai il rigoglio della natura mediterranea e della piedi di Anacapri e al di sopra delle rocce che giungono maestosa pineta. L’approccio progettuale a picco sul mare alla Grotta dell’Arcera e alla Grotta concepisce la trasformazione da monumento Azzurra, permette di ammirare l’unicità del paesaggio a luogo di fruizione e percezione collettiva: la caprese. L’obiettivo del progetto è quello di valorizzare il sopravvivenza sua e delle rovine valorizzano sito oggi abbandonato: l’incuria di una natura rigogliosa l’identità del luogo sia morfologicamente sia nega la lettura dell’impianto delle sostruzioni. L’assenza metaforicamente. di un supporto museale, amministrativo e ricettivo incide negativamente sulla gestione del luogo: da tale assenza nasce il progetto, con la volontà di restituire una fruizione contemporanea alla Villa. Innesti e permanenze costituiscono elementi integrati e uniti da un "nastro’’ che porta ad osservare la Villa da punto di vista privilegiato. Declinandosi in percorso INDICE INTRODUZIONE p. 8 2.INTERGRAZIONE DELLE LACUNE SENZA p. 41 MIMETISMI PARTE I. CAPRI, UN PATRIMONIO DI TESORI p.10 2.1. -

8. Bay of Naples & the Amalfi Coast
228 OPEN ROAD'S BEST OF ITALY 8. BAY OF NAPLES & THE AMALFI COAST HIGHLIGHTS L¤ Naples, Pompeii, Herculaneum, Capri, Amalfi, Ravello, Positano L¤the ancient wonders of Pompeii, the island beauty of Capri, Naples' National Archaeo- logical Museum, the pretty towns hugging the Amalfi Coast BAY OF NAPLES & THE AMALFI COAST 229 INTRO COORDINATES The Bay of Naples is the Naples sits on the Bay of Naples, about gateway to the scenic island four hours south of Rome by train or car of Capri and the ancient if you take the A2. You can also arrive by Roman towns of Pompeii ferry or bus. The northern part of the and Herculaneum. In Amalfi Coast is another hour or so south Naples itself is the best Ro- of Naples by car if there is no man archeological museum traffic, but you will likely in Italy, and some say all of find the bus much easier! Europe, filled with the arti- facts from those ancient Roman towns that were covered in the ash and lava from the eruption of Mt. Vesuvius almost 2,000 years ago. A little way beyond the bay are the picturesque villages of the Amalfi Coast perched scenically on the slope overlooking the pristine blue waters of the Mediterranean, where you will find Positano, Amalfi, and Ravello, among others. A WEEKEND IN CAPRI & NAPLES There is quite a lot to do in and around the Bay of Naples. This weekend is packed with scenic vistas, relaxing islands, ancient Roman towns, exemplary museums, and more. Friday Evening As you pass through Naples, feel its energy, notice the chaos, smell the exhaust fumes, and be thankful you will be spending your weekend on the pristine island of Capri.