Periodico Quaderni Archeologia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Intriguing Human Preference for a Ternary Patterned Reality
75 Kragujevac J. Sci. 27 (2005) 75-114. THE INTRIGUING HUMAN PREFERENCE FOR A TERNARY PATTERNED REALITY Lionello Pogliani,* Douglas J. Klein,‡ and Alexandru T. Balaban¥ *Dipartimento di Chimica Università della Calabria, 87030 Rende (CS), Italy; ‡Texas A&M University at Galveston, Galveston, Texas, 77553-1675, USA; ¥ Texas A&M University at Galveston, Galveston, Texas, 77551, USA E-mails: [email protected]; [email protected]; balabana @tamug.tamu.edu (Received February 10, 2005) Three paths through the high spring grass / One is the quicker / and I take it (Haikku by Yosa Buson, Spring wind on the river bank Kema) How did number theory degrade to numerology? How did numerology influence different aspects of human creation? How could some numbers assume such an extraordinary meaning? Why some numbers appear so often throughout the fabric of reality? Has reality really a preference for a ternary pattern? Present excursion through the ‘life’ and ‘deeds’ of this pattern and of its parent number in different fields of human culture try to offer an answer to some of these questions giving at the same time a glance of the strange preference of the human mind for a patterned reality based on number three, which, like the 'unary' and 'dualistic' patterned reality, but in a more emphatic way, ended up assuming an archetypical character in the intellectual sphere of humanity. Introduction Three is not only the sole number that is the sum of all the natural numbers less than itself, but it lies between arguably the two most important irrational and transcendental numbers of all mathematics, i.e., e < 3 < π. -

CONSIDERAZIONI Di Storia Ed Archeologia 2021
CONSIDERAZIONI di Storia ed Archeologia 2021 CONSIDERAZIONI DI STORIA ED ARCHEOLOGIA DIRETTORE GIANFRANCO DE BENEDITTIS Comitato di redazione Rosalba ANTONINI Paolo MAURIELLO Maria Assunta CUOZZO Antonella MINELLI Cecilia RICCI Gianluca SORICELLI Comitato Scientifico BARKER Graeme CAMBRIDGE, BISPHAM Edward OXFORD, CAPPELLETTI Loredana VIENNA. CORBIER Cecilia PARIGI , CROWFORD Michael LONDRA, D’ERCOLE Cecilia PARIGI, ESPINOSA David OVIEDO, ISAYEV Elena EXETER, LETTA Cesare PISA, OAKLEY Stephen CAMBRIDGE, PELGROM Jeremia GRONINGEN, STECK Tesse LEIDEN, TAGLIAMONTE Gianluca LECCE Segreteria Gino AMOROSA Marilena COZZOLINO Federico RUSSO Autorizzazione del Tribunale di Campobasso nr. 6/08 cr. n. 2502 del 17.09.2008 La rivista è scaricabile gratuitamente dal sito www.samnitium.com ISSN 2039-4845 (testo a stampa) ISSN 2039-4853 (testo on line) INDICE p. 3 CARTA ARCHEOLOGICA DEL MUNICIPIUM DEI LIGURES BAEBIANI (MACCHIA DI CIRCELLO, BN) Paola Guacci p. 34 ASPETTI LETTERARI DI UNA CONTROVERSA ISCRIZIONE (CIL IX 2689) Laura Fontana p. 48 NOTE SUI QUAESTORES ENTRO COLONIE LATINE Federico Russo p. 57 PER UN DOSSIER SULLA LINGUA SANNITICA DI TEANUM APULUM Gianfranco De Benedittis p. 72 FRUSTULA BARANELLENSIA 2 TESSERAE IN TERRACOTTA DAL MUSEO CIVICO “GIUSEPPE BARONE” Jessica Piccinini p. 83 FORTIFICAZIONI MEGALITICHE NEL VALLO DI DIANO CUOZZO DELLA CIVITA - TEGGIANUM LUCANA E LE SUE FORTIFICAZIONI SATELLITI DI CUOZZO DELL’UOVO E DI CIMA 760 SAGGIO DI FOTOINTERPRETAZIONE ARCHEOLOGICA Domenico Caiazza NOTE SUI QUAESTORES ENTRO COLONIE LATINE Federico Russo 1. I quaestores locali Alcune fra le più antiche testimonianze epigrafiche restituiteci dalla colonia latina di Paestum per- mettono di affrontare un problema di carattere storico-istituzionale da lungo tempo dibattuto in dot- trina, quello della funzione e del profilo giuridico dei quaestores locali dell’Italia antica, con particolare riferimento a quelli attestati nelle colonie latine. -

Using Italian
This page intentionally left blank Using Italian This is a guide to Italian usage for students who have already acquired the basics of the language and wish to extend their knowledge. Unlike conventional grammars, it gives special attention to those areas of vocabulary and grammar which cause most difficulty to English speakers. Careful consideration is given throughout to questions of style, register, and politeness which are essential to achieving an appropriate level of formality or informality in writing and speech. The book surveys the contemporary linguistic scene and gives ample space to the new varieties of Italian that are emerging in modern Italy. The influence of the dialects in shaping the development of Italian is also acknowledged. Clear, readable and easy to consult via its two indexes, this is an essential reference for learners seeking access to the finer nuances of the Italian language. j. j. kinder is Associate Professor of Italian at the Department of European Languages and Studies, University of Western Australia. He has published widely on the Italian language spoken by migrants and their children. v. m. savini is tutor in Italian at the Department of European Languages and Studies, University of Western Australia. He works as both a tutor and a translator. Companion titles to Using Italian Using French (third edition) Using Italian Synonyms A guide to contemporary usage howard moss and vanna motta r. e. batc h e lor and m. h. of f ord (ISBN 0 521 47506 6 hardback) (ISBN 0 521 64177 2 hardback) (ISBN 0 521 47573 2 paperback) (ISBN 0 521 64593 X paperback) Using French Vocabulary Using Spanish jean h. -

Map 44 Latium-Campania Compiled by N
Map 44 Latium-Campania Compiled by N. Purcell, 1997 Introduction The landscape of central Italy has not been intrinsically stable. The steep slopes of the mountains have been deforested–several times in many cases–with consequent erosion; frane or avalanches remove large tracts of regolith, and doubly obliterate the archaeological record. In the valley-bottoms active streams have deposited and eroded successive layers of fill, sealing and destroying the evidence of settlement in many relatively favored niches. The more extensive lowlands have also seen substantial depositions of alluvial and colluvial material; the coasts have been exposed to erosion, aggradation and occasional tectonic deformation, or–spectacularly in the Bay of Naples– alternating collapse and re-elevation (“bradyseism”) at a staggeringly rapid pace. Earthquakes everywhere have accelerated the rate of change; vulcanicity in Campania has several times transformed substantial tracts of landscape beyond recognition–and reconstruction (thus no attempt is made here to re-create the contours of any of the sometimes very different forerunners of today’s Mt. Vesuvius). To this instability must be added the effect of intensive and continuous intervention by humanity. Episodes of depopulation in the Italian peninsula have arguably been neither prolonged nor pronounced within the timespan of the map and beyond. Even so, over the centuries the settlement pattern has been more than usually mutable, which has tended to obscure or damage the archaeological record. More archaeological evidence has emerged as modern urbanization spreads; but even more has been destroyed. What is available to the historical cartographer varies in quality from area to area in surprising ways. -
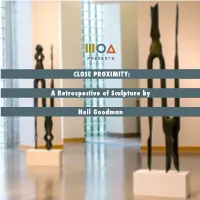
A Retrospective of Sculpture by CLOSE PROXIMITY: Neil Goodman
PRESENTS CLOSE PROXIMITY: A Retrospective of Sculpture by Neil Goodman Contents Introduction ............................. 10 Foreword ..................................19 Artist’s Statement ..................... 33 PRESENTS Interview ................................. 38 Neil Goodman Biography .......... 48 CLOSE PROXIMITY: Artwork Plates ......................... 50 A Retrospective of Sculpture by Founded in 1981 with the mission of “making art a part of everyday life”, the Museum of Outdoor Arts (MOA) is a forerunner in the placement of site-specific sculpture in Colorado. Our art collection is located at public locations throughout the Denver metro area. From commercial office parks to botanic gardens, city parks and traditional sculpture gardens; art is placed to interpret space as Neil Goodman “a museum without walls.” MOA also curates indoor galleries and hosts world-class art exhibitions and educational programs. Please visit our website to learn more about MOA. MOAonline.org MOA INDOOR GALLERY Follow Us @OutdoorArts 1000 Englewood Parkway, Second Floor, Englewood, CO 80110 Exhibiting September 15 – November 17, 2018 OUTDOOR INSTALLATION AT WESTLANDS PARK All photography by 5701 South Quebec Street, Greenwood Village, CO 80111 Heather Longway Exhibiting September 2018 – August 2019 2 CLOSE PROXIMITY: A Retrospective of Sculpture by Neil Goodman MOA, September 15 - November 17, 2018 3 4 CLOSE PROXIMITY: A Retrospective of Sculpture by Neil Goodman MOA, September 15 - November 17, 2018 5 6 CLOSE PROXIMITY: A Retrospective of Sculpture by Neil Goodman MOA, September 15 - November 17, 2018 7 8 CLOSE PROXIMITY: A Retrospective of Sculpture by Neil Goodman MOA, September 15 - November 17, 2018 9 INTRODUCTION retrospective exhibition. We all became fast the massive sculptures frame the landscape. friends and enthusiastic collaborators. -

Archaeometric Study of Roman Pottery from Caudium Area (Southern Italy)
De Bonis_periodico 06/09/10 10.51 Pagina 73 Period. Mineral. (2010), 79, 2, 73-89 doi: 10.2451/2010PM0011 http://go.to/permin An International Journal of PerIodICo di MInerAlogIA MINERALOGY, CRYSTALLOGRAPHY, GEOCHEMISTRY, established in 1930 ORE DEPOSITS, PETROLOGY, VOLCANOLOGY and applied topics on Environment , Archeometry and Cultural Heritage Archaeometric study of roman pottery from Caudium area (Southern Italy) Alberto De bonis 1 *, C elestino GrifA 2, A lessio lAnGellA 2, M AriAno MerCurio 2, M AriA luisA Perrone 3 and VinCenzo MorrA 1 1 Dipartimento di scienze della terra, università degli studi federico ii, Via Mezzocannone, 8, 80134 napoli, italy. 2 Dipartimento di studi Geologici ed Ambientali, università degli studi del sannio, Via dei Mulini, 59/A, 82100 benevento, italy. 3 Via r. Morghen, 61/C, 80129, napoli, italy. Submitted, April 2010 - Accepted, July 2010 AbstrACt - Aim of this work is the minero- quartzarenite clasts. Multivariate statistical analysis petrographical characterization of late antique painted (Hierarchical Clustering and Principal Component common wares from the ancient roman settlement of Analysis) confirms the already identified groups. Caudium (today Montesarchio, Campania region, Mineralogical analyses and scanning electron italy). microscope observations of the sintering degree of twenty-two samples (4 th to 6 th century AD) clayey paste enabled to evaluate the firing collected during the archaeological survey of the area, temperatures of the most representative samples (from were studied to investigate their manufacturing 800 to 1200°C). technology and to attest a possible local production. the whole data set, along with geological features Ceramics shards are represented by 16 painted of the investigated area (wide availability of raw common ware samples; furthermore, 2 bricks, 2 kiln materials) and archaeological evidences (kiln refuses, rejects and 2 fragments of cooking ware were large number of fragments of the same ceramic class), investigated for comparison. -

By Filippo Sabetti Mcgill University the MAKING of ITALY AS AN
THE MAKING OF ITALY AS AN EXPERIMENT IN CONSTITUTIONAL CHOICE by Filippo Sabetti McGill University THE MAKING OF ITALY AS AN EXPERIMENT IN CONSTITUTIONAL CHOICE In his reflections on the history of European state-making, Charles Tilly notes that the victory of unitary principles of organiza- tion has obscured the fact, that federal principles of organization were alternative design criteria in The Formation of National States in West- ern Europe.. Centralized commonwealths emerged from the midst of autonomous, uncoordinated and lesser political structures. Tilly further reminds us that "(n)othing could be more detrimental to an understanding of this whole process than the old liberal conception of European history as the gradual creation and extension of political rights .... Far from promoting (representative) institutions, early state-makers 2 struggled against them." The unification of Italy in the nineteenth century was also a victory of centralized principles of organization but Italian state- making or Risorgimento differs from earlier European state-making in at least three respects. First, the prospects of a single political regime for the entire Italian peninsula and islands generated considerable debate about what model of government was best suited to a population that had for more than thirteen hundred years lived under separate and diverse political regimes. The system of government that emerged was the product of a conscious choice among alternative possibilities con- sidered in the formulation of the basic rules that applied to the organi- zation and conduct of Italian governance. Second, federal principles of organization were such a part of the Italian political tradition that the victory of unitary principles of organization in the making of Italy 2 failed to obscure or eclipse them completely. -

Relazione Tecnica
VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO DI REGOLAZIONE SUL BACINO DI CAMPOLATTARO COMMITTENTE: REC S.R.L VIA GIULIO UBERTI 37 MILANO ANALISI ARCHEOLOGICA – RELAZIONE TECNICA COORDINAMENTO ATTIVITÀ: APOIKIA S.R.L. – SOCIETÀ DI SERVIZI PER L’ARCHEOLOGIA CORSO VITTORIO EMANUELE 84 NAPOLI 80121 TEL. 0817901207 P. I. 07467270638 [email protected] DATA GIUGNO 2012 CONSULENZA ARCHEOLOGICA: RESPONSABILE GRUPPO DI LAVORO: DOTT.SSA FRANCESCA FRATTA DOTT.SSA AURORA LUPIA COLLABORATORI: DOTT. ANTONIO ABATE DOTT.SSA BIANCA CAVALLARO DOTT. GIANLUCA D’AVINO DOTT.SSA CONCETTA FILODEMO DOTT. NICOLA MELUZIIS DOTT. SSA RAFFAELLA PAPPALARDO DOTT. FRANCESCO PERUGINO DOTT..SSA MARIANGELA PISTILLO REC- iIMPIANTO IDROELETTRICO DI REGOLAZIONE SUL BACINO DI CAMPOLATTARO Relazione Tecnica PREMESSA 1. METODOLOGIA E PROCEDIMENTO TECNICO PP. 4-26 1.1 LA SCHEDATURA DEI SITI DA BIBLIOGRAFIA E D’ARCHIVIO PP. 4-6 1.2 LA FOTOINTERPRETAZIONE PP. 7-9 1.3 LA RICOGNIZIONE DI SUPERFICIE PP. 10-20 1.4 APPARATO CARTOGRAFOICO PP. 21-26 2. INQUADRAMENTO STORICO ARCHEOLOGICO PP. 27-53 3. L'ANALISI AEROTOPOGRAFICA PP. 54-58 4. LA RICOGNIZIONE DI SUPERFICIE - SURVEY PP. 59-61 5. CONCLUSIONI PP. 62-84 BIBLIOGRAFIA PP. 84-89 ALLEGATI SCHEDOGRAFICI: LE SCHEDE DELLE EVIDENZE DA BIBLIOGRAFIA LE SCHEDE DELLE TRACCE DA FOTOINTERPRETAZIONE LE SCHEDE DI RICOGNIZIONE: - SCHEDE UR - SCHEDE UDS - SCHEDE SITI - SCHEDE QUANTITATIVE DI MATERIALI ARCHEOLOGICI - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SITI E REPERTI ARCHEOLOGICI UDS ALLEGATI CARTOGRAFICI: -

Tituli Honorarii, Monumentale Eregedenktekens. Ere-Inscripties Ten Tijde Van Het Principaat Op Het Italisch Schiereiland
Annelies De Bondt 2e licentie Geschiedenis Optie Oude Geschiedenis Stnr. 20030375 Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte Vakgroep Oude Geschiedenis van Europa Blandijnberg 2 9000 Gent Tituli honorarii, monumentale eregedenktekens. Ere-inscripties ten tijde van het Principaat op het Italisch schiereiland. Een statistisch-epigrafisch onderzoek. Fascis 3: Inventaris. Promotor: Prof. Dr. Robert DUTHOY Licentiaatsverhandeling voorgedragen tot Leescommissarissen: Prof. Dr. Dorothy PIKHAUS het behalen van de graad van A Dr. Koenraad VERBOVEN Licentiaat/Master in de geschiedenis. Inventaris 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave 1 1. Inleiding 5 1.1. Verantwoording nummering 5 1.2. Diakritische tekens 6 1.3. Bibliografie en gebruikte afkortingen. 6 2. Inventaris 9 Regio I, Latium et Campania 9 Latium Adjectum 9 Aletrium 9 Fundi 17 Anagnia 9 Interamna Lirenas 18 Antium 10 Minturnae 19 Aquinum 11 Privernum 20 Ardea 11 Rocca d’Arce 20 Atina 12 Setia 21 Casinum 12 Signia 21 Cereatae Marianae 13 Sinuessa 21 Circeii 13 Suessa Aurunca 21 Cora 13 Sura 23 Fabrateria Vetus 14 Tarracina 23 Ferentinum 15 Velitrae 23 Formiae 16 Verulae 23 Latium Vetus 24 Albanum 24 Lavinium 28 Bovillae 24 Ostia Antica 30 Castel di Decima 25 Portus 37 Castrimoenium 25 Praeneste 37 Gabiae 26 Tibur 39 Labico 27 Tusculum 42 Lanuvium 27 Zagarollo 43 Campania 44 Abella 44 Neapolis 56 Abellinum 44 Nola 56 Acerrae 45 Nuceria 57 Afilae 45 Pompei 57 Allifae 45 Puteoli 58 Caiatia 46 Salernum 62 Cales 47 Stabiae 63 Capua 48 Suessula 63 Cubulteria 50 Surrentum 64 Cumae 50 Teanum Sidicinum -

The Cauldron 2015
Mikaela Liotta, Cake Head Man, mixed media The Cauldron Senior Editors Grace Jaewon Yoo Muriel Leung Liam Nadire Staff Pann Boonbaichaiyapruck Phoebe Danaher Daniel Fung 2015 Sally Jee Prim Sirisuwannatash Angela Wong Melissa Yukseloglu Faculty Advisor Joseph McDonough 1 Poetry Emma Woodberry Remember 5 GyuHui Hwang Two Buttons Undone 6 Khanh Nyguen I Wait for You to Have Dinner 8 Angela Wong Euphoria 9 Sabi Benedicto The House was Supposed to be Tan 12 (But was Accidentally Painted Yellow) Canvas Li Haze 15 Adam Jolly Spruce and Hemlock Placed By 44 Gentle Hands Jordan Moller The Burning Cold 17 Grace Jaewon Yoo May 18 Silent Hills 40 Lindsay Wallace Forgotten 27 Joelle Troiano Flicker 30 Jack Bilbrough Untitled 31 Valentina Mathis A Hop Skip 32 Jessica Li The Passenger 36 Daddy’s Girl 43 Eugenia Rose stumps 38 Brandon Fong Ironing 47 Ryder Sammons Mixed Media, Ceramics New Year’s Cold 48 Mikaela Liotta Shayla Lamb Spine 7 Senior Year 50 Mermaid 46 Teddy Simson Elephant Skull 16 Prose Eye of the Tiger 53 Muriel Leung Katie I A Great River 20 Imagination 19 Zorte 52 Sabi Benedicto Geniophobia 32 2 Photography Rachel Choe More Please 8 Pann Boonbaichaiyapruck DEAD 2 Spin 12 Swimmingtotheschor 22 Bigfernfloating 41 Lydia Stenflo LA as seen from the 14 Griffith Observatory at Night in March Beach Warrior 58 Meimi Zhu Reflection 30 Jessica Li Juvenescence 37 The Last Door 42 Brandon Fong The End is Neigh 38 Sunday in Menemsha 53 Liam Nadire Hurricane Sandy #22 47 Pride 58 Painting, Drawing Katie I Risen 4 Oban Galbraith The Divide 9 Joni Leung -

The Pilgrim M Ther Schoenstatt Rosary Campaign ~ the Pilgrim Mother ~ Vol
The Pilgrim M ther Schoenstatt Rosary Campaign ~ The Pilgrim Mother ~ Vol. 3 Num. 2 ~ www.schoenstattrosarycampaign.com ~ 262-522-4326 ~ [email protected] Summer 2016 Dear Missionaries, Queridos Misioneros, In this jubilee year of Mercy our Schoenstatt Shrines across En este año jubilar de la Misericordia nuestros the USA become focal points of intense prayer life, but also Santuarios de Schoenstatt se convierten en of deep experiences of mercy. If that is the case, then our puntos centrales de intensa vida de oración, images of the Pilgrim Mother ought to become powerful pero también de experiencias profundas de instruments of God’s graces transmitted to all those who misericordia. Si esto es así, entonces nuestras imágenes de la Virgen Peregrina han de open their doors to the presence of Mary in their homes. convertirse en instrumentos poderosos por And, you are the chosen instruments to make this possible! medio de los cuales Dios transmite sus gracias a todos los que abren las puertas de sus That is why we want to crown our Pilgrim Mothers this year! hogares a María. Y, ¡ustedes son los We want to pull on her mantle, so to say, and remind her of instrumentos elegidos para realizar este our many dire needs in these times of extreme confusion, apostolado! persecution, and disasters. We won’t allow negativism and Por eso queremos coronar nuestras imágenes pessimism to have the last word. God’s will, God’s word, and de la Virgen Peregrina este año. Queremos God’s doing shall have the last word. Mary, the Mother of halar su manto, por decir así, y recordarle las God, the Handmaid of the Lord is an expert in making that muchas y grandes necesidades que happen. -
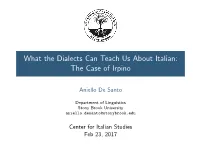
What the Dialects Can Teach Us About Italian: the Case of Irpino
What the Dialects Can Teach Us About Italian: The Case of Irpino Aniello De Santo Department of Linguistics Stony Brook University [email protected] Center for Italian Studies Feb 23, 2017 Italian Dialects Raddoppiamento Sintattico Irpino Experiments Language as a Tapestry Italian Dialects Raddoppiamento Sintattico Irpino Experiments Language as a Tapestry Italian Dialects Raddoppiamento Sintattico Irpino Experiments Outline 1 Why a study of Dialects? 2 Raddoppiamento Sintattico 3 The Irpino Dialect 4 Field Experiments Italian Dialects Raddoppiamento Sintattico Irpino Experiments Languages of Italy Image cc @ Wikipeda 2 Italian Dialects Raddoppiamento Sintattico Irpino Experiments Languages of Italy Table: From Sabatini, F. (1978) English Better an egg today than an hen tomorrow Standard Italian Meglio un uovo oggi che una gallina domani Friulan Mior un of ui che une gialine doman Piedmontese A l'e mej 'n euve ancheuj che na galin-a doman Emilian L'e mei un ov incu che la galeina edmeng Tuscan Megl'un ovo oggi he una gallina domani Corsican Medu ogji l'ou che dumane a jadina Romanesque Mejjo l'ovo oggi ch'a gallina domani Campanian Meglie ll'uove ogge c'a jalline rimane Salentine Megghiu i'd osce cca la caddina crai Calabrian Miegliu oje un 'uovu ca dumani ca dumani a gaddina Sicilian Megghiu oji un 'ovu ca rumani a jaddina Sardinian Menzus unu ou oje chi no una pudda crasa 3 Italian Dialects Raddoppiamento Sintattico Irpino Experiments Languages vs Dialects A common misconception Dialects are a corrupted version of the Standard