"FEDERICO Il" Pasquarella C.,* Sannino G.** Soriente I.* GRECO
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Greco Di Tufo DOCG” Non Deve Essere Superiore Alle 10 Tonnellate
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DOCG “GRECO DI TUFO” Approvato DOC con DPR 26.03.1970 G.U.130 - 26.05.1970 Approvato DOCG con DM 18.07.2003 G.U. 180 - 05.08.2003 Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Modificato con DM 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Articolo 1 Denominazione e vini La Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Greco di Tufo”, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: “Greco di Tufo” Bianco; “Greco di Tufo”Spumante Articolo 2 Base ampelografica La Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Greco di Tufo” è riservata ai vini bianchi ottenuti esclusivamente da uve di vitigni provenienti da vigneti, aventi in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Greco B: minimo 85%; Coda di Volpe bianca: massimo 15%. Articolo 3 Zona di produzione La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Avellino: Tufo, Altavilla Irpina, Chianche, Montefusco, Prata di Principato Ultra, Petruro Irpino, Santa Paolina e Torrioni. Articolo 4 Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Greco di Tufo” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. -

Avviso Pubblico Ammissioni Alle Ludoteche Prima Infanzia “Spazio Bimbi” in Strutture Convenzionate
AVVISO PUBBLICO AMMISSIONI ALLE LUDOTECHE PRIMA INFANZIA “SPAZIO BIMBI” IN STRUTTURE CONVENZIONATE IL PRESIDENTE RENDE NOTO CHE Le domande di accesso al servizio e di ammissione alle Ludoteche Prima Infanzia “Spazio Bimbi”, pervenute entro il termine di presentazione del 20.02.2018 sono in corso di esame ai fini della valutazione dell’ammissione e della eventuale quota di compartecipazione. Considerato che risultano ancora posti disponibili, SI COMUNICA CHE rimane sempre aperta la possibilità di effettuare le DOMANDE DI AMMISSIONE alle LUDOTECHE PRIMA INFANZIA “SPAZIO BIMBI”. Le domande di accesso al servizio saranno considerate in ordine cronologico di acquisizione al protocollo di riferimento di ogni singolo Comune, per cui le domande pervenute per ogni sede e regolari dal punto di vista formale (ossia con possesso dei requisiti, sottoscritte e consegnate con la documentazione richiesta, in particolare completa di ISEE) individueranno i minori partecipanti alle attività, fino a completamento delle singole sezioni divise per sedi. Le ulteriori domande pervenute confluiranno in una lista d'attesa per ognuna delle sedi richieste, alla quale l'Ufficio di Piano attingerà per i successivi ingressi in caso di sopraggiunta disponibilità di posti-utente. In caso di lista d'attesa attiva per una sede e presenza di posti disponibili per l'altra sede, l'Ufficio di Piano potrà prevedere, previo consenso del genitore del minore o di chi ne fa le veci, l'inserimento del minore interessato nella sede per la quale non sono stati ancora saturati i posti programmati. L'Ufficio di Piano dell'Ambito A04, all'avvio del servizio, renderà noto l'elenco degli iscritti e dei nominativi dei minori inseriti in lista d'attesa. -

Guardia Di Finanza Savignano Irpino
Provincia di Avellino Settore Pianificazione e Attività sul Territorio Servizio Protezione Civile Greci Montaguto Casalbore Guardia di Finanza Savignano Irpino Montecalvo Irpino Ariano Irpino Competenza territoriale Zungoli Villanova del Battista Melito Irpino COMPAGNIA AVELLINO Bonito San Sossio Baronia Scampitella Flumeri Vallesaccarda Grottaminarda TENENZA ARIANO IRPINO Venticano San Nicola Baronia Pietradefusi Mirabella Eclano Chianche Castel Lacedonia Montefusco Baronia Trevico TENENZA BAIANO Rotondi Roccabascerana Petruro Torrioni Torre le Vallata Irpino Nocelle Fontanarosa Sturno Tufo Carife Cervinara Santa Paolina Taurasi Monteverde San Martino Sant'Angelo all' Esca TENENZA SANT'ANGELO DEI LOMBARDI Altavilla Prata di Montemiletto Frigento Bisaccia Valle Irpina Gesualdo Aquilonia Caudina Pietrastornina Principato Grottolella Ultra Lapio Luogosano Avella Pratola Serra Guardia TENENZA SOLOFRA Sant'Angelo a Scala Villamaina Rocca Lombardi Montefalcione San Sirignano Summonte Montefredane Paternopoli San Mango sul Calore Felice Quadrelle Capriglia Irpina Mugnano del Cardinale Ospedaletto Candida Torella dei Andretta Sede Reparti Guardia di Finanza Manocalzati Castelvetere sul Calore Sperone d'Alpinolo Parolise Lombardi Chiusano San Domenico Sant'Angelo Mercogliano Avellino San Potito Ultra dei Lombardi Morra de Baiano Castelfranci Calitri Atripalda Salza Irpina Sanctis Marzano Montemarano Sorbo Serpico di Nola Taurano Monteforte Cesinali Cairano Pago del Vallo di Lauro Irpino Santo Stefano del Sole Cassano Aiello del Sabato Conza Lauro -

Decreto Del Presidente Della Provincia Di Avellino
Giunta Regionale della Campania Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 45 del 20 settembre 2004 PROVINCIA DI AVELLINO - Decreto del Presidente della Provincia di Avellino concernente l’approvazione dell’Accordo di Programma per la “Valorizzazione e sviluppo comprensorio Vini Doc Greco e Fiano e creazione Parco Minerario delle antiche zolfare di Tufo ed Altavilla Irpina lungo la valle del fiume Sabato del 7 giugno 2004. IL PRESIDENTE PREMESSO: che in data 8 febbraio 1999 è stato sottoscritto un “Accordo di Programma”, tra l’Amministrazione Provinciale di Avellino, la Comunità Montana Partenio, l’Associazione per l’Archeologia Industriale, il Parco Scientifico Tecnologico, l’Associazione Movimento del Turismo del Vino e l’Associazione Città del Vino, finalizzato alla “Valorizzazione e sviluppo del Comprensorio vini DOC Greco e Fiano e creazione parco minerario delle antiche zolfare di Tufo ed Altavilla lungo la valle del fiume Sabato”; che, nell’abito delle opportunità offerte dalle delibere CIPE 9 luglio 1998 e 30 giugno 1999, n. 106, è stato finanziato e redatto uno studio di fattibilità per la alla “Valorizzazione e sviluppo del Comprensorio vini DOC Greco e Fiano e creazione parco minerario delle antiche zolfare di Tufo ed Altavilla lungo la valle del fiume Sabato”; • che per lo studio, certificato positivo e coerente dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, si è concluso con la fattibilità degli interventi ideati per un importo complessivo di E. 25.578.798,41; • che per la progettazione preliminare dei citati interventi è stato assegnato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della legge 144/99, un finanziamento complessivo di E. -

Actes Dont La Publication Est Une Condition De Leur Applicabilité)
30 . 9 . 88 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 270/ 1 I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CEE) N° 2984/88 DE LA COMMISSION du 21 septembre 1988 fixant les rendements en olives et en huile pour la campagne 1987/1988 en Italie, en Espagne et au Portugal LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, considérant que, compte tenu des donnees reçues, il y a lieu de fixer les rendements en Italie, en Espagne et au vu le traité instituant la Communauté économique euro Portugal comme indiqué en annexe I ; péenne, considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières vu le règlement n0 136/66/CEE du Conseil, du 22 grasses, septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) A ARRÊTÉ LE PRESENT REGLEMENT : n0 2210/88 (2), vu le règlement (CEE) n0 2261 /84 du Conseil , du 17 Article premier juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive , et aux organisa 1 . En Italie, en Espagne et au Portugal, pour la tions de producteurs (3), modifié en dernier lieu par le campagne 1987/ 1988 , les rendements en olives et en règlement (CEE) n° 892/88 (4), et notamment son article huile ainsi que les zones de production y afférentes sont 19 , fixés à l'annexe I. 2 . La délimitation des zones de production fait l'objet considérant que, aux fins de l'octroi de l'aide à la produc de l'annexe II . -

Comunità Montane Savignano Irpino
Provincia di Avellino Settore Pianificazione e Attività sul Territorio Servizio Protezione Civile Greci Montaguto Casalbore Comunità Montane Savignano Irpino Montecalvo Irpino Ariano Irpino Competenza territoriale Zungoli Villanova del Battista Melito Irpino Comunità Montana Ufita Bonito San Sossio Baronia Scampitella Flumeri Vallesaccarda Comunità Montana Alta Irpinia Grottaminarda Venticano San Nicola Baronia Pietradefusi Mirabella Eclano Chianche Castel Lacedonia Comunità Montana Partenio - Vallo di Lauro Montefusco Baronia Trevico Rotondi Roccabascerana Petruro Torrioni Torre le Vallata Irpino Nocelle Fontanarosa Sturno Tufo Carife Cervinara Santa Paolina Taurasi Monteverde Comunità Montana Irno - Solofrana San Martino Sant'Angelo all' Esca Altavilla Prata di Montemiletto Frigento Bisaccia Valle Irpina Gesualdo Aquilonia Caudina Pietrastornina Principato Grottolella Ultra Lapio Luogosano Comunità Montana Termino Cervialto Avella Pratola Serra Guardia Sant'Angelo a Scala Villamaina Rocca Lombardi Montefalcione San Sirignano Summonte Montefredane Paternopoli San Mango sul Calore Felice Quadrelle Capriglia Irpina Comuni non appartenenti Mugnano del Cardinale Ospedaletto Candida Torella dei Andretta Manocalzati Castelvetere sul Calore Sperone d'Alpinolo Parolise Lombardi Chiusano San Domenico Sant'Angelo Mercogliano Avellino San Potito Ultra dei Lombardi Morra de Baiano Castelfranci Calitri Atripalda Salza Irpina Sanctis Marzano Montemarano Sorbo Serpico di Nola Taurano Monteforte Cesinali Cairano Pago del Vallo di Lauro Irpino Santo -

NATURA 2000 Dir. 92/43/CEE E 79/409/CEE
Baselice Sassinoro G Colle Sannita Foiano di Val Fortore Matese Reino Pietraroia Morcone Alta Valle del Fiume Tammaro Sorgenti e Alta Valle del Fiume Fortore Montefalcone di Val Fortore Circello Assessorato ai Rapporti con il Consiglio Regionale - Sport - Lavori Pubblici - Pendici Meridionali del Monte Mutria Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia Cusano Mutri Bosco di Castelfranco in Miscano Opere Pubbliche - Parcheggi - Cave e Torbiere, Acque Minerali, Termali e Miniere San Marco dei Cavoti Molinara Commissario ad Acta 62054_04 L 62054_01 PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE Cerreto Sannita Ordinanza T.A.R. Campania - Napoli - Prima sezione - n. 719 del 18/5/05 62059_01 Pontelandolfo Reino Castelfranco in Miscano Campolattaro 62059_00 Ginestra degli Schiavoni Fragneto l'Abate San Lupo San Giorgio la Molara San Lorenzello Greci Casalduni 62062_05 64020_05 I Montaguto Guardia Sanframondi Pesco Sannita Casalbore San Lorenzo Maggiore Fragneto Monforte Pago Veiano Castelvenere 62034_01 64020_01 PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE Fiumi Volturno e Calore Beneventano Ponte Buonalbergo 62019_01 64005_01 Savignano Irpino 62053_01 62008_21 62008_11 64096_02 A Paupisi 62076_03 64096_01 62008_62 Pietrelcina Montecalvo Irpino 62008_63 Tavola n. 2 - AV: NATURA 2000: Aree SIC e ZPS Torrecuso Solopaca Dir.92/43/CEE e 79/409/CEE Provincia di Avellino Vitulano Paduli Camposauro Sant'Arcangelo Trimonte 62030_01 64005_07 62077_01 Ariano Irpino 64005_04 Foglianise 64005_03 62021_00 Il Commissario ad Acta delegato 62021_01 (Decreto Ass. Reg. LL.PP. -
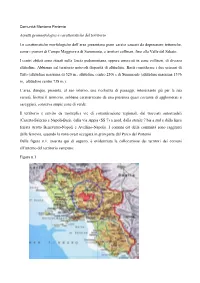
Aspetti Geomorfologici E Caratteristiche Del Territorio Le
Comunità Montana Partenio Aspetti geomorfologici e caratteristiche del territorio Le caratteristiche morfologiche dell’area presentano piani carsici causati da depressioni tettoniche, come i pianori di Campo Maggiore e di Summonte, a territori collinari, fino alla Valle del Sabato. I centri abitati sono situati nella fascia pedemontana, oppure arroccati in zone collinari, di diversa altitudine. Abbiamo sul territorio notevoli disparità di altitudine. Basti considerare i due estremi di Tufo (altitudine massima di 520 m., altitudine centro 250) e di Summonte (altitudine massima 1576 m, altitudine centro 738 m.). L’area, dunque, presenta, al suo interno, una ricchezza di paesaggi, interessante già per la sua varietà. Inoltre il territorio, sebbene caratterizzato da una presenza quasi costante di agglomerati e caseggiati, conserva ampie zone di verde. Il territorio è servito da molteplici vie di comunicazione regionali, dai tracciati autostradali (Caserta-Salerno e Napoli-Bari), dalla via Appia (SS 7) a nord, dalla statale 7 bis a sud e dalla linea ferrata (tratto Benevento-Napoli e Avellino-Napoli). I comuni est della comunità sono raggiunti dalla ferrovia, essendo la zona ovest occupata in gran parte dal Parco del Partenio Dalla figura n.1, inserita qui di seguito, è evidenziata la collocazione dei territori dei comuni all’interno del territorio campano: Figura n.1 Infatti l’area della Comunità Montana Partenio è parte integrante del Parco regionale del Partenio del quale, insieme al territorio sannita, rappresenta la parte più significativa. Dei 22 Comuni del Parco 8 fanno parte dell’Ente che ne è la parte più importante con la dorsale montana del Partenio che comprende Montevergine (1493 m) la montagna sede della storica meta religiosa del Santuario. -

Dati Relativi Agli Impianti Gestiti Dalla Societa' Dati
DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI GESTITI DALLA SOCIETA' DATI RELATIVI ALLE LOCALITA' SERVITE DAI SINGOLI IMPIANTI CODICE CODICE DITTA (*) DENOMINAZIONE IMPIANTO LOCALITA' CODICE ISTAT FASCIA CLIMATICA REMI 34749201 IT00CEY01127I Sparanise CE SPARANISE (CE) 61089 C 34756801 IT00BNO00046I San Lorenzello BN CERRETO SANNITA (BN) 62023 D 34768201 IT00AVO00051J Ariano Irpino AV ARIANO IRPINO (AV) 64005 E ATRIPALDA (AV) 64006 D 34768301 IT00AVO00012K Atripalda AV MANOCALZATI (AV) 64046 D AVELLA (AV) 64007 D BAIANO (AV) 64010 C MUGNANO DEL CARDINALE (AV) 64065 D 34768401 IT00AVO00070M Avella AV QUADRELLE (AV) 64076 D SIRIGNANO (AV) 64100 D SPERONE (AV) 64103 C AVELLINO (AV) 64008 D 34768500 IT00AVO00002J Avellino AV CESINALI (AV) 64026 D AIELLO DEL SABATO (AV) 64001 D 34769201 IT00AVO00073S Calitri AV CALITRI (AV) 64015 D 34769501 IT00AVO00067B Capriglia Irpina AV CAPRIGLIA IRPINA (AV) 64018 D CASALBORE (AV) 64020 D 34769701 IT00AVO00111E Casalbore AV BUONALBERGO (BN) 62011 D CHIANCHE (AV) 64027 D 34770401 IT00AVO00101D Chianche AV PETRURO IRPINO (AV) 64071 D TORRIONI (AV) 64111 E 34770701 IT00AVO00132L Conza della Campania AV CONZA DELLA CAMPANIA (AV) 64030 D 34770901 IT00AVO00129A Flumeri AV FLUMERI (AV) 64032 E 34771001 IT00AVO00068D Fontanarosa AV FONTANAROSA (AV) 64033 D 34771101 IT00AVO00103K Forino AV FORINO (AV) 64034 D GESUALDO (AV) 64036 E 34771301 IT00AVO00069F Gesualdo AV FRIGENTO (AV) 64035 E STURNO (AV) 64104 E 34771501 IT00AVO00040J Grottaminarda AV GROTTAMINARDA (AV) 64038 D 34771601 IT00AVO00104M Grottolella AV GROTTOLELLA (AV) 64039 -

Orari, Fermate E Percorso Linea
Orari e mappe della linea bus BUS BUS Avellino Visualizza In Una Pagina Web La linea bus BUS (Avellino) ha 10 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Avellino: 17:00 - 18:25 (2) Avellino: 05:30 - 18:45 (3) Benevento: 06:40 - 19:15 (4) Castel S. Giorgio-Roccap.: 17:15 (5) Mercato S. Severino: 06:00 - 20:40 (6) Mercato S. Severino: 06:45 - 14:15 (7) Montoro Forino: 07:00 - 14:36 (8) Napoli Centrale: 06:15 - 07:00 (9) Nocera Inferiore: 09:10 - 20:20 (10) Salerno: 06:00 - 21:25 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus BUS più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus BUS Direzione: Avellino Orari della linea bus BUS 8 fermate Orari di partenza verso Avellino: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 17:00 - 18:25 martedì 17:00 - 18:25 Salerno Piazza Vittorio Veneto, Salerno mercoledì 17:00 - 18:25 Salerno Irno giovedì 17:00 - 18:25 Mercato San Severino venerdì 17:00 - 18:25 sabato 17:00 Mercato S. Severino, Via Pioppi domenica Non in servizio Montoro Forino Solofra SP32, Solofra Informazioni sulla linea bus BUS Serino Direzione: Avellino Fermate: 8 Avellino Durata del tragitto: 75 min SP41, Atripalda La linea in sintesi: Salerno, Salerno Irno, Mercato San Severino, Mercato S. Severino, Via Pioppi, Montoro Forino, Solofra, Serino, Avellino Direzione: Avellino Orari della linea bus BUS 7 fermate Orari di partenza verso Avellino: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 05:30 - 18:45 martedì 05:30 - 18:45 Benevento mercoledì 05:30 - 18:45 Benevento, Terminal Bus Piazzale Venanzio Vari, Benevento giovedì -

Greco Di Tufo Fiano-Falanghina-Aglianico Campania Paoloboselli.Com - August 2016 TORRICINO
TORRICINO Greco di Tufo Fiano-Falanghina-Aglianico Campania paoloboselli.com - August 2016 TORRICINO The Torricino estate is located outside the township of Tufo in the Avellino province in Campania. The town- ship of Tufo is named for the tufaceous, volcanic soil that the town is built on and has given its name to the ap- pellation, Greco di Tufo. The property takes its title from an old medieval tower neighboring the eleven acre vineyard (4.5 ha). Torricino is owned by the Di Marzo family and grows and bottles Greco di Tufo (D.O.C.G.), Fiano di Avellino (D.O.C.G.), and Aglianico (I.G.T.). The Di Marzo family has been deeply involved in the economic and agricultural life of Tufo for nearly 150 years. In 2002 Stefano Di Marzo (born in 1977) completed his training in agronomy and oenology and decided to commit Torricino to a policy of rigorous selection to bring out all the character and personality of his Greco di Tufo. Stefano believes that it is the land that makes the difference. In Tufo, sulphur mines discovered in 1866 and owned by his ancestors have been the eco- nomic backbone of the town. Stefano, who inherited from his parents Vintantonio & Vincenzina an enormous love and passion for his land, inherited also a unique “terroir” where the mines of sulphur play an important role; in fact his Greco shows intriguing hints of sulphur perfumes. The Greco di Tufo grape was brought from Thessalonica in Greece (near modern day Macedonia) to Magna Grecia in Southern Italy by the Pelasgian people over two millennia ago and cultivated by the Romans in the centuries that followed. -

14601-Pdf12.Pdf
COMUNI APPARTENENTI COM SEDE ABITANTI FAMIGLIE n° COMUNI COMUNI APPARTENENTI COM 1-SA SALERNO 192,539 78,072 2 SALERNO, CAVA DE' TIRRENI COM SEDE ABITANTI FAMIGLIE SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO, ROCCAPIEMONTE, SCAFATI, NOCERA INFERIORE, NOCERA n° COMUNI COMUNI APPARTENENTI COM SEDE ABITANTI FAMIGLIE SUPERIORE, SARNO, PAGANI, SAN VALENTINO TORIO, ANGRI, CORBARA, CASTEL SAN GIORGIO, SAN COM 1-CE CASERTA 118,580 45,569 4 CASAGIOVE, SAN NICOLA LA STRADA, CASTEL MORRONE, CASERTA COMUNI APPARTENENTI n° COMUNI COM 2-SA SARNO 275,217 93,403 12 MARZANO SUL SARNO COM SEDE ABITANTI FAMIGLIE COM 2-CE SAN FELICE A CANCELLO 37,249 12,147 3 SANTA MARIA A VICO, ARIENZO, SAN FELICE A CANCELLO n° COMUNI ALTAVILLA IRPINA, CAPRIGLIA IRPINA, CHIANCHE, GROTTOLELLA, PETRURO IRPINO, VIETRI SUL MARE, PRAIANO, FURORE, MAIORI, SCALA, RAVELLO, ATRANI, CETARA, CONCA DEI COM 1-AV ALTAVILLA IRPINA 13,381 5,433 9 PIETRASTORNINA, SANT'ANGELO A SCALA, TORRIONI, TUFO COM 3-SA TRAMONTI 41,149 15,422 13 MARINI, MINORI, AMALFI, TRAMONTI, POSITANO COM 3-CE MADDALONI 46,548 14,836 3 MADDALONI, CERVINO, VALLE DI MADDALONI COM 1-NA POZZUOLI 134,663 46,235 4 MONTE DI PROCIDA, PROCIDA, BACOLI, POZZUOLI ARIANOIRPINO,CASALBORE,GRECI,MONTAGUTO,MONTECALVOIRPINO,SAVIGNANOIRPINO, COM 4-CE TEANO 28,896 10,875 5 VAIRANO PATENORA, FRANCOLISE, TEANO, CAIANELLO, PIETRAVAIRANO COM 2-NA GIUGLIANO IN CAMPANIA 212,067 68,501 4 MELITO DI NAPOLI, VILLARICCA, GIUGLIANO IN CAMPANIA, QUALIANO COM 2-AV ARIANO IRPINO 34,479 13,895 8 VILLANOVA DEL BATTISTA, ZUNGOLI COM 4-SA BRACIGLIANO 80,545 28,668 7