1 Arditi Del Popolo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tra Fascismo Ed Antifascismo Nel Salernitano
TRA FASCISMO E ANTIFASCISMO NEL SALERNITANO di Ubaldo Baldi Dopo la “grande paura” della borghesia italiana del biennio rosso e la “grande speranza” per il proletariato della occupazione delle fabbriche del settembre 1920 , gli anni che vanno dal 1920 al 1923 , sono caratterizzati in Italia dalle aggressioni squadristiche fasciste. Queste hanno l’obiettivo di smantellare militarmente le sedi dei partiti e delle organizzazioni sindacali della sinistra e con una strategia del terrore eliminare fisicamente e moralmente le opposizioni. Una essenziale , ma non meno drammatica, esposizione di cifre e fatti di questo clima terroristico si ricava da quanto scritto in forma di denunzia da A. Gramsci nell’ “Ordine Nuovo” del 23.7.21 . Nel salernitano il fascismo si afferma, sia politicamente che militarmente, relativamente più tardi, sicuramente dopo la marcia su Roma. Questo fu solo in parte dovuto alla forza e al consistente radicamento all’interno del proletariato operaio delle sue rappresentanze sindacali e politiche. Di contro gli agrari e il padronato industriale ma anche la piccola borghesia , in linea con il classico trasformismo meridionale, prima di schierarsi apertamente , attesero il consolidamento del fascismo e il delinearsi preciso della sua natura per poi adeguarsi conformisticamente alla realtà politico-istituzionale che andava rappresentandosi come vincente. Anche perché ebbero ampiamente modo di verificare e valutare concretamente i privilegi e i vantaggi economici che il fascismo permetteva loro. Il quadro economico provinciale -

Workers' Demonstrations and Liberals
Workers’ Demonstrations and Liberals’ Condemnations: the Italian Liberal Press’s Coverage of General Strikes, Factory Occupations, and Workers’ Self-Defense Groups during the Rise of Fascism, 1919-1922 By Ararat Gocmen, Princeton University Workers occupying a Turin factory in September 1920. “Torino - Comizio festivo in una officina metallurgica occupata.” L’Illustrazione italiana, 26 September 1920, p. 393 This paper outlines the evolution of the Italian liberal press’s in the liberal press in this way, it illustrates how working-class coverage of workers’ demonstrations from 1919 to 1922. The goal radicalism contributed to the rise of fascism in Italy.1 is to show that the Italian liberal middle classes became increas- ingly philofascistic in response to the persistency of workers’ dem- onstrations during this period. The paper analyzes articles from 1 I would like to thank Professor Joseph Fronczak for his guidance the Italian newspapers La Stampa and L’Illustrazione italiana, in writing this paper, especially for his recommended selections treating their coverage of general strikes, factory occupations, and from the existing historiography of Italian fascism that I cite workers’ self-defense groups as proxies for middle-class liberals’ throughout. I am also grateful to Professors Pietro Frassica and interpretations of workers’ demonstrations. By tracking changes Fiorenza Weinapple for instructing me in the Italian language 29 Historians of Italian fascism often divide the years lead- workers’ demonstrations took place during the working-class ing up to the fascists’ rise to power—from the immediate mobilization of 1919-1920, strikes—sometimes even large aftermath of the First World War at the beginning of 1919 to ones—remained a persistent phenomenon in the two years Benito Mussolini’s March on Rome in October 1922—into of violent fascist reaction that followed.7 Additionally, while two periods. -

Consensus for Mussolini? Popular Opinion in the Province of Venice (1922-1943)
UNIVERSITY OF BIRMINGHAM SCHOOL OF HISTORY AND CULTURES Department of History PhD in Modern History Consensus for Mussolini? Popular opinion in the Province of Venice (1922-1943) Supervisor: Prof. Sabine Lee Student: Marco Tiozzo Fasiolo ACADEMIC YEAR 2016-2017 2 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third parties in respect of this work are as defined by The Copyright Designs and Patents Act 1988 or as modified by any successor legislation. Any use made of information contained in this thesis/dissertation must be in accordance with that legislation and must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder. Declaration I certify that the thesis I have presented for examination for the PhD degree of the University of Birmingham is solely my own work other than where I have clearly indicated that it is the work of others (in which case the extent of any work carried out jointly by me and any other person is clearly identified in it). The copyright of this thesis rests with the author. Quotation from it is permitted, provided that full acknowledgement is made. This thesis may not be reproduced without my prior written consent. I warrant that this authorisation does not, to the best of my belief, infringe the rights of any third party. I declare that my thesis consists of my words. 3 Abstract The thesis focuses on the response of Venice province population to the rise of Fascism and to the regime’s attempts to fascistise Italian society. -

Tigr V Zgodovini in Zgodovinopisju
TIGR V ZGODOVINI IN ZGODOVINOPISJU TIGR V ZGODOVINI IN ZGODOVINOPISJU UREDIL ALEŠ GABRIČ Ljubljana 2017 TIGR v zgodovini in zgodovinopisju ZALOŽBA INZ Odgovorni urednik dr. Aleš Gabrič ZBIRKA VPOGLEDI 17 ISSN 2350-5656 Aleš Gabrič (ur.) TIGR V ZGODOVINI IN ZGODOVINOPISJU Recenzenta dr. Žarko Lazarević dr. Egon Pelikan Jezikovni pregled Ajda Gabrič Oblikovanje Barbara Bogataj Kokalj Založnik Inštitut za novejšo zgodovino Tisk Medium d.o.o. Naklada 400 izvodov Izid knjige je podprla Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije Društvo TIGR Primorske CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 94(497.4-15) TIGR v zgodovini in zgodovinopisju / uredil Aleš Gabrič. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2017. - (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656 ; 17) ISBN 978-961-6386-77-7 1. Gabrič, Aleš, 1963- 290693120 © 2017, Inštitut za novejšo zgodovino. Vse pravice so pridržane. Brez predhodnega pisnega dovoljenja izdajatelja je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev, objavljanje, predelava ali katera koli druga oblika uporabe tega dela ali njegovih delov, bodisi s fotokopiranjem, tiskanjem, snemanje ali shranitvijo in objavo v elektronski obliki. Predgovor VSEBINA Aleš Gabrič, Predgovor ........................................................................................................ 5 1 TIGR in primorski antifašizem.............................................................................7 Bojan Godeša, O primorskem antifašizmu ......................................................................... -
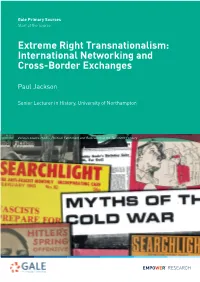
Extreme Right Transnationalism: International Networking and Cross-Border Exchanges
Gale Primary Sources Start at the source. Extreme Right Transnationalism: International Networking and Cross-Border Exchanges Paul Jackson Senior Lecturer in History, University of Northampton Various source media, Political Extremism and Radicalism in the Twentieth Century EMPOWER™ RESEARCH While many historians have devoted themselves to forms of anti-fascism: divisions within the left. The examining the dynamics of fascist movements and Italian Communist Party was also formed at this time, regimes, the topic of ‘anti-fascism’ has traditionally and while initially supportive of the Arditi del Popolo, been neglected. However, historians and other later it instructed its members to withdraw their academics are now starting to take greater interest in engagement. The Arditi del Popolo was shut down by the study of those who opposed nationalist and racist the Italian state by 1924, while the Italian Communist extremists, and are developing new approaches to Party was itself banned from 1926. Splits within the understanding these complex cultures. Some, such as left have often been a characteristic of anti-fascist Nigel Copsey, have been concerned with developing politics, and in Italy during the 1920s such anti- sober, empirical accounts, exploring left-wing, centre fascists were driven by competing ideas on how to and even right-wing forms of anti-fascism, presenting develop an anti-capitalist revolution. In this case, the it as a heterogeneous politicised identity. Others, such issue helped to foster discord between a more as Mark Bray, have been more concerned with eclectic and anarchist variant of anti-fascism and a developing unapologetically partisan readings of the more centralised Communist version. -

Socialismo E Combattentismo: La Lega Proletaria. 1918-1922
« Italia contemporanea » dicembre 1980, fase. 141 Socialismo e combattentismo: la Lega proletaria. 1918-1922 La storiografia italiana di questo secondo dopoguerra ha in più di una occasione fatto giustizia delle interpretazioni agiografiche e propagandistiche del regime fascista sul movimento combattentistico, senza tuttavia riuscire a liberarsi com pletamente dall’ipoteca di una visione riduttiva, concentrata sull’analisi della componente « nazionale » dell’organizzazione dei reduci *. L’indubbio progresso registrato dagli studi con la pubblicazione del ricco volume di G. Sabbatucci1 2 ha giustamente rivalutato la presenza all’interno delle organizzazioni nazionali di una forte ma minoritaria componente democratica di contro all’appiattimento delle analisi tradizionali tutte tese a riscontrare nel « movimento » un serbatoio di for ze proto e filo-fasciste. Tutti questi studi hanno comunque rivolto la propria analisi alle vicende politi co-istituzionali dei gruppi dirigenti, alla loro scarsa coesione politica ed ideologi ca e alla conseguente rapida caduta della parabola organizzativa; limitata atten zione è stata invece dedicata alla massa degli iscritti, alla composizione sociale, al rapporto con la società civile in generale e con i diversi partiti politici in partico lare, ai rapporti tra base e gruppi dirigenti e tra le varie organizzazioni di ispira zione combattentistica. Pur sottolineando l’accentuato antisocialismo dei pro grammi e dell’attività in generale, non se ne è mai, a mio modo di vedere, tenta to di ricollegare -

ACTA HISTRIAE 24, 2016, 4, Pp
ACTA HISTRIAE ACTA ACTA HISTRIAE 24, 2016, 4 24, 2016, 4 ISSN 1318-0185 Cena: 11,00 EUR UDK/UDC 94(05) ACTA HISTRIAE 24, 2016, 4, pp. 689-992 ISSN 1318-0185 UDK/UDC 94(05) ISSN 1318-0185 Zgodovinsko društvo za južno Primorsko - Koper Società storica del Litorale - Capodistria ACTA HISTRIAE 24, 2016, 4 KOPER 2016 ACTA HISTRIAE • 24 • 2016 • 4 ISSN 1318-0185 UDK/UDC 94(05) Letnik 24, leto 2016, številka 4 Odgovorni urednik/ Direttore responsabile/ Darko Darovec Editor in Chief: Uredniški odbor/ Gorazd Bajc, Furio Bianco (IT), Flavij Bonin, Dragica Čeč, Lovorka Comitato di redazione/ Čoralić (HR), Darko Darovec, Marco Fincardi (IT), Darko Friš, Aleksej Board of Editors: Kalc, Borut Klabjan, John Martin (USA), Robert Matijašić (HR), Darja Mihelič, Edward Muir (USA), Egon Pelikan, Luciano Pezzolo (IT), Jože Pirjevec, Claudio Povolo (IT), Vida Rožac Darovec, Andrej Studen, Marta Verginella, Salvator Žitko Urednik/Redattore/ Editor: Gorazd Bajc Prevodi/Traduzioni/ Translations: Maja Smotlak, Petra Berlot Kužner Lektorji/Supervisione/ Language Editor: Vida Rožac Darovec Stavek/Composizione/ Typesetting: Grafis trade d.o.o. Izdajatelj/Editore/ Published by: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko / Società storica del Litorale© Sedež/Sede/Address: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, SI-6000 Koper-Capodistria, Kreljeva 3 / Via Krelj 3, tel.: +386 5 6273-296; fax: +386 5 6273-296; e-mail: [email protected]; www.zdjp.si Tisk/Stampa/Print: Grafis trade d.o.o. Naklada/Tiratura/Copies: 300 izvodov/copie/copies Finančna podpora/ Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije / Slovenian Supporto finanziario/ Research Agency Financially supported by: Slika na naslovnici/ Foto di copertina/ Picture on the cover: Izrez stenske poslikave Toneta Kralja v Pnevmi, cerkev sv. -

Transnational Anarchism Against Fascisms: Subaltern Geopolitics and Spaces of Exile in Camillo Berneri’S Work Federico Ferretti
Transnational Anarchism Against Fascisms: subaltern geopolitics and spaces of exile in Camillo Berneri’s work Federico Ferretti To cite this version: Federico Ferretti. Transnational Anarchism Against Fascisms: subaltern geopolitics and spaces of exile in Camillo Berneri’s work. eds. D. Featherstone, N. Copsey and K. Brasken. Anti-Fascism in a Global Perspective, Routledge, pp.176-196, 2020, 10.4324/9780429058356-9. hal-03030097 HAL Id: hal-03030097 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03030097 Submitted on 29 Nov 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Transnational anarchism against fascisms: Subaltern geopolitics and spaces of exile in Camillo Berneri’s work Federico Ferretti UCD School of Geography [email protected] This paper addresses the life and works of transnational anarchist and antifascist Camillo Berneri (1897–1937) drawing upon Berneri’s writings, never translated into English with few exceptions, and on the abundant documentation available in his archives, especially the Archivio Berneri-Chessa in Reggio Emilia (mostly published in Italy now). Berneri is an author relatively well-known in Italian scholarship, and these archives were explored by many Italian historians: in this paper, I extend this literature by discussing for the first time Berneri’s works and trajectories through spatial lenses, together with their possible contributions to international scholarship in the fields of critical, radical and subaltern geopolitics. -

Arditi D'italia E Arditi Del Popolo
HUMANITIES – Anno III, Numero 5, Gennaio 2014 DOI: 10.6092/2240-7715/2014.1.38-47 Alessandra Grasso* L’Arditismo dopo Fiume: Arditi d’Italia e Arditi del Popolo IL 150 anniversario della nascita di D’Annunzio costituisce per me oggi1 l’occasione per affrontare un argomento che è quello dell’Arditismo che ho avuto modo di studiare, seppure marginalmente, nel corso delle mie ricerche relative alla tesi di dottorato2. Nel ricostruire la vicenda del gruppo romano di “Giustizia e Libertà” mi sono imbattuta infatti in una serie di documenti che testimoniavano come alcuni fra gli arrestati avessero fatto parte, durante la prima guerra mondiale, delle squadre d’assalto degli Arditi3. Per comprendere a pieno il fenomeno dell’Arditismo non si può prescindere dal clima politico-sociale, confuso e contraddittorio del nostro paese, nella fase compresa tra il 1917, anno in cui furono create le prime squadre d’assalto4, e la fine della prima guerra mondiale, fino ad arrivare agli sconvolgimenti radicali del biennio rosso e alla restaurazione, avvenuta con la marcia su Roma. Per dipanare la massa intricata di movimenti e associazioni che si costituirono in quel frangente è necessario cogliere i collegamenti intercorrenti * Dottoressa di Ricerca, Università degli Studi di Messina. 1 Viene qui riprodotto l’intervento esposto ai Colloqui dottorali sul tema “150 anni di D’Annunzio: il personaggio, le imprese, le opere”, Università degli Studi di Messina 11- 13 Novembre 2013. 2 La tesi è relativa alla biografia politica di Max Salvadori. 3 Tra le nove persone cui, dopo l’arresto, venne effettivamente comminata una pena, Aristide Ciccotti e Narducci Ferdinando sono schedati come ex Arditi di guerra, senza contare che anche uno dei più rappresentativi esponenti del movimento romano di Giustizia e Libertà, Francesco Fancello, fece parte delle truppe d’assalto 4 I reparti d’assalto nacquero nel campo di Sdricca di Manzano, all’interno della seconda armata, su iniziativa dei generali Capello e Grazioli e del tenente colonello Bassi. -
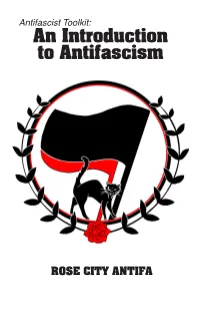
An Introduction to Antifascism
Antifascist Toolkit: An Introduction to Antifascism ROSE CITY ANTIFA Introduction We wrote this zine in Spring of 2021 in the immediate wake of the Trump presidency, the January 6th insurrection at the Capitol, and the mass Black Lives Matter uprisings against police brutality. Over the last year it’s been heartening to us to see so many people identifying themselves as antifascists. While individuals and groups may have their own definitions of antifascism, we’ve created this zine as a guide for new antifascists (or for those who have just learned the term) in order to provide Rose City Antifa’s answer to the question: “what is antifascism?” Rose City Antifa breaks antifascist work into three main categories: direct action, solidarity work with other liberatory groups, and community education. All these tactics build upon each other to create a world free of fascist ideology. RCA 1 Introduction RCA 2 The Historical Roots of Antifascism Antifascism as an organized movement began in Europe in the 1920s, first in Italy in response to the rise of Benito Mussolini’s dictatorship, and then throughout Europe as a response to the growing Axis influence and increasing threat of ethnic cleansing. In 1932, the Communist Party of Germany (KPD) established Antifaschistiche Aktion as a militant wing united against the fascist influence in their country. The double flag logo used by the KPD is still used today in antifascist organizing. In the United States, the contemporary iteration of Antifascist Action began in the 1980s with Anti Racist Action. ARA had a lot of crossover with the punk scene, and disrupted white supremacist gangs in street- level confrontation and in subcultural spaces like venues. -

Pasado Y Memoria. Revista De Historia Contemporánez
De “caballeros de la mUerte” a la “lUcha por la vida”. Los arditi italianos, de la gUerra a la militancia antifascista 1 From ‘Death Knights’ to the ‘StrUggle for Life’. Italian Arditi, from War to Anti-fascism Eros Francescangeli Università di PeruGia [email protected] Recibido: 31-I-2016 Aceptado: 5-IX-2016 ResUmen El artículo aborda la historia de los arditi en la Italia posterior a la Primera Guerra Mundial: tropas de elite desarrolladas en el ejército italiano desde 1917. Los arditi en la posGuerra se convirtieron en un violento Grupo político que suele relacionarse en la historioGrafía de manera unidireccional con el fascismo. El artículo demuestra una realidad mucho más compleja, centrándose en la trayectoria de Grupos antifascistas llamados Arditi del popolo , creados en reacción a la amenaza fascista. Se examinan las características de las mentalidades de los arditi durante la posGuerra italiana en el marco de las asociaciones de excombatientes, señalando concomitancias y puntos de ruptu ra entre aquellos ex- arditi que decidieron apoyar el fascismo, y aquellos que se convir tie - ron al antifascismo. Palabras clave : Arditi, Paramilitarismo, Fascismo, Antifascismo, Primera Guerra Mun - dial, Italia. Abstract This article deals with the history of the Italian Arditi –elite troops in the Italian Army since 1917– after World War I. Postwar A rditi became a violent political Group in the 1. Traducción: MiGuel Palou Espinosa. Pasado y Memoria . Revista de Historia Contemporánea, 15, 2016, pp. 73-97 DOI: 10.14198/PASADO2016.15.03 74 Eros FrancescanGeli Italian Army often related directly to Fascism. This articles explores a much more com - plex reality by focusinG on the trajectory of antifascist Groups ( Arditi del popolo ), crea - ted as a response to Fascism threat. -

War in Peace Paramilitary Violence in Europe After the Great War
War in Peace Paramilitary Violence in Europe after the Great War Edited by ROBERT GERWARTH AND JOHN HORNE OXFORD UNIVERSITY PRESS OXFORD UNIVERSITY PRESS Great Clarendon Street, Oxford, 0X2 6DP, United Kingdom Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University’s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide. Oxford is a registered trade matk of Oxford University Press in the UK and in certain other countries © Oxford University Press 2012 The moral rights of the author have been asserted First Edition published in 2012 impression: 2 Ail rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press, or as expressly permitted by law, by licence or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization. Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to the Rights Department, Oxford University Piess, at the address above You must not circulate this work in any other form and you must impose this same condition on any acquirer British Library Cataloguing in Publication Data Data available Library of Congress Cataloging in Publication Data Data available ISBN 978—0—19—965491—8 Printed in Great Britain by MPG Books Group, Bodmin and King’s Lynn Acknowledgements This book is the result of collaborative efforts over a long period. Most of the authors assembled in this volume met at two themed workshops, held in Dublin in 2008 and 2010.