Serena Romano
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Schede Di Presentazione Delle Ville Venete Proposte Per L’Inserimento Negli Itinerari Di Visita Culturale
Villa di Montruglio Via Montruglio 9 36024 Mossano (VI) Cod Fisc: 94025480271 Tel: 0444/1836858 Fax: 0444/776138 Allegato alla Relazione dell’Associazione Ville Venete alla Direzione Regionale del Turismo 19 Dicembre 2008 SCHEDE DI PRESENTAZIONE DELLE VILLE VENETE PROPOSTE PER L’INSERIMENTO NEGLI ITINERARI DI VISITA CULTURALE 1. ELENCO DELLE VILLE VENETE PROPOSTE PER L’INSERIMENTO NEGLI ITINERARI DI VISITA CULTURALE PROVINCIA PADOVA 1. Ca' Marcello – Levada di Piombino Dese 2. Castello del Catajo – Battaglia Terme 3. Castello di San Pelagio – Terradura di Due Carrare 4. Giardini di Villa Emo – Rivella 5. Giardini di Villa Pizzoni Ardemani - Valsanzibio di Galzignano Terme 6. Villa Contarini – Piazzola sul Brenta 7. Villa Cornaro – Piombino Dese 8. Villa Emo Capodilista “la Montecchia” – Selvazzano Dentro 9. Villa Pisani Bolognesi Scalabrin – Vescovana PROVINCIA ROVIGO 10. Villa Badoer “la Badoera" – Fratta Polesine PROVINCIA TREVISO 11. Castello di Roncade – Roncade 12. Villa di Maser – Maser 13. Villa Emo – Fanzolo di Vedelago 14. Villa Tiepolo Passi – Carbonera PROVINCIA VENEZIA 15. Museo Nazionale di Villa Pisani – Stra 16. Villa Foscari "la Malcontenta" – Malcontenta 17. Villa Foscarini Rossi – Stra 18. Villa Widmann Rezzonico Foscari – Mira PROVINCIA VERONA 19. Giardino di Villa Giusti – Verona 20. Villa Arvedi – Grezzana 21. Villa La Mattarana - Verona 22. Villa Sagramoso Perez Pompei – Illasi PROVINCIA VICENZA 23. Castello Porto Colleoni Thiene – Thiene 24. Villa Almerico Capra detta "la Rotonda" – Vicenza 25. Villa Caldogno – Caldogno 26. Villa Cordellina Lombardi – Montecchio Maggiore 27. Villa da Schio – Costozza di Longare 28. Villa di Montruglio – Mossano 29. Villa Fracanzan Piovene – Orgiano 30. Villa Godi Malinverni – Lugo di Vicenza 31. Villa Loschi Zileri – Monteviale 32. -

Bibliografia Veronese 2009 2011 Viviani Volpato UV 2014.Indd
G. F. VIVIANI ACCADEMIA DI AGRICOLTURA SCIENZE E LETTERE DI VERONA G. VOLPATO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA BIBLIOGRAFIA VERONESE BIBLIOGRAFIA VERONESE (2009-2011) (2009-2011) di GIUSEPPE FRANCO VIVIANI e GIANCARLO VOLPATO Supplemento al vol. 185° degli Atti e Memorie dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona MMXIV VERONA · MMXIV ISBN 978-88-98513-63-5 Volumi pubblicati della “Bibliografia Veronese” Volume I: 1966-1970 (esaurito) Volume II: 1971-1973 (esaurito) Volume III: 1974-1987 (esaurito) Volume IV: 1988-1992 (esaurito) Volume V: 1993-1996 (esaurito) Volume VI: 1997-1999 (esaurito) cd: 1966-1999 (esaurito) Volume VII: 2000-2002 (esaurito) Volume VIII: 2003-2005 Volume IX: 2006-2008 Volume X: 2009-2011 ACCADEMIA DI AGRICOLTURA SCIENZE E LETTERE DI VERONA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA BIBLIOGRAFIA VERONESE (2009-2011) di GIUSEPPE FRANCO VIVIANI e GIANCARLO VOLPATO Supplemento al vol. 185° degli Atti e Memorie dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona VERONA · MMXIV Pubblicato con il contributo del Fondo di ricerca (ex 60%) © 2014 - Dipartimento Tempo Spazio Immagine Società (TeSIS) Università degli Studi di Verona Impaginazione e stampa: Tipolitografia «La Grafica», Vago di Lavagno (Verona) ISBN 978-88-98513-63-5 INDICE Presentazione 7 Al Lettore 9 Selezione dalla critica: non per gloria né per interesse 11 Abbreviazioni 25 Avvertenza 29 Piano di classificazione 31 schede bibliografiche Generalità 41 Filosofia e discipline connesse 53 Religione 56 Scienze sociali 71 Linguistica 115 Scienze pure 120 Tecnologia (Scienze applicate) 129 Arti 135 Letteratura 206 Storia e Geografia 239 Indice degli autori 401 Indice dei soggetti 429 PRESENTAZIONE Sono trascorsi molti anni da quando i due autori della Bibliografia veronese hanno cominciato a lavorare assieme: siamo stati abituati, ormai, ad aspetta- re, a ritmi cadenzati ma sempre precisi, i loro volumi. -

Paolo Veronese a San Bernardino Di Verona
ALESSANDRA ZAMPERINI PAOLO VERONESE A SAN BERNARDINO DI VERONA ABSTRACT - The paper is focused on the beginnings of Paolo Veronese, showing that his Raising of Jairus’Daughter for San Bernardino (1546 c.) was favored by the painter’s relations with Antonio Badile. In addition, thanks to the Badile family, Paolo could be in touch with some of his first patrons and with his most famous friend, Michele Sanmicheli. KEY WORDS - Paolo Veronese, Antonio Badile, Michele Sanmicheli, Canossa family, Della Torre family. RIASSUNTO - L’articolo tratta degli esordi di Paolo Veronese, evidenziando come la sua Resurrezione della Figlia di Giairo eseguita per San Bernardino (1546 c.) fosse stata favorita dai rapporti che legavano il pittore ad Antonio Badile. Attraverso le relazioni dei Badile, inoltre, Paolo poté entrare in contatto con alcuni dei suoi primi committenti e con il suo più celebre mentore, vale a dire Michele Sanmicheli. PAROLE CHIAVE - Paolo Veronese, Antonio Badile, Michele Sanmicheli, Canossa famiglia, Della Torre famiglia. Non era raro, in passato, che i lavori si prolungassero per tempi lun- ghissimi, ma chissà se Bartolomeo Avanzi, predisponendo nel 1492 l’in- nalzamento della cappella familiare a San Bernardino, poteva immagi- nare che il completamento di quell’impresa avrebbe richiesto oltre cin- quant’anni (1). Legenda delle abbreviazioni: ASVr=Archivio di Stato di Verona. T= Antico Ufficio del Registro, Testamenti. (1) Per la cappella Avanzi (in merito alla commissione fondativa, alla decorazione e alla storia più tarda) si rimanda a R. BRENZONI, L’organo dei Rossi e la cappella degli 212 Atti Acc. Rov. Agiati, a. 262 (2012), ser. -
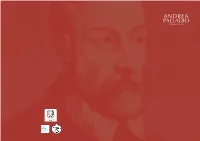
4184 F Palladio.Pdf
O 1508-1580 Andrea Palladio 1508-1580 ANDREA PALLADIO 1508-1580 ANDREA PALLADIO 1508-1580 First published in 2010 by The Embassy of Italy. Designed by: David Hayes. Typeface: Optima. Photographer: Pino Guidolotti. Photographer Lucan House: Dave Cullen. © The Embassy of Italy 2011. All rights reserved. No part of this book may be copied, reproduced, stored in a retrieval system, broadcast or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior permission of the copyright owners and the publishers. Lucan House, Co. Dublin Palladianism and Ireland NDREA PALLADIO GAVE HIS NAME to a style of architecture, Palladianism, whose most obvious Afeatures – simple lines, satisfying symmetry and mathematical proportions – were derived from the architecture of antiquity and particularly that of Rome. From the seventeenth century onwards Palladianism spread across Europe, with later examples to be found as far afield as America, India and Australia. Irish Palladianism has long been recognised as a distinctive version of the style. Editions of Palladio’s Quattro Libri dell’Architettura were second in popularity only to editions of Vitruvius amongst the Irish architects and dilettanti of the eighteenth century but, fittingly, it was another Italian, Alessandro Galilei, who may be said to have introduced the style to Ireland at Castletown, Co. Kildare (under construction from 1722). Thus began a rich tradition of Palladianism in Irish country house architecture, with notable examples at Bellamont Forest, Co. Cavan (c.1730), Russborough, Co. Wicklow (1742), and Lucan House, Co. Dublin (1773), now the Residence of the Ambassador of Italy. Ireland can also boast, in the facade of the Provost’s House, Trinity College Dublin, the only surviving example of a building erected to a design by Palladio outside his native Italy. -

Fama, Artes, Memoria. Künstlerische Selbstinszenierung Im Italien Des
fama, artes, memoria Künstlerische Selbstinszenierung im Italien des 16. Jahrhunderts in Venedig, Verona und Florenz Inauguraldissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München vorgelegt von Theda Jürjens aus Aurich 2016 Erstgutachter: Prof. Dr. Ulrich Pfisterer Zweitgutachter: Prof. Dr. Philipp Zitzlsperger Datum der mündlichen Prüfung: 27. Juni 2016 Vorwort Die vorliegende Arbeit ist die überarbeitete und gekürzte Fassung meiner im Jahr 2016 an der Ludwig-Maximilians-Universität München angenommenen Dis- sertation. Danach erschienene Publikationen konnten nur in Ausnahmefällen in- tegriert werden. Sollten trotz sorgfältiger Recherchen Rechteinhaber von Abbildungen nicht kor- rekt angeführt sein, bitte ich die Betroffenen, sich mit mir in Verbindung zu set- zen. Mein aufrichtiger Dank gebührt meinem Doktorvater Prof. Dr. Ulrich Pfisterer und dem Zweitgutachter Prof. Dr. Philipp Zitzlsperger für die Betreuung meiner Arbeit und ihre Unterstützung. Ich danke des Weiteren dem Evangelischen Studienwerk Villigst und dem Deut- schen Studienzentrum in Venedig / Centro Tedesco di Studi Veneziani für die großzügig gewährten Stipendien. Darüber hinaus sei allen von Herzen gedankt, die mich auf meinem Weg begleitet, ermutigt und mir Rückhalt geboten haben - insbesondere meinen Eltern und mei- nen Freunden. Theda Jürjens Dresden / Berlin 2019 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis I. Einleitung .................................................................................................... -

The Allegorical Landscape Alvise Cornaro and His Self-Promotion by the Landscape Paintings in the Odeo Cornaro in Padua
Open Peer Reviewed Journal, www.kunstgeschichte-ejournal.net SÖREN FISCHER The Allegorical Landscape Alvise Cornaro and his Self-Promotion by the Landscape Paintings in the Odeo Cornaro in Padua I Summary The present study deals with the illusionistic landscape paintings in the villa-like Odeo Cornaro of Padua.1 Commissioned by the author, patron of arts and land owner Alvise Cornaro, and executed by Lambert Sustris (c. 1505/1510–c. 1585) and Gualtiero Padovano (c. 1505/10–1552/1553) around 1540/1541, these frescos created for the first time the life-sized pictorial illusion of views onto surrounding landscapes in the Venetian Republic of the 16th century. It is the aim of this study to highlight these frescos as important instruments in Alvise Cornaros self-representation and as allegorical comments on his extensive activities in land cultivation for the good of the Venetian Republic and its people. >1< II Introduction: The Odeo Cornaro in Padua In the first half of the cinquecento, Alvise Cornaro, born in Venice (c. 1484–1566) as son of Antonio di Giacomo and Angeliera Angelieri, belonged next to Gian Giorgio Trissino and Daniele Barbaro to the high class of humanistic society in the Venetian Republic, yet he was never accepted as an aristocrat (Ill. 1).2 Although he tried to prove his aristocracy to the authorities throughout his life, his name was never to be put into the Golden Book of the Republic.3 Aristocracy remained denied to him. Agriculture and the reclamation of land were central elements of Alvise's life:4 For him, agriculture, or as he expressed with the term santa agricoltura5 referring to the ancient Roman authors on agriculture such as Publius Vergilius Maro and Lucius Iunius Moderatus Columella, signified independence and power for both the individual and the entire state of Venice. -

Andrea Palladio E Verona • Committenti, Progetti, Opere
Andrea Palladio e Verona Committenti, progetti, opere Andrea Palladio e Verona • Committenti, progetti, opere Ricerca condotta nell’ambito di un Dotto- Cero, Giuliana Fontanella, Michele Garzon, La pubblicazione del volume rato di ricerca dell’Università degli Studi di Mattea Gazzola, Vincenzo Giuliano, Paola è stata sostenuta da Verona, XXV ciclo, 2010-2012 Marini, Stefania Mastella, Guerrino Macca- gnan, Loredana Olivato, Marco Ottaviani, Crediti fotografici: Chiara Panizzi, Marco Pasa, Gianni Peretti, Archivio dell’Associazione Adige Nostro, Lionello Puppi, Gianni e Antonella Rigo- pp. 105, 276, 281, 282, 283; Archivio CDSV, danzo, Sara Rodella, Silvino Salgaro, Raffaele Centro di Documentazione per la Storia del- Santoro, Adele Scarpari, Jessica Soprana, Ca- la Valpolicella (Andrea Brugnoli, Renato Ce- rolina di Serego, Violante di Serego, Pier Al- vese, Renzo Nicolis, Michele Suppi, Giovan- vise Serego Alighieri, Arianna Strazieri, Gil- ni Viviani), pp. 37, 44, 88, 154, 155, 159, 176, berto Tommasi, Graziana Tondini, Daniela 193-201, 205; Archivio di Stato di Venezia Tovo, Luca Trevisan, Alessandra Zamperini (Prot. 7710 - 28.13.07/1 del 31 ottobre 2013 e del 20 novembre 2013; prot. 8716 del 23 Si ringrazia inoltre: dicembre 2013 - sezione di fotoriproduzione il personale dell’Archivio di Stato di Venezia; dell’Archivio di Stato di Venezia), pp. 86, 87, il personale dell’Archivio di Stato di Vicenza; 118, 266, 298, 320-321; Archivio di Stato di il personale dell’archivio di stato di Verona; Verona (Concessione n.19/13 del 22 luglio il personale Biblioteca Civica di Verona; il 2013 - fotografie di Vincenzo Giuliano), pp. personale della Biblioteca Bertoliana di Vi- 75, 96, 106, 147, 166, 267, 322, 323, 324, 325; cenza; il personale della Biblioteca Capitolare Archivio fotografico del Museo di Castel- di Verona vecchio (aut. -
LE VILLE DEL PALLADIO Elenco
LE VILLE DEL PALLADIO Elenco Le 24 ville palladiane del Veneto, che tra il 1994 e il 1996 sono state inserite nella lista Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO : 1. Villa Almerico Capra , detta La Rotonda (Vicenza) 2. Villa Gazzotti Grimani (Vicenza località Bertesina) 3. Villa Angarano , conosciuta anche come Villa Bianchi Michiel (Bassano del Grappa, provincia di Vicenza) 4. Villa Caldogno (Caldogno, provincia di Vicenza) 5. Villa Chiericati (Vancimuglio di Grumolo delle Abbadesse, provincia di Vicenza) 6. Villa Forni Cerato (Montecchio Precalcino, provincia di Vicenza) 7. Villa Godi (Lonedo di Lugo di Vicenza, provincia di Vicenza) 8. Villa Pisani (Bagnolo di Lonigo, provincia di Vicenza) 9. Villa Pojana (Pojana Maggiore, provincia di Vicenza) 10. Villa Saraceno (Agugliaro, provincia di Vicenza) 11. Villa Thiene (Quinto Vicentino, provincia di Vicenza) 12. Villa Trissino (Meledo di Sarego, provincia di Vicenza) 13. Villa Trissino (Vicenza, località Cricoli) non è attualmente attribuita a Palladio, ma rimane legata tradizionalmente al suo nome 14. Villa Valmarana (Lisiera di Bolzano Vicentino, provincia di Vicenza) 15. Villa Valmarana (Vigardolo di Monticello Conte Otto, prov. di Vicenza) 16. Villa Piovene (Lugo di Vicenza, provincia di Vicenza) 17. Villa Badoer , detta La Badoera (Fratta Polesine, provincia di Rovigo) 18. Villa Barbaro (Maser, provincia di Treviso) 19. Villa Emo (Vedelago, provincia di Treviso) 20. Villa Zeno (Cessalto, provincia di Treviso) 21. Villa Foscari , detta La Malcontenta (Mira, provincia di Venezia) 22. Villa -

Dottorato Di Ricerca in Storia Antica E Archeologia. Storia Dell'arte Ciclo XXII
Dottorato di ricerca in Storia Antica e Archeologia. Storia dell’Arte Ciclo XXII (A.A. 2006/2007 - 2008/2009) ASPETTI DELLA COMMITTENZA VENEZIANA IN RIFERIMENTO ALL'OPERA DI BATTISTA ZELOTTI SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE DI AFFERENZA: L-ART/04 Tesi di dottorato di Alessandra Lotto, matricola 955385 Coordinatore del Dottorato Tutore del dottorando Prof. Giuseppe Barbieri Prof. Sergio Marinelli 1 Alessandra Lotto Aspetti della committenza veneziana in riferimento all'opera di Battista Zelotti Sommario: Introduzione Capitolo 1 Fuggevolezza del pittore e silenzio delle fonti Capitolo 2 I committenti veronesi e veneziani di Battista Zelotti 2.1.I Malaspina a Verona 2.2.Antonio di Giovanni Battista Cappello 2.3.La famiglia Soranzo 2.4.Alvise di Federico Foscari 2.5.Leonardo di Alvise Emo 2.6.Camillo di Bernardo Trevisan 2.7.Alvise di Girolamo Cùccina Capitolo 3 3.1.Il nome del pittore nelle fonti storiche e documentarie 3.2.Possibili esordi veronesi di Battista Zelotti a San Giovanni in Sacco Capitolo 4 Battista Zelotti e Antonio Cappello 4.1.Tra pubblico e privato. La committenza veneziana 2 4.2.Antonio Cappello procuratore di San Marco de supra Capitolo 5 La decorazione della libreria antica dell’abbazia di Santa Maria di Praglia. 5.1.Ricostruzione dell’originaria disposizione dei dipinti nella Biblioteca e coordinate cronologiche per la commissione 5.2.La decorazione della Biblioteca e il suo programma iconologico 5.3.Orientamenti culturali e tradizione libraria cassinese 5.4.L’Ordine Benedettino e la riforma cattolica Capitolo 6 Documenti d'archivio 6.1.Testamento di Antonio Cappello procuratore di San Marco 6.2.Condizione di decima di Antonio Cappello procuratore di San Marco 6.3.Testamento di Giovanni Battista q. -

BIBLIOGRAFIA VERONESE BIBLIOGRAFIA VERONESE (2012-2015) (2012-2015) Di GIUSEPPE FRANCO VIVIANI E GIANCARLO VOLPATO
G. F. VIVIANI ACCADEMIA DI AGRICOLTURA SCIENZE E LETTERE DI VERONA G. VOLPATO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA BIBLIOGRAFIA VERONESE BIBLIOGRAFIA VERONESE (2012-2015) (2012-2015) di GIUSEPPE FRANCO VIVIANI e GIANCARLO VOLPATO Supplemento al vol. 187° degli Atti e Memorie dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona MMXVI VERONA · MMXVI ISBN 978-88-6947-146-9 Copertina Bibliografia Veronese 2009 2011 Viviani Volpato UV 2014.indd 1 21/12/16 14:14 Volumi pubblicati della “Bibliografia Veronese” Volume I: 1966-1970 (esaurito) Volume II: 1971-1973 (esaurito) Volume III: 1974-1987 (esaurito) Volume IV: 1988-1992 (esaurito) Volume V: 1993-1996 (esaurito) Volume VI: 1997-1999 (esaurito) cd: 1966-1999 (esaurito) Volume VII: 2000-2002 (esaurito) Volume VIII: 2003-2005 Volume IX: 2006-2008 Volume X: 2009-2011 Volume XI: 2012-2015 ACCADEMIA DI AGRICOLTURA SCIENZE E LETTERE DI VERONA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA BIBLIOGRAFIA VERONESE (2012-2015) di GIUSEPPE FRANCO VIVIANI e GIANCARLO VOLPATO Supplemento al vol. 187° degli Atti e Memorie dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona VERONA · MMXVI Pubblicato con il contributo di ACCADEMIA DI AGRICOLTURA DIPARTIMENTO SCIENZE E LETTERE DI VERONA CULTURE E CIVILTÀ © 2016 Impaginazione e stampa: Tipolitografia «La Grafica», Vago di Lavagno (Verona) ISBN 978-88-6947-146-9 INDICE Presentazione di Claudio Carcereri de Prati 7 Presentazione di Giampaolo Romagnani 8 Al Lettore 9 Abbreviazioni 15 Avvertenza 19 Piano di classificazione 21 schede bibliografiche Generalità 31 Filosofia e discipline connesse 43 Religione 48 Scienze sociali 68 Linguistica 127 Scienze pure 132 Tecnologia (Scienze applicate) 143 Arti 148 Letteratura 254 Storia e Geografia 300 Indice degli autori 525 Indice dei soggetti 559 PRESENTAZIONE Con l’uscita di questo undicesimo volume la Bibliografia Veronese cessa la pro- pria pubblicazione; ne rendono conto dei motivi gli autori stessi nella loro “Nota al lettore”. -

Approfondimento Le Ville Di Andrea Palladio
Approfondimento Le ville di Andrea Palladio L’evoluzione della campagna minacciava il suo predominio commerciale nel nell’entroterra veneto Mediterraneo orientale, quindi con la scoperta tra Quattro e Cinquecento dell’America e lo spostamento del baricentro del La nascita del modello abitativo della villa e la mondo dal Mediterraneo alle coste atlantiche. sua diffusione nella campagna veneta deriva dai Gli interessi politici ed economici di Venezia si mutamenti economici e politici che hanno investito spostarono così verso occidente, con investimenti i territori sottoposti al dominio della Serenissima pubblici che si affiancarono all’iniziativa privata: Repubblica di Venezia tra la seconda metà del il rilevamento cartografico della rete idrica dei Quattrocento e i primi decenni del Cinquecento, possedimenti di terraferma, ordinato per decreto determinando la trasformazione del paesaggio nel 1460, le opere di bonifica e la ridefinizione agrario in quell’area. della rete infrastrutturale fino all’introduzione di All’inizio del XV secolo Venezia si era imposta più moderne tecniche di coltivazione. sulle Signorie di terraferma comprese tra il Po e il In questo processo di ridefinizione economica e Mincio; nel 1428, con la conquista di Bergamo, territoriale le ville svolsero un ruolo di primo piano: i suoi possedimenti arrivarono fino all’Adda, ai esse, infatti, diventarono i nodi di una fitta rete di confini del Ducato di Milano. L’imposizione della trasporti, sia via acqua sia via terra. La diffusione pace interna e l’avvio di una politica -

Andrea Palladio, His Life and Works
Librairie des Arts D6coratifs & Industrie^ ANDREA PALLADIO fa fix » ANDREA PALLADIC/ HIS LIFE AND WORKS BANISTER F.' FLETCHER A.R.I.B.A., ARCHITECT LECTURER ON ARCHITECTURE AT THE ARCHITECTURAL ASSOCIATION; UNIVERSITY EXTENSION LECTURER ON ARCHITECTURE ; AND FORMERLY LECTURER AT KING'S COLLEGE, LONDON; R.I.B.A. GODWIN BURSAR, 1893; TITE MEDALLIST, 1895; ESSAY MEDALLIST. 1896; PAST VICE-PRESIDENT OF THE ARCHITECTURAL ASSOCIATION LONDON GEORGE BELL AND SONS 1902 CHISWICK PRESS: CHARLES WHITTINGHAM AND CO. TOOKS COURT, CHANCERY LANE, LONDON. — FOREWORDS MANY attempts have been made at various times to write the life of this great architect of the Renaissance, but it has been difficult to glean from any of these sources authentic details of his daily life which might prove of interest to the general reader. After a long and careful consideration of these bio- graphies, I am inclined to agree with Calvi, 1 that no one has ever written a better one than Paolo Gualdo, whose father Nicolo Gualdo—was a contemporary of Palladio, living at Vicenza at the same time. He must consequently have had many opportunities of acquiring accurate information re- garding the incidents of his life holding much the same ; position in regard to Palladio as Manetti held in regard to Brunelleschi, though unfortunately Paolo Gualdo (whose work is compiled from notes taken by his father at the time) does not give the same detailed account which Manetti furnishes of the life of the great Brunelleschi. Furthermore, knowing the high position held by the Gualdo family, and their great integrity, I am in favour of accepting his statements with all confidence, and some of 2 the information found in his book is therefore given here.