Appunti Di Astronomia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
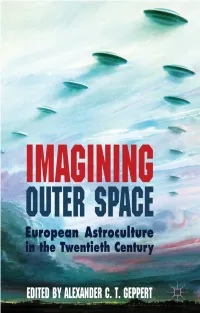
Imagining Outer Space Also by Alexander C
Imagining Outer Space Also by Alexander C. T. Geppert FLEETING CITIES Imperial Expositions in Fin-de-Siècle Europe Co-Edited EUROPEAN EGO-HISTORIES Historiography and the Self, 1970–2000 ORTE DES OKKULTEN ESPOSIZIONI IN EUROPA TRA OTTO E NOVECENTO Spazi, organizzazione, rappresentazioni ORTSGESPRÄCHE Raum und Kommunikation im 19. und 20. Jahrhundert NEW DANGEROUS LIAISONS Discourses on Europe and Love in the Twentieth Century WUNDER Poetik und Politik des Staunens im 20. Jahrhundert Imagining Outer Space European Astroculture in the Twentieth Century Edited by Alexander C. T. Geppert Emmy Noether Research Group Director Freie Universität Berlin Editorial matter, selection and introduction © Alexander C. T. Geppert 2012 Chapter 6 (by Michael J. Neufeld) © the Smithsonian Institution 2012 All remaining chapters © their respective authors 2012 All rights reserved. No reproduction, copy or transmission of this publication may be made without written permission. No portion of this publication may be reproduced, copied or transmitted save with written permission or in accordance with the provisions of the Copyright, Designs and Patents Act 1988, or under the terms of any licence permitting limited copying issued by the Copyright Licensing Agency, Saffron House, 6–10 Kirby Street, London EC1N 8TS. Any person who does any unauthorized act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages. The authors have asserted their rights to be identified as the authors of this work in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. First published 2012 by PALGRAVE MACMILLAN Palgrave Macmillan in the UK is an imprint of Macmillan Publishers Limited, registered in England, company number 785998, of Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 6XS. -
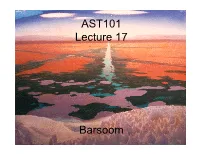
AST101 Lecture 17 Barsoom
AST101 Lecture 17 Barsoom There are 4 Terrestrial Planets • Mercury • Venus • Earth • Mars Mercury From the Messenger Orbiter, March 2011. Rayed crater: Debussy Venus From the Venus Express, 2007. H2SO4 clouds Earth (Terra) Apollo 17 Mars Hubble Space Telescope Barsoom A world like our own? Populated by aliens? Telescopic Observations Mars is dynamic • Polar caps wax and wane • Surface features change shape regularly • Clouds obscure the surface Giovanni Schiaparelli Published a map of Mars in 1877 Identified surface features he called “canali” Schiaparelli’s Mars Percival Lowell Mistranslated “canali” (channels) as canals Established Lowell Observatory on Mars Hill, Flagstaff AZ Lowell’s map of Mars (excerpt) Lowell’s Mars Canals imply • intelligent life, and • deliberate construction Lowell created a Mars that is • a dying planet, • whose intelligent denizens built canals – to collect the melting polar ice, and – to distribute the water among the oases Camille Flammarion (1884) Chesley Bonestell: Surface of Mars © Bonestell Space Art No one would have believed in the last years of the nineteenth century that this world was being watched keenly and closely by intelligences greater than man's and yet as mortal as his own; that as men busied themselves about their various concerns they were scrutinised and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinise the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. H. G. WELLS THE WAR OF THE WORLDS Illusions of Mars. I. This mythos arose from two optical illusions. 1. The human brain tends to connect the dots, which results in apparent linear features. -

Science Fictional the Aesthetics of Science Fiction Beyond the Limits of Genre
Science Fictional The Aesthetics of Science Fiction Beyond the Limits of Genre Andrew Frost University of NSW | College of Fine Arts PhD Media Arts 2013 4 PLEASE TYPE Tl<E UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES Tht:tltiDittorUdon Sht•t Surname or Fenily name: Frost FIRI neme; Andrew OCher namels: Abbr&Yia~lon fof" dcgrco as given in the Unlverslty caltn<S:ar. PhD tCOde: 1289) Sd'IOOI; Seh.ool Of Media Arts Faculty; Coll999 of A ne Am Title: Science Fletfonar.: The AestheUes or SF Beyond the Limit:t of Gcnt'O. Abstract 350 words maximum: (PLEASE TYPE) ScMtnce Flcdonal: The Anthetics of SF Beyond the Umlts of Genre proposes that oonte~my eufture 1$ * $pallal e)Cl>ertence dom1nS'ed by an aesane(IC or science liction and its qua,;.genefic form, the ·$dence ficdonal', The study explores the connective lines between cultural objects suet! as film, video art. painting, illustration, advertising, music, and children's television in a variety ofmediums and media coupled with research that conflates aspects of ctitical theory, art history a nd cuttural studies into a unique d iscourse. The study argues thai three types of C\lltural e ffeets reverberation. densi'ly and resonanoe- affect cultural space altering ood changing the 1ntel'l)totation and influeooe of a cuUural object Through an account of the nature of the science fictional, this thesis argues that science fiction as wo uncJersland It, a.nd how 11 has beon oooventionally concefved, is in fact the counter of its apparent function within wider culture. While terms such as ·genre~ and ·maln-stream• suggest a binary of oentre and periphery, this lh-&&is demonstrates that the quasi-generic is in fact the dominant partner in the process of cultural production, Ocelamlon ,.~ lo disposition or projoct thnlsJdtuen.tlon I htrOby grltlt t<> I~ Ul'll\IOI'IiiY Of Now SOUIJ'I WaltS or i&& agents the rlg:tlllo ard'llve anct to INike available my ttwrsl9 or di$sertabon '" whole or in 1»Jt il'lllle \Jtlivetsay lbrsrles., at IOtmS Of tnedb, rtOW or hero <~~Ot kncwn, 5tAijod:.lo lho Jl«Mdonll ol lho Co9yrlghlt Act 1968. -

Hearst Corporation Los Angeles Examiner Photographs, Negatives and Clippings--Portrait Files (A-F) 7000.1A
http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/c84j0chj No online items Hearst Corporation Los Angeles Examiner photographs, negatives and clippings--portrait files (A-F) 7000.1a Finding aid prepared by Rebecca Hirsch. Data entry done by Nick Hazelton, Rachel Jordan, Siria Meza, Megan Sallabedra, and Vivian Yan The processing of this collection and the creation of this finding aid was funded by the generous support of the Council on Library and Information Resources. USC Libraries Special Collections Doheny Memorial Library 206 3550 Trousdale Parkway Los Angeles, California, 90089-0189 213-740-5900 [email protected] 2012 April 7000.1a 1 Title: Hearst Corporation Los Angeles Examiner photographs, negatives and clippings--portrait files (A-F) Collection number: 7000.1a Contributing Institution: USC Libraries Special Collections Language of Material: English Physical Description: 833.75 linear ft.1997 boxes Date (bulk): Bulk, 1930-1959 Date (inclusive): 1903-1961 Abstract: This finding aid is for letters A-F of portrait files of the Los Angeles Examiner photograph morgue. The finding aid for letters G-M is available at http://www.usc.edu/libraries/finding_aids/records/finding_aid.php?fa=7000.1b . The finding aid for letters N-Z is available at http://www.usc.edu/libraries/finding_aids/records/finding_aid.php?fa=7000.1c . creator: Hearst Corporation. Arrangement The photographic morgue of the Hearst newspaper the Los Angeles Examiner consists of the photographic print and negative files maintained by the newspaper from its inception in 1903 until its closing in 1962. It contains approximately 1.4 million prints and negatives. The collection is divided into multiple parts: 7000.1--Portrait files; 7000.2--Subject files; 7000.3--Oversize prints; 7000.4--Negatives. -

Teacher Exhibition Notes Moving to Mars
TEACHER EXHIBITION NOTES MOVING TO MARS 18 OCTOBER 2019 - 23 FEBRUARY 2020 TEACHER NOTES These teacher notes are extracted from the exhibition text. The introduction, section headers and captions are as found in Moving to Mars. The exhibition is split into six sections within which sub sections focus on key groups of objects such as ‘Pressure suits and spacesuits’ and ‘Eating in Space’. These sections are represented in these notes but the expanded text can be found in the exhibition. A few exhibits from each category have been selected to enable you to guide your students’ journey around the exhibition and point of some exhibits of interest as you go. If you would like a more in-depth look around the exhibition, then you may be a free preliminary visit once you have made your group booking. We do not run tours of our galleries but our visitor experience assistants who are based in the galleries are knowledgeable on much of the content. Photography and cinematography is permitted in the gallery without the use of a flash. Dry sketching is allowed. No food or drink is allowed in the gallery. Please do not touch any objects unless instructed to do so in gallery signage. 1. IMAGANING MARS Mars is the most striking planet in the night sky. Its reddish glow and wandering motion fascinated ancient astronomers. Mars promised fire, destruction and war. From early maps to Hollywood film posters, the ways we have represented the Red Planet reflect our shifting understanding of it. As telescopes developed, astronomers could read Mars more deeply. -

Ebook < Impact Craters on Mars # Download
7QJ1F2HIVR # Impact craters on Mars « Doc Impact craters on Mars By - Reference Series Books LLC Mrz 2012, 2012. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 254x192x10 mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Source: Wikipedia. Pages: 50. Chapters: List of craters on Mars: A-L, List of craters on Mars: M-Z, Ross Crater, Hellas Planitia, Victoria, Endurance, Eberswalde, Eagle, Endeavour, Gusev, Mariner, Hale, Tooting, Zunil, Yuty, Miyamoto, Holden, Oudemans, Lyot, Becquerel, Aram Chaos, Nicholson, Columbus, Henry, Erebus, Schiaparelli, Jezero, Bonneville, Gale, Rampart crater, Ptolemaeus, Nereus, Zumba, Huygens, Moreux, Galle, Antoniadi, Vostok, Wislicenus, Penticton, Russell, Tikhonravov, Newton, Dinorwic, Airy-0, Mojave, Virrat, Vernal, Koga, Secchi, Pedestal crater, Beagle, List of catenae on Mars, Santa Maria, Denning, Caxias, Sripur, Llanesco, Tugaske, Heimdal, Nhill, Beer, Brashear Crater, Cassini, Mädler, Terby, Vishniac, Asimov, Emma Dean, Iazu, Lomonosov, Fram, Lowell, Ritchey, Dawes, Atlantis basin, Bouguer Crater, Hutton, Reuyl, Porter, Molesworth, Cerulli, Heinlein, Lockyer, Kepler, Kunowsky, Milankovic, Korolev, Canso, Herschel, Escalante, Proctor, Davies, Boeddicker, Flaugergues, Persbo, Crivitz, Saheki, Crommlin, Sibu, Bernard, Gold, Kinkora, Trouvelot, Orson Welles, Dromore, Philips, Tractus Catena, Lod, Bok, Stokes, Pickering, Eddie, Curie, Bonestell, Hartwig, Schaeberle, Bond, Pettit, Fesenkov, Púnsk, Dejnev, Maunder, Mohawk, Green, Tycho Brahe, Arandas, Pangboche, Arago, Semeykin, Pasteur, Rabe, Sagan, Thira, Gilbert, Arkhangelsky, Burroughs, Kaiser, Spallanzani, Galdakao, Baltisk, Bacolor, Timbuktu,... READ ONLINE [ 7.66 MB ] Reviews If you need to adding benefit, a must buy book. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I discovered this publication from my i and dad advised this pdf to find out. -- Mrs. Glenda Rodriguez A brand new e-book with a new viewpoint. -

Moonstruck: How Realistic Is the Moon Depicted in Classic Science Fiction Films?
MOONSTRUCK: HOW REALISTIC IS THE MOON DEPICTED IN CLASSIC SCIENCE FICTION FILMS? DONA A. JALUFKA and CHRISTIAN KOEBERL Institute of Geochemistry, University of Vienna. Althanstrasse 14, A-1090 Vienna, Austria (E-mail: [email protected]; [email protected]) Abstract. Classical science fiction films have been depicting space voyages, aliens, trips to the moon, the sun, Mars, and other planets, known and unknown. While it is difficult to critique the depiction of fantastic places, or planets about which little was known at the time, the situation is different for the moon, about which a lot of facts were known from astronomical observations even at the turn of the century. Here we discuss the grade of realism with which the lunar surface has been depicted in a number of movies, beginning with George Méliès’ 1902 classic Le Voyage dans la lune and ending, just before the first manned landing on the moon, with Stanley Kubrick’s 2001: A Space Odyssey. Many of the movies present thoughtful details regarding the actual space travel (rockets), but none of the movies discussed here is entirely realistic in its portrayal of the lunar surface. The blunders range from obvious mistakes, such as the presence of a breathable atmosphere, or spiders and other lunar creatures, to the persistent vertical exaggeration of the height and roughness of lunar mountains. This is surprising, as the lunar topography was already well understood even early in the 20th century. 1. Introduction Since the early days of silent movies, the moon has often figured prominently in films, but mainly as a backdrop for a variety of more or (most often) less well thought-out plots. -

Transits of Mercury, 1605–2999 CE
Appendix A Transits of Mercury, 1605–2999 CE Date (TT) Int. Offset Date (TT) Int. Offset Date (TT) Int. Offset 1605 Nov 01.84 7.0 −0.884 2065 Nov 11.84 3.5 +0.187 2542 May 17.36 9.5 −0.716 1615 May 03.42 9.5 +0.493 2078 Nov 14.57 13.0 +0.695 2545 Nov 18.57 3.5 +0.331 1618 Nov 04.57 3.5 −0.364 2085 Nov 07.57 7.0 −0.742 2558 Nov 21.31 13.0 +0.841 1628 May 05.73 9.5 −0.601 2095 May 08.88 9.5 +0.326 2565 Nov 14.31 7.0 −0.599 1631 Nov 07.31 3.5 +0.150 2098 Nov 10.31 3.5 −0.222 2575 May 15.34 9.5 +0.157 1644 Nov 09.04 13.0 +0.661 2108 May 12.18 9.5 −0.763 2578 Nov 17.04 3.5 −0.078 1651 Nov 03.04 7.0 −0.774 2111 Nov 14.04 3.5 +0.292 2588 May 17.64 9.5 −0.932 1661 May 03.70 9.5 +0.277 2124 Nov 15.77 13.0 +0.803 2591 Nov 19.77 3.5 +0.438 1664 Nov 04.77 3.5 −0.258 2131 Nov 09.77 7.0 −0.634 2604 Nov 22.51 13.0 +0.947 1674 May 07.01 9.5 −0.816 2141 May 10.16 9.5 +0.114 2608 May 13.34 3.5 +1.010 1677 Nov 07.51 3.5 +0.256 2144 Nov 11.50 3.5 −0.116 2611 Nov 16.50 3.5 −0.490 1690 Nov 10.24 13.0 +0.765 2154 May 13.46 9.5 −0.979 2621 May 16.62 9.5 −0.055 1697 Nov 03.24 7.0 −0.668 2157 Nov 14.24 3.5 +0.399 2624 Nov 18.24 3.5 +0.030 1707 May 05.98 9.5 +0.067 2170 Nov 16.97 13.0 +0.907 2637 Nov 20.97 13.0 +0.543 1710 Nov 06.97 3.5 −0.150 2174 May 08.15 3.5 +0.972 2644 Nov 13.96 7.0 −0.906 1723 Nov 09.71 13.0 +0.361 2177 Nov 09.97 3.5 −0.526 2654 May 14.61 9.5 +0.805 1736 Nov 11.44 13.0 +0.869 2187 May 11.44 9.5 −0.101 2657 Nov 16.70 3.5 −0.381 1740 May 02.96 3.5 +0.934 2190 Nov 12.70 3.5 −0.009 2667 May 17.89 9.5 −0.265 1743 Nov 05.44 3.5 −0.560 2203 Nov -

‹ in This Web Service Cambridge University Press Cambridge University Press 978-0-521-51418-7
&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV 78-0-521-51418-7 - Planetary Surface Processes +-D\0HORVK ,QGH[ 0RUHLQIRUPDWLRQ Index aa, 208–09 Apollo 17, 152, 153, 277, 322 accretion of planets, 268 heat flow, 292 acoustic fluidization, 343 Appalachian Valley and Ridge, 129 adiabat, 180, 181 Arden corona, 139 adiabatic gradient, 123, 173–74 Ares Vallis, 405 Adivar crater, 379 Ares Vallis flood, 406 Aeolis Planum, 413, 414 Argyre Basin, 455 Agassiz, Louis, 434, 439 Aristarchus crater, 216 age, solar system, 3 Aristarchus plateau, 195, 206, 216 ages of planetary surfaces, see impact craters: Artemis Chasma, 16 populations: dating Artemis Corona, 93 agglutinate, 285 Ascraeus Mons, 207 Ahmad Baba crater, 225 asteroid, 4 Airy isostasy, 87, 88 atmospheres Alba Patera, 157, 159 retention, 6 albedo, 289 Aleutian volcanic chain, 189, 195 Bagnold, R., 348, 374, 397, 401, 430 Algodones dunes, 366 Baltis Vallis, Venus, 217 alkali basalt, 184 Barringer, D. M., 223 Allegheny River, 417 basalt, 179, 196 Alpha Regio, Venus, 216 Basin and Range province, 136 Alphonsus crater, 155 batch melting, 187 Alpine Fault, 149 Beta Regio, 91 Alps, 436 Big Bear Lake, CA, 302 Amazon River, 416 Bingham, E. C., 64, 185 Amboy crater, CA, 377 biotite, 305 ammonia clathrate, 179 Blackhawk landslide, 341 Amontons, Guillaume, 68 blueberries on Mars, 304 amorphous ice, 288 Bonestell, Chesley, 328 Anderson, Don, 94 Borealis plains, 17 Anderson, E. M., 145 Boulton, G. S., 452 Andes mountains, 189, 195 Boussinesq, J., 411 andesite, 182, 184, 196, 197 Brazil nut effect, 314 anhydrite, 297, 299 Brent -

Mars Wars the Rise and Fall of the Space Exploration Initiative
Mars Wars The Rise and Fall of the Space Exploration Initiative Thor Hogan The NASA History Series National Aeronautics and Space Administration NASA History Division Office of External Relations Washington, DC May 2007 NASA SP-2007-4410 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Hogan, Thor. Mars wars : the rise and fall of the Space Exploration Initiative / Thor Hogan. p. cm. -- (The NASA history series) (NASA SP-2007-4410) Includes bibliographical references and index. 1. Space Exploration Initiative (U.S.) 2. Space flight to Mars--Planning--History--20th century. 3. United States. National Aeronautics and Space Administration--Management--History--20th century. 4. Astronautics and state--United States--History--20th century. 5. United States--Politics and government--1989-1993. 6. Outerspace--Exploration--United States--History--20th century. 7. Organizational change--United States--History--20th century. I. Title. TL789.8.U6S62 2007 629.45’530973--dc22 2007008987 Table of Contents Acknowledgements. iii Chapter 1: Introduction. 1 The Policy Stream and Punctuated Equilibrium Models. 2 Why Mars?. 5 Canals on Mars. 7 Mars in Popular Culture. 9 Mariner and Viking . 11 Chapter 2: The Origins of SEI . 15 Early Mission Planning . 16 Post-Apollo Planning. 21 Case for Mars. 25 National Commission on Space. 27 The Ride Report . 30 President Reagan and NASA’s Office of Exploration. 32 Chapter 3: Bush, Quayle, and SEI. 37 Bush-Quayle 1988. 39 Reagan-Bush Transition. 44 The Problem Stream: Providing Direction to a Directionless Agency. 47 The Policy Stream: The Ad Hoc Working Group. 57 The Political Stream: Briefing Key Actors. 64 Joining the Streams: Human Exploration of Mars Reaches the Gov. -

Spring 2002 Issue
21st CENTURY SCIENCE & TECHNOLOGY \' Spring 2002 Features News SPECIAL REPORT 12 Alexander von Humboldt: 58 Why There Really Are A Republican Scientist in the Tradition of Franklin No Limits to Growth Timothy Rush Ralf Schauerhammer The most renowned scientist worldwide in the first half of the 19th PEDAGOGY Century, Humboldt is barely known today in the country of his 66 Gauss's Declaration of greatest philosophical affinities, the United States. Independence: The Fundamental Theorem of Algebra 31 Ibero-America Needs a Space Agency! Bruce Director Marsha Freeman NUCLEAR REPORT It's time for all the nations of Ibero-America to put forward bold 70 INTERVIEW WITH WALTER SIMON plans for space exploration, and for the developed nations to stop General Atomics Reactor sabotaging such projects, under the guise of non-proliferation. In Russia To Burn Weapons Plutonium 74 PBMR Moves Ahead In South Africa RESEARCH FRONTIERS 75 GROWING FOOD IN AIR A Second Green Revolution Caroline Hartmann and Elisabeth Pascali 76 INTERVIEW WITH DR. GIANCARLO COSTA Out-of-Soil Farming Produces A Superior Product at Less Cost SPACE 78 INTERVIEW WITH ACADEMICIAN NIKOLAI ANFIMOV Inside Russia's Unique Space Science Institute Departments EDITORIAL 2 Teach Gauss's 1799 Proof of the Fundamental Th e increasing prominence of skeptical environmentalist Bjorn Lomborg Theorem of Algebra was too much fo r Scientific American, which devoted 77 pages in its Laurence Hecht January 2002 issue to a hit-and-run attack on Lomborg, written by leading 3 LETTERS Malthusian scientists. The Special Report by Ralf Schauerhammer, "Why 8 NEWS BRIEFS There Really Are No Limits to Growth, " examines the fa ulty premises of 10 VI EWPOI NT both the Malthusians and Lomborg and his free market supporters. -

Sha Library Manual and Catalogue December 2013
SHA LIBRARY MANUAL AND CATALOGUE DECEMBER 2013 CONTENTS 1. Introduction 2. Aims of the SHA Library 3. Location and Access to Collections 4. Services 5. Collections 6. Requesting material for loan 7. Guidance on the use of material 8. Photocopying and Copyright 9. Archives 10. Links to other libraries 11. Catalogue 1. Introduction The SHA Library came into being in June 2002 when the Society was founded. Its first and then only, Librarian was Madeline Cox, FRAS, who set up and organised the Society's Lending Library, based at her home and operating by post. In 2004, premises were made available at the Birmingham & Midland Institute for a Reference Library, subsequently named the Sir Robert Ball Library (SRBL), in the Benson Room. The Lending Library was re-named the Sir Patrick Moore Library. The SRBL was placed under the management of Stuart Williams, FRAS, then Secretary of the SHA and now Research Librarian, and set up with the help of Survey Coordinator Roger Jones, under the oversight of SHA Librarian Madeline Cox, who subsequently became Chair of the SHA's newly-formed Library Committee. In late 2007, re-organisation and expansion of the SHA Library Service was planned and as a result Madeline Cox became Head Librarian. In early 2008, it was decided to reunite the lending and reference collections within the Sir Robert Ball Library at the BMI, to make them more accessible to members and others. At the same time, fixed opening days ceased and access to the reunited library was made available by arrangement. Currently, the volunteer staff of the SHA Library Service comprises: Head Librarian Madeline Cox, FRAS.