Le Cavità Archeologiche Artificiali Del Golfo Di Napoli
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

F. Pingue , G.. De Natale , , P. Capuano , P. De , U
Ground deformation analysis at Campi Flegrei (Southern Italy) by CGPS and tide-gauge network F. Pingue1, G.. De Natale1, F. Obrizzo1, C. Troise1, P. Capuano2, P. De Martino1, U. Tammaro1 1 Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia . Osservatorio Vesuviano, Napoli, Italy 2 Dipartimento di Matematica e Informatica, Università di Salerno, Italy CGPS CAMPI FLEGREI NETWORK TIDE GAUGES ABSTRACT GROUND DEFORMATION HISTORY CGPS data analysis, during last decade, allowed continuous and accurate The vertical ground displacements at Campi Flegrei are also tracked by the sea level using tide gauges located at the Campi Flegrei caldera is located 15 km west of the Campi Flegrei, a caldera characterized by high volcanic risk due to tracking of ground deformation affecting Campi Flegrei area, both for Nisida (NISI), Port of Pozzuoli (POPT), Pozzuoli South- Pier (POPT) and Miseno (MISE), in addition to the reference city of Naples, within the central-southern sector of a the explosivity of the eruptions and to the intense urbanization of the vertical component (also monitored continuously by tide gauge and one (NAPT), located in the Port of Naples. The data allowed to monitor all phases of Campi Flegrei bradyseism since large graben called Campanian Plain. It is an active the surrounding area, has been the site of significant unrest for the periodically by levelling surveys) and for the planimetric components, 1970's, providing results consistent with those obtained by geometric levelling, and more recently, by the CGPS network. volcanic area marked by a quasi-circular caldera past 2000 years (Dvorak and Mastrolorenzo, 1991). More recently, providing a 3D displacement field, allowing to better constrain the The data have been analyzed in the frequency domain and the local astronomical components have been defined by depression, formed by a huge ignimbritic eruption the caldera floor was raised to about 1.7 meters between 1968 and inflation/deflation sources responsible for ground movements. -

Boccaccio Angioino Materiali Per La Storia Culturale Di Napoli Nel Trecento
Giancarlo Alfano, Teresa D'Urso e Alessandra Perriccioli Saggese (a cura di) Boccaccio angioino Materiali per la storia culturale di Napoli nel Trecento Destini Incrociati n° 7 5 1-6.p65 5 19/03/2012, 14:25 Il presente volume è stato stampato con i fondi di ricerca della Seconda Università di Napoli e col contributo del Dipartimento di Studio delle componenti culturali del territorio e della Facoltà di Lettere e Filosofia. Si ringraziano Antonello Frongia ed Eliseo Saggese per il prezioso aiuto offerto. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’éditeur ou de ses ayants droit, est illicite. Tous droits réservés. © P.I.E. PETER LANG S.A. Éditions scientifiques internationales Bruxelles, 2012 1 avenue Maurice, B-1050 Bruxelles, Belgique www.peterlang.com ; [email protected] Imprimé en Allemagne ISSN 2031-1311 ISBN 978-90-5201-825-6 D/2012/5678/29 Information bibliographique publiée par « Die Deutsche Nationalbibliothek » « Die Deutsche Nationalbibliothek » répertorie cette publication dans la « Deutsche Nationalbibliografie » ; les données bibliographiques détaillées sont disponibles sur le site http://dnb.d-nb.de. 6 1-6.p65 6 19/03/2012, 14:25 Indice Premessa ............................................................................................... 11 In forma di libro: Boccaccio e la politica degli autori ...................... 15 Giancarlo Alfano Note sulla sintassi del periodo nel Filocolo di Boccaccio .................. 31 Simona Valente Appunti di poetica boccacciana: l’autore e le sue verità .................. 47 Elisabetta Menetti La “bona sonoritas” di Calliopo: Boccaccio a Napoli, la polifonia di Partenope e i silenzi dell’Acciaiuoli ........................... 69 Roberta Morosini «Dal fuoco dipinto a quello che veramente arde»: una poetica in forma di quaestio nel capitolo VIII dell’Elegia di Madonna Fiammetta ................................................... -

Map 44 Latium-Campania Compiled by N
Map 44 Latium-Campania Compiled by N. Purcell, 1997 Introduction The landscape of central Italy has not been intrinsically stable. The steep slopes of the mountains have been deforested–several times in many cases–with consequent erosion; frane or avalanches remove large tracts of regolith, and doubly obliterate the archaeological record. In the valley-bottoms active streams have deposited and eroded successive layers of fill, sealing and destroying the evidence of settlement in many relatively favored niches. The more extensive lowlands have also seen substantial depositions of alluvial and colluvial material; the coasts have been exposed to erosion, aggradation and occasional tectonic deformation, or–spectacularly in the Bay of Naples– alternating collapse and re-elevation (“bradyseism”) at a staggeringly rapid pace. Earthquakes everywhere have accelerated the rate of change; vulcanicity in Campania has several times transformed substantial tracts of landscape beyond recognition–and reconstruction (thus no attempt is made here to re-create the contours of any of the sometimes very different forerunners of today’s Mt. Vesuvius). To this instability must be added the effect of intensive and continuous intervention by humanity. Episodes of depopulation in the Italian peninsula have arguably been neither prolonged nor pronounced within the timespan of the map and beyond. Even so, over the centuries the settlement pattern has been more than usually mutable, which has tended to obscure or damage the archaeological record. More archaeological evidence has emerged as modern urbanization spreads; but even more has been destroyed. What is available to the historical cartographer varies in quality from area to area in surprising ways. -

The Recollections of Encolpius
The Recollections of Encolpius ANCIENT NARRATIVE Supplementum 2 Editorial Board Maaike Zimmerman, University of Groningen Gareth Schmeling, University of Florida, Gainesville Heinz Hofmann, Universität Tübingen Stephen Harrison, Corpus Christi College, Oxford Costas Panayotakis (review editor), University of Glasgow Advisory Board Jean Alvares, Montclair State University Alain Billault, Université Jean Moulin, Lyon III Ewen Bowie, Corpus Christi College, Oxford Jan Bremmer, University of Groningen Ken Dowden, University of Birmingham Ben Hijmans, Emeritus of Classics, University of Groningen Ronald Hock, University of Southern California, Los Angeles Niklas Holzberg, Universität München Irene de Jong, University of Amsterdam Bernhard Kytzler, University of Natal, Durban John Morgan, University of Wales, Swansea Ruurd Nauta, University of Groningen Rudi van der Paardt, University of Leiden Costas Panayotakis, University of Glasgow Stelios Panayotakis, University of Groningen Judith Perkins, Saint Joseph College, West Hartford Bryan Reardon, Professor Emeritus of Classics, University of California, Irvine James Tatum, Dartmouth College, Hanover, New Hampshire Alfons Wouters, University of Leuven Subscriptions Barkhuis Publishing Zuurstukken 37 9761 KP Eelde the Netherlands Tel. +31 50 3080936 Fax +31 50 3080934 [email protected] www.ancientnarrative.com The Recollections of Encolpius The Satyrica of Petronius as Milesian Fiction Gottskálk Jensson BARKHUIS PUBLISHING & GRONINGEN UNIVERSITY LIBRARY GRONINGEN 2004 Bókin er tileinkuð -

Documento Di Orientamento Strategico
Regione Campania – Fondi Strutturali Comunitari Obiettivo 1 POR 2000- 2006 Progetto Integrato per la valorizzazione delle risorse archeologiche, architettoniche e paesistiche dei Campi Flegrei Itinerario di valenza culturale di primario interesse regionale Titolarità Regione Campania Documento di orientamento strategico Regione Campania Provincia di Napoli Comune di Bacoli Comune di Monte di Procida Comune di Pozzuoli Comune di Quarto Soprintendenza BAAS di Napoli Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta Commissario per l’attuazione della legge 80/86 Documento redatto a cura della struttura operativa dell’Asse II del POR Campania Approvato dal Tavolo di concertazione il 3.7.2001(Verbale n.3) Ma la riunione è del 12/07/02 1 Regione Campania – Fondi Strutturali Comunitari Obiettivo 1 Scheda sintetica CONTESTO TERRITORIALE: Campi Flegrei COMUNI INTERESSATI DAL PIT: Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto. ASSE DI RIFERIMENTO PRIMARIO: ASSE II Risorse Culturali FINALITA’: Conservare e valorizzare il patrimonio storico culturale dei Campi Flegrei per creare condizioni favorevoli all’innesco di processi di sviluppo locale , favorendo lo sviluppo di iniziative imprenditoriali collegate alla valorizzazione del Bene culturale nei settori dell’artigianato, del turismo, dei servizi e del restauro. Creare le condizioni per l’attrazione di capitali privati nel ciclo di recupero, valorizzazione e gestione dei Beni culturali, anche promuovendo la finanza di progetto. OBIETTIVI GENERALI: a) tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, naturale -

Paolo Poccetti
13-Poccetti 171 5-07-2013 9:18 Pagina 171 PAOLO POCCETTI IL FILO DELL’ONOMASTICA E LA TRAMA DELLA RAPPRESENTAZIONE LETTERARIA DELLA CAMPANIA IN VIRGILIO Virgilio è certamente tra gli autori dell’antichità più indagati per quanto riguarda l’uso dei nomi propri. L’interesse risale ai suoi com- mentatori antichi i quali proprio a partire dai nomi offrono le informa- zioni più dettagliate e più ghiotte per gli antiquari e i filologi. È dietro le citazioni di nomi che si seguono le tracce di opere perdute che sono state la fonte del poeta augusteo, si raggranellano frammenti di autori di cui a loro volta spesso non resta che il nome. Fatto sta che la biblio- grafia sull’onomastica virgiliana è ormai sterminata e se ne ricava la sensazione che sia giunto il momento di una riflessione generale e di un bilancio critico sull’uso che è stato fatto dei nomi propri, particolar- mente dell’Eneide, nell’ambito dell’esegesi e dei commenti, a scopo let- terario, linguistico e storico-antiquario. È, infatti, a partire dai nomi che Virgilio è stato utilizzato ora come fonte storica ora come serbatoio di tradizioni altrimenti perdute ora, perfino, come guida topografica, di cui esempio più noto e qui perti- nente è la ricerca dell’ubicazione reale dell’antro della Sibilla nell’area archeologica di Cuma sulla scorta della descrizione fattane nell’Eneide.1 Per ovvi motivi ruolo privilegiato come repertorio di ono- mastica sotto il profilo storico e geografico ha l’Italia, che è, per quanto riguarda l’Eneide, meta e teatro degli avvenimenti di oltre metà del poema e, per quanto riguarda le Georgiche, spazio ideale della vita campestre e delle risorse dell’agricoltura. -

Posillipo Inside
Posillipo inside Guided Tour Sejanus Cave and Parco della Tomba di Virgilio are the focus points of the itinerary. The first one crosses the hill of Posillipo, provides wonderful landscapes of Nisida and the Phlegrean area; from the park, you can see an amazing landscape of the Neapolitan gulf, on which is settled the Vesuvius’s mole. Poi 1 Crypta neapolitana (Park of Virgilu's Tomb) Info POI Distance Skill Scan the QrCode to access the 1 0.00 Km Tutti navigable mobile version of the itinerary Poi 1 Crypta neapolitana (Park of Virgilu's Tomb) Napoli / Place to visit - Archaeological areas Site rich of suggestive legends, equipped with such beauty to be quoted by Petrarca and to turn Goethe’s head, the Neapolitan Crypt, situated in Parco Virgiliano, is a long cramped gallery of 700 meters excavated in tuff in the 1st century b.C. Also known as Grotta vecchia di Pozzuoli (old cave of Pozzuoli), it was built at the time of Emperor Augustus to connect Naples to Campi Flegrei. At the entrance, situated not too far from Giacomo Leopardi’s tomb, it is now possible to see two frescoed niches: the one on the left has a raffiguration of the Madonna and her Baby from the 14th century, while, on the right one, which is of uncertain origins, God’s face is depicted. The tunnel is oriented so that, in occasion of the equinoxes, the sun is perfectly allineated between the two entrances at dusk and dawn, which enables the natural light to illuminate it completely. This crypt, besides being an essential passage to connect Neàpolis with Puteoli harbour, was also a place of worship where initiation rites took place. -

Il Turismo Geologico: Aree Protette E Geoparchi
IL TURISMO GEOLOGICO: AREE PROTETTE E GEOPARCHI CAPITOLO 2 IL TURISMO GEOLOGICO: AREE PROTETTE E GEoparcHI Convener: Anna Paganoni Museo Civico di Scienze Naturali, Bergamo; Associazione Italiana Geologia & Turismo, [email protected] Maurizio Burlando Presidente Geoparks Network Italia, Direttore Beigua Geopark, [email protected] Furio Finocchiaro Dipartimento di Matematica e Geoscienze, Università di Trieste, Trieste; Associazione Italiana Geologia & Turismo, [email protected] GEOLOGICAL TOURISM: PROTECTED AREAS AND GEOPARKS Geological tourism holds in Geosites, in protected natural areas, in Geological museums and in Geoparks, privileged places aimed at the conservation and promotion of geological processes, from those that are unique and rare to more common ones (but often clearly evident). Discovering, through promotional events dedicated to geo-tourism, where, when and why phenomena and places are expressions of the Geological Heritage, is the focus of this second session of our Conference. These phenomena are with full rights in the Cultural Heritage of our country not only due to regulatory law but also to the included participation of the geological heritage into our collective and individual identity. Such an heritage must be protected, preserved and known in its excellence spots, but especially loved as it is loaded with an immaterial and symbolic responsibility, an heritage to respect like our own home for the benefit of future generations. Damage and/or loss of each of the elements that form the “Geological heritage” alters forever the possibility of understanding and interpretation. Geology, memory of natural processes, must find ways to convey the complex four-dimensional perspective, where time and space are witnessing climates, environments and different phenomena. -
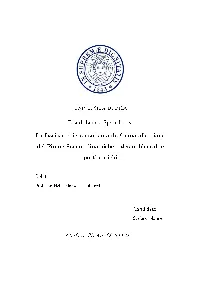
Università Di Pisa
Università di Pisa Tesi di Laurea Specialistica La fascia costiera campana da Cuma alla piana del Fiume Sarno: dinamiche paleoambientali e porti antichi Relatore Prof.essa Nella Maria Pasquinucci Candidato Stefano Marinelli ANNO ACCADEMICO 2010-2011 La Campania è la regione più bella non solo d'Italia, ma di tutto il mondo. Non c'è niente di più dolce del suo clima: basti dire che la primavera vi sboccia due volte. Non c'è niente di più fertile del suo suolo: si dice che là gareggino Cerere e Bacco. Niente di più ospitale del suo mare: vi si trovano i famosi porti di Gaeta e di Miseno, di Baia dalle tepide fonti, il Lucrino e l'Averno, quasi luoghi di riposo del mare. Qui ci sono monti cinti di vigneti, il Gauro, il Falerno, il Massico e, più bello di tutti, il Vesuvio, che rivaleggia col fuoco dell'Etna. Ci sono città volte al mare: Formia, Cuma, Pozzuoli, Napoli, Ercolano, Pompei e la stessa loro capitale Capua, un tempo annoverata fra le tre più grandi città (del mondo) con Roma e Cartagine. (Floro, Campania Felix) Indice Introduzione 1 1 Inquadramento dell'area di studio: il golfo di Napoli 5 1.1 Il territorio dei Campi Flegrei . 7 1.1.1 I laghi costieri . 11 1.2 Il territorio dell'antica Neapolis . 13 1.2.1 Settore occidentale . 15 1.2.2 Settore orientale . 16 1.3 Il settore meridionale del golfo di Napoli . 18 2 Dinamiche paleoambientali nella fascia costiera campana in età storica 22 2.1 Evoluzione del paesaggio costiero dei Campi Flegrei . -

Baia. Una Ciudad, O Los Restos De Lo Que Fue, a Veintitrés Ki- Lómetros De Nápoles Y 8 Metros Bajo El Nivel Del Mar
Baia. Una ciudad, o los restos de lo que fue, a veintitrés ki- lómetros de Nápoles y 8 metros bajo el nivel del mar. Aquí comienza el trabajo, un viaje por la antigüedad a través de las ruinas de Baia. El tema de este trabajo se centra en las ruinas de la ciudad subacuática de Baia, conocida antiguamente como Puteoli, una ciudad de vacaciones de la antigua Roma para las clases altas de la sociedad, absorbida por el mar hace más de dos mil años. Esta ciudad albergó grandes autores como Cicerón, Virgilio o Nerón, y en ella aún se pueden encontrar estructu- ras de las villas, calles e incluso templos como el de Venus, además de estatuas o mosaicos perfectamente conservados bajo el agua. Actualmente, a pesar de contar con numerosas investigacio- nes sobre el yacimiento a nivel fotográfico y de conservación, no se encuentran cartografías detalladas del mismo que nos hagan recorrer los restos de la ciudad, más allá de los planos turísticos de museo u otros con poca definición. Por ello, este trabajo pretende entender la evolución de la ciudad de Baia a través de plantas, secciones y dibujos a mano de su emplaza- miento, además del análisis del territorio donde se sitúa. Todo ello se analiza desde los ocho lugares de inmersión existentes actualmente, alrededor de los cuales se desarrolla el trabajo. BAIA 8 CARTOGRAFÍAS SUBACUÁTICAS Autora: CARMEN LLORENTE ANAYA Tutor: ENRIQUE COLOMÉS MONTAÑÉS ABSTRACT Baia. Una ciudad, o los restos de lo que fue, a veintitrés kilómetros de Nápoles y 8 metros bajo el nivel del mar. -

De Feo Giovanni
Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Ingegneria Industriale Gli antichi acquedotti romani e alcune meraviglie dell’ Aqua Augusta di Serino Giovanni De Feo www.greenopoli.it UNIVERSITY OF SALERNO - ITALY www.unisa.it Department of Civil Engineering www.unisa.diciv.it Groundwater Recharge in an Endoreic Basin with Reclaimed Municipal Wastewater Giovanni De Feo Wastewater Reclamation & Reuse for Sustainability Nov. 8-11.2005 / Ramada Plaza, Jeju, Korea La Piana del Dragone Volturara Irpina (Av) Dr. Andreas N. Angelakis Honorary Member of IWA Fellow IWA Past President of EUREAU Chairperson of IWA-WWAC SG on Water and Wastewater in Ancient Civilizations Iraklion, Hellas. Ottaviano De Biase Poeta, storico locale, “marinaio di montagna” UNIVERSITY OF SALERNO - ITALY www.unisa.it Department of Civil Engineering www.unisa.diciv.it Historical Development of the Augustan Aqueduct in Southern Italy: Twenty Centuries of Works from SERINO to NAPLES Giovanni DE FEO Via Ferrari, 14 83028 SERINO (AV) EU, FAO, UNESCO, EUREAU, Assoc. of Greek Municipalities IWA Specialty Conference: 1 st International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations October 28-30, 2006 - Heraklion (Iraklio), Crete, Greece Specialist Group on Water and Wastewater in Ancient Civilizations http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20090502052213/timemachine/images/4/45/The_Time_Machine.jpg Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Ingegneria Civile www.unisa.it www.unisa.diciv.it Sviluppo Storico dell’Acquedotto Augusteo in Campania: Venti Secoli di Lavori tra SERINO e NAPOLI Giovanni DE FEO A.N.M.I. Associazione Nazionale Marinai d’Italia per la Campania Presenta il volume L’Acqua del Serino - Sorgenti e Acquedotti di Ottaviano De Biase CIRCOLO UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE DI NAPOLI Sabato 11 novembre, ore 17.30 Perché i Romani costruivano acquedotti? ° In generale, non per fornire acqua potabile e per motivi igienici: per rifornire le terme (Hodge, 2002) o per scopi militari . -

The Legacy of Antiquity
The Legacy of Antiquity The Legacy of Antiquity: New Perspectives in the Reception of the Classical World Edited by Lenia Kouneni The Legacy of Antiquity: New Perspectives in the Reception of the Classical World, Edited by Lenia Kouneni This book first published 2013 Cambridge Scholars Publishing 12 Back Chapman Street, Newcastle upon Tyne, NE6 2XX, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2013 by Lenia Kouneni and contributors All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-4438-5249-X, ISBN (13): 978-1-4438-5249-4 “The art of the Greeks, of the Egyptians, of the great painters who lived in other times, is not an art of the past; perhaps it is more alive today than it ever was.” —Pablo Picasso, Two Statements by Picasso, 1923, in Picasso on Art: A Selection of Views, ed. Dore Ashton (London: 1972) TABLE OF CONTENTS List of Illustrations ..................................................................................... ix Foreword ................................................................................................... xv Acknowledgements .................................................................................. xvi Introduction ................................................................................................