Convegno Per La Conservazione
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Programma Del Festival Delle Arti 2016
1 CAMPO VAPORETTO Fermata Sacca Fisola Spazi Derive e nuovi approdi 2 CENTRO XXV APRILE Calle del Teatro 1, Sacca Fisola 3 GIUDECCA 795 ART GALLERY In un contesto difficile e distratto, il tema della settima edizione del Fondamenta S. Biagio 795 Festival delle Arti vuole essere un invito a salpare verso destinazioni 4 FONDAMENTA S. BIAGIO sconosciute e imprevedibili, usando la “deriva” psicogeografica come 5 AREA “CASETTE” pratica estetica di lettura di un territorio urbano in continua 6 CAMPO S. COSMO trasformazione. 7 EX CONVENTO SS. COSMA E DAMIANO Abbiamo invitato gli artisti a rapportarsi con lo spazio pubblico di Campo S. Cosmo 620/A Giudecca e Sacca Fisola con percorsi sino ad ora inesplorati, per 8 ASS. IL CENTRO DELLA LUCE DORATA sorprendersi, avere nuove visioni, aggiungervi dimensione ed Corte Nova 633 emozione, capirne le peculiarità, lasciandosi ispirare per opere 9 FONDAMENTA S. EUFEMIA Come raggiungerci Porticato della Chiesa inedite. 10 XFRAME STUDIO I partecipanti potranno misurare le proprie gesta performative con Fermate dei mezzi di trasporto pubblico Actv: Sacca Fisola, Palanca, Redentore, Zitelle Fondamenta S. Eufemia 673 l'aperto di corti e fondamenta, il percorribile di calli e callette, il > linea 2 e 4.1 da Ferrovia e da P.le Roma (parcheggio auto) direz. S.Zaccaria 11 FONDAMENTA S. EUFEMIA e CALLE DEL PISTOR navigabile di canali e lagune, lo scavalcabile dei muri e l’elevabile > linea 2 da Tronchetto (parcheggio auto) direzione S. Zaccaria 12 PATRONATO DON BOSCO delle altane. > linea 2 da Zattere direzione S. Zaccaria Calle lunga de l’Accademia dei Nobili 618 > linea 2 e 4.2 da S. -

Urban Accessibility of Historical Cities: the Venetian Case Study Valeria Tatano, Francesca Guidolin, Francesca Peltrera
World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Humanities and Social Sciences Vol:11, No:5, 2017 Urban Accessibility of Historical Cities: The Venetian Case Study Valeria Tatano, Francesca Guidolin, Francesca Peltrera original functionality or to add new functions, while always Abstract—The preservation of historical Italian heritage, at the safeguarding its historical and cultural value. urban and architectural scale, has to consider restrictions and In historical refurbishment intervention it is often necessary requirements connected with conservation issues and usability needs, to intervene ensuring appropriate levels of accessibility, which are often at odds with historical heritage preservation. Recent reducing as much as possible the presence of architectural decades have been marked by the search for increased accessibility not only of public and private buildings, but to the whole historical barriers. city, also for people with disability. Moreover, in the last years the Making the country’s heritage accessible to people with concepts of Smart City and Healthy City seek to improve disabilities, means restoring and adapting urban spaces, while accessibility both in terms of mobility (independent or assisted) and looking for solutions that are able to combine restoration fruition of goods and services, also for historical cities. The principles preservation requirements with those of Inclusive Design and of Inclusive Design have introduced new criteria for the improvement regulations that guarantee their correct application; however, it of public urban space, between current regulations and best practices. Moreover, they have contributed to transforming “special needs” into is not always to achieve this aim. This is especially the case in an opportunity of social innovation. -

From Railway Station Santa Lucia / Piazzale Roma from Airport Marco
S.Alvise Ponte della Libertà Sacca S.Alvise Fond.Dei Riformati Fond. Sacca S.Girolamo Canossiane 8 C.Lun.Penitenti Fond.Contarini Chiesa di C.d.Capitello C.d.Legname S.Alvise Rio S.Alvise C.d.Rotonda ISOLA DI MURANO Campo Fond.Coletti S.Alvise Ospedale Fatebenefratelli C.Capuccine C.d.Riformati Rio S.Girolamo Calle Fondamenta della Sensa C.llo Piave ISOLA DI Fondamenta de le Capuzine Chiesa della S.Girolamo C.Rubini Madonna dell'Orto C.lle Ferau Madonna dell'Orto Fond. de le Case Nove C.Pisani Calle Gradisca S.MICHELE C.te Cavallo Tre Fondamenta S.Girolamo Capitello Fond.Mad.Orto Archi 9 C.l.Piave Chiesa di C.Muneghe Campo S.Michele Corte C.llo Madonna Calle de l'Artigia Zappa d. Battello Fondamenta Ormesini dell'Orto en C.Angelo Fond. G. Contarini Ponte Calle LoredanFond.dei Mori Cristo dei Tre Archi C.Malvas. C.Brazzo C.llo Campo S.Michele Cimitero Cà Pesaro Madonna Nuovo Campo d.Mori Fond. S.Giobbe Corte Calle Scuro del Ghetto dei Vedei C.tintoret. no Basilica di C.d.ColoriMagazz Crea C.2 corti Fondamenta di Cannaregio Museo S.Maria Calle de le Beccarie Ebraico C.Forner e Donato Hotel ScalaVecchio mat. Fondamenta della C.Muti Calle del C.Larga Calle s.Giovanni Museo Paradiso Fond.Savorgnan Sinagoga Fondamente Nove Chiesa di Calle d.Chioverette G.NuovoC.lle d. Masena 24 del Vetro C.llo C.Gropp S.Giobbe Corte Vecchia Calle delle Conterie Soffiador Calle Cereria d. Scuole Misericordia Fond. Abbazia R.T.Crea Fondamenta Venier C.d.Forno Museo C.Busello Fond. -

Mattm 88-89-90; Prov Ve 3.6 Componente "Paesaggio"
MATTM 88‐89‐90; PROV VE 3.6 COMPONENTE "PAESAGGIO", "BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI" MATTM88: Elaborare uno studio della visualità (bacini, margini, itinerari, coni visuali) e della percezione visiva (verifica delle relazioni di le varie componenti del paesaggio e tra queste e l'opera), fornendo inoltre opportuni fotosimulazioni per la verifica dell'impatto visuale da e verso l'area dell'intervento, con particolare riferimento al centro storico, indicando i punti di scatto per ognuno di essi e considerando non solo il nuovo tracciato del canale con le relative velme ma anche le sagome, in scala, delle navi che l'attraverseranno nella fase di esercizio. Le fotosimulazioni dovranno, quindi, essere ad altezza osservatore, ante operam e post operam, in numero adeguato rispetto ai principali luoghi d'osservazione e di fruizione del territorio interessato. MATTM89: Chiarire le modalità che hanno portato alla definizione dell’area di influenza riportata nella figura 4.42, in considerazione soprattutto delle dimensioni esigue di detta figura, dalla quale risulta impossibile verificare quali siano, come afferma il Proponente, "i principali assi di comunicazione viaria e marittima, i centri abitati, gli spazi aperti costieri e lagunari che comportano elevata visibilità della zona interessata dagli interventi di progetto" utilizzati per l'inviluppo dell'area. MATTM90: Evitare rimandi alla Relazione Paesaggistica, come accade ad esempio in riferimento al rapporto fra l'opera e la componente paesaggistica (pag. 171 dello SIA), poiché tale Relazione è parte di un'altra procedura. 1 Le componenti del paesaggio che caratterizzano l’area interessata dal progetto sono riconducibili ai “caratteri” individuati nella Variante al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento con valenza paesaggistica presentato nel 2013. -
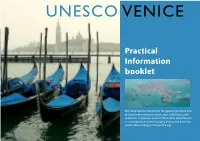
Practical Information Booklet
UNESCO VENICE Practical Information booklet This document is intended for the general guidance and practical information of visitors, new staff, interns, and volunteers. It provides pratical information about Venice, its transportation system, lodging, eating, and basic tips useful when visiting or living in the city Venice International airport Waterways The classical Venetian boat is the gondola, although it is now mostly www.veniceairport.it Climate used for tourists, or for weddings, funerals, or other ceremonies. Motorised waterbuses A visit to Venice in winter can be a great experience but you Alilaguna Shuttle Service (vaporetti) ply regular routes along the major canals and between the city’s islands. should be prepared for cold weather and for high water (acqua www.alilaguna.com Gondolas still in common use by Venetians are the traghetti, foot passenger boats cross- alta). Being by the sea, Venice rarely suffers from frost and an Associazione Alberghiera VeneziaSì Srl. tel. +39 041 5416555 ing the Grand Canal at certain points without bridges. average temperature in mid November is about 10 degrees fax: +39 041 522-1242 Water taxi Eating Cooperativa Motoscafi Call Center tel +39 041 522-2264 High waters Acqua Alta is the term for the exceptional tide peaks that occur pe- Venice is full of restaurants, featuring the cuisine of the Veneto. tel. +39 041 541-5084 Everyday from 8. a.m. to 9 p.m. riodically in the northern Adriatic Sea. The peaks reach their maximum in the Venetian For years Venice was the crossroads of the trading of spices Toll free number : 199 173 309 Lagoon, where they cause partial flooding of Venice and Chioggia. -

Ocdpcn 616/2019
DECRETO DEL C.D. n. 4 del 18 aprile 2020 - ALLEGATO 1 O.C.D.P.C. N. 616/2019 - ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 12 NOVEMBRE 2019 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA Contributi per l’immediato sostegno alla popolazione – PRIVATI - art. 25, comma 2, lettera c), Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 QUADRO RIEPILOGATIVO SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO - PRIMO STRALCIO – ELENCO DEI CONTRIBUTI LIQUIDABILI A FAVORE DI PRIVATI LEGENDA: Indennizzi assicurativi quantificati: N=non quantificato Liquidazione Totale o Parziale del contributo richiesto: P=parziale; T=totale. GENERALITÀ RENDICONTAZIONE Rendicontato Liquidazione Costi effettivamente sostenuti, Totale o Indennizzi assicurativi ammissibile al netto CONTRIBUTO Numeraz. Numero Protocollo Nominativo del dichiarante Indirizzo unità immobiliare interessata documentati, ammissibili alla Parziale del quantificati degli indennizzi elenco domanda (COGNOME – NOME) dall’evento data del Decreto contributo EROGABILE (B) (A) (A-B) richiesto DORSODURO 1539, DORSODURO, S. 1 10 GALLOTTI DARIO POLO, S. CROCE, GIUDECCA, SACCA € 444,00 N € 444,00 T € 444,00 FISOLA SAN MARTINO DESTRA 513, BURANO, 2 17 CERINI FIORELLA € 610,00 N € 610,00 T € 610,00 MAZZORBO, TORCELLO PELLESTRINA 546, PELLESTRINA, S. 3 36 SCARPA MARIO € 550,00 N € 550,00 T € 550,00 PIETRO IN VOLTA CASTELLO 5091, S. MARCO, CASTELLO, S. 4 45 FORT LORENZO € 430,00 N € 430,00 T € 430,00 ELENA, CANNAREGIO DORSODURO 1904/E, DORSODURO, S. 5 80 COMERCI DANIELE POLO, S. CROCE, GIUDECCA, SACCA € 3.115,00 N € 3.115,00 T € 3.115,00 FISOLA PELLESTRINA 1062, PELLESTRINA, S. 6 94 GHEZZO MAURO € 1.448,00 N € 1.448,00 T € 1.448,00 PIETRO IN VOLTA DORSODURO 716, DORSODURO, S. -

DAL 2/11 Prendo La Numero: PRIMA Prendevo La Linea
CAMPAGNA INFORMATIVA PER LA RINUMERAZIONE DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE Prendo il numer !... Dal 2 Novembre 2011 entra in vigore il nuovo sistema di identificazione delle linee di navigazione. Si passa dal sistema attuale ad uno dove tutte le linee sono rappresentate da un numero (ad eccezione delle linee notturne) e l'ordinamento è progressivo. Alcune linee sono rimaste invariate rispetto al passato. Nella tabella sottostante sono indicate sia la vecchia che la nuova numerazione con l'indicazione del percorso effettuato da ciascuna linea. Le fermate indicate fra parentesi vengono effettuate solo in alcuni orari o stagioni. La numero 22 è una nuova linea. PRIMA DAL 2/11 PRIMA DAL 2/11 prendevo prendo prendevo prendo O la linea: la numero: la linea: la numero: TA IA R A V IN F.TE NOVE/MURANO/BURANO/ P.LE ROMA/LIDO S.M.E. TREPORTI/(P.TA SABBIONI) TA TA IA IA R R A S. MARCO-S. ZACCARIA/GIUDECCA/ A V V IN IN F.TE NOVE/VIGNOLE/ TRONCHETTO/P.LE ROMA/RIALTO/ S. ERASMO/TREPORTI S. MARCO/(LIDO S.M.E.) P.LE ROMA/MURANO/ S. MARCO-S. ZACCARIA/ P.LE ROMA LIDO S.M.E./P.TA SABBIONI MURANO/F.TE NOVE/P.LE ROMA/ GIUDECCA/S. MARCO-S. ZACCARIA/ P.TA SABBIONI/LIDO S.M.E. F.TE NOVE/MURANO TA IA R MURANO/F.TE NOVE/ A V P.TA SABBIONI/ S. MARCO-S. ZACCARIA/GIUDECCA/ IN S. MARCO-S. ZACCARIA P.LE ROMA/F.TE NOVE/MURANO TA IA R LIDO S.M.E./F.TE NOVE/P.LE ROMA/ A V ZATTERE/S. -

PM10-Bound Arsenic Emissions from the Artistic Glass Industry in Murano (Venice, Italy) Before and After the Enforcement of REACH Authorisation
Journal of Hazardous Materials xxx (xxxx) xxx Contents lists available at ScienceDirect Journal of Hazardous Materials journal homepage: www.elsevier.com/locate/jhazmat Research paper PM10-bound arsenic emissions from the artistic glass industry in Murano (Venice, Italy) before and after the enforcement of REACH authorisation Gianni Formenton a,*, Maria Gregio b, Giovina Gallo a, Francesca Liguori c, Massimo Peruzzo d, Elena Innocente e, Roberto Lava a, Mauro Masiol e,* a Dipartimento Regionale Laboratori, Servizio Veneto Est, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), via Lissa 6, 30174 Mestre (VE), Italy b Servizio Igiene Sanita` Pubblica, Dipartimento di Prevenzione, Azienda Unita` Locale Socio Sanitaria 3 Serenissima, Piazzale S. Lorenzo Giustiniani 11/d, 30174 Mestre (VE), Italy c Osservatorio Regionale Aria, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), via Lissa 6, 30174 Mestre (VE), Italy d Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, Dipartimento di Prevenzione, Azienda Unita` Locale Socio Sanitaria 9 Scaligera, via Santa Maria Crocifissa di Rosa, 37067 Valeggio sul Mincio (VR), Italy e Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, U niversita` Ca’ Foscari Venezia, Campus Scientifico, via Torino 155, 30172 Mestre (VE), Italy ARTICLE INFO ABSTRACT Keywords: The island of Murano (Venice, Italy) is famous worldwide for its artistic glass production. Diarsenic trioxide was REACH a main ingredient of the raw glass mixture until 2015, when the authorisation process of European REACH Glass manufacturing Regulation (Registration Evaluation Authorisation of Chemicals) entered into force, effectively forbidding the use Arsenic of arsenic. A total of 3077 PM10 samples were collected across the Venice area in 2013–2017. -

The “Vicious Circle” of Tourism Development in Heritage Destinations
The “vicious circle” of tourism development in heritage destinations PAPER PREPARED FOR THE 40TH CONGRESS OF THE EUROPEAN REGIONAL SCIENCE ASSOCIATION, BARCELONA, 19/8 - 1/9 2000 ANTONIO PAOLO RUSSO Tinbergen Instituut and EURICUR, Erasmus Universiteit Rotterdam Postbus 1738 3000 DR Rotterdam (NL) Tel.: ++31 10 4081578 Fax: ++31 10 4089153 e-mail: [email protected] Abstract This paper explores the manifold relations that there exist between the spatial organisation of tourism, the quality of the tourism product in heritage cities, and the general dynamics of the regional economy. The concept of “vicious circle” of tourism development is introduced to describe the self-feeding linkage between the emergence of a class of excursionists among the visitors in the later stages of the tourism destination life-cycle and the decline in the attractiveness of the city. Reference is made to the case of Venice. According to this scheme, effective policies for sustainable tourism should attack the critical points where the vicious circle feeds. An adequate attention must be paid to the quality and accessibility of the primary and complementary tourism products. Keywords: Life-cycle model, heritage cities, regional dynamics, tourism policy 1. Introduction The very nature of tourism – its intensive use of the central space, its seasonal pattern, its “transversality” across industries – can greatly affect sensitive urban areas. By pushing on the value of urban facilities and premises, it represents an incentive for citizens and firms to abandon central locations. In the era of increasing inter-regional competition, the dispersion of human capital and economic resources is a major threat to the viability of local development (Bramezza, 1996). -

Q U a D E Rn I T Rim E S Tra Li C O N S O Rz Io V E N E Z Ia N U O Va , a N N O X V
Quaderni Trimestrali Consorzio Venezia Nuova, anno XV, nn. 1/2, gennaio/giugno 2007 - Poste Italiane spa - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Venezia - Maggio 2007. In caso di mancato recapito restituire all’ Ufficio di Venezia CMP - Detentore del conto, per la restituzione al mittente, previo pagamento resi Il Consorzio Venezia Nuova è il soggetto attuatore per conto del Ministero delle Infrastrutture - Magistrato alle Acque di Venezia delle attività di salvaguardia di competenza dello Stato, in attuazione della legge 798/84. Il Consorzio opera in base a una serie di obiettivi indicati dalla legge, organizzati in un Piano generale degli interventi che è stato definito dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo isti - tuito dalla legge 798/84; adeguato alle indicazioni delle istituzioni rappresentate nel Comitato; approvato dagli organismi competenti (a partire dal Magistrato alle Acque e dallo stesso Comitato); richia - mato dalla legge speciale per Venezia 139/92, come riferimento per lo sviluppo e il finanziamento delle attività. Il Piano degli interventi, integrato dal Piano generale degli studi , è articolato secondo linee di azione distinte ma in reciproca relazione: difesa dalle acque alte; di - fesa dalle mareggiate; difesa ambientale. Per svolgere il proprio com - pito di concessionario di studi, sperimentazioni, progetti e opere, il Consorzio Venezia Nuova si è dotato di una struttura in grado di pianificare, organizzare e gestire le diverse attività nel loro complesso e in tutte le fasi di attuazione. Il Consorzio è costituito da grandi imprese nazionali, da cooperative e da imprese locali. La sua opera - tività è iniziata nella seconda metà degli anni ‘80, quando sono stati avviati i primi interventi previsti dalla legislazione speciale per Ve - nezia. -

Departing from Venice
Republic of Common Ground September – November 2012 REPUBLIC of COMMON GROUND UN-COMMON NEWS UN-COMMON VENICE founded in 1798 Departing from Venice At the 13th International Architec- be translated into the language of ture Exhibition in Venice, which the kiosk where this alternative view has ‘Common Ground’ as its theme, (un-common view) will be offered Günther Vogt’s exhibition piece ta- to passersby in Venice in the form kes Venice itself as the starting point. of newspapers, maps, postcards, etc.. It examines public space, understood As the smallest building in the city, as being the commons, caught in the the kiosk is open to the widest pos- conflict between resource and utili- sible section of the general public, zation. By interviewing the local re- and will thereby establish a dialogue sidents and tourists in various public between the city and Biennale, as ad- places all over Venice, the intention is mission is free to all - firmly rooted to present a subjective perception of in the common ground of the city. the local ‘resource’ and its regulato- page 2,3 ry framework in relation to everyday life. The results of the surveys will LOCAL BACKGROUND COntEnt Piazza vs. An attempt THEME BACKGROUND: WATER IntERNATIONAL 2 Un-Common Venice 10 Water consumption 22,23 How does globalisation 3 Public assets in Venice 11 The greatest flood work locally? Campi on water from the everyday protection of all time 24,25 77 Statements on tourism perspective of the users 12,13 Venice – an attempt to While St. Mark’s Square (literally the In his article Jan Pieper shows how make water habitable through art (Jan Pieper) 26 OPINION & DEBATE LOCAL only ‘square’ in Venice) has always the particular situation of Venice has 27 PLAYTIME 4 Campo St. -

Municipalita' Di Venezia-Murano-Burano
MUNICIPALITA’ DI VENEZIA-MURANO-BURANO Deliberazione n. CV/2019/21 Oggetto: Ordine del Giorno “Dislocamento dell’attuale base di conferimento rifiuti solidi urbani, in attività presso il Cantiere di Veritas Spa – Isola della Giudecca”. Seduta del 1/04/2019 Consiglieri pres ass Consiglieri pres ass BALLARIN X MESSINIS X BERTELLI X ODEH X BERTOTTO X PANIZZI X BUSETTO X PURRAZZA X CAMILLA X REGAZZO X DE COL X ROSSETTO X DELL'ANTONIO X ROSSO X FINOCCHI X SAMBO X GAMBINO X SERENA X GASPERINI X STELLON X GIUSTO X TAGLIAPIETRA X GRIMALDO X TONON X MARIN X VIANELLO X MAROTTA X VIO X MARTINI X Totale 24 5 PRESIEDE PARTECIPA GIOVANNI ANDREA MARTINI PAOLO DEDE’ Il Presidente Giovanni Andrea Martini Il Segretario Paolo Dedè Deliberazione Protocollo n. 157317 del 25/03/2019 Pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni dal 2/04/2019 IL SEGRETARIO Paolo Dedè Deliberazione n.21 del 1.04. /2019 - PG. 157317 del 25/03/2019 OGGETTO: Ordine del Giorno “Dislocamento dell’attuale base di conferimento rifiuti solidi urbani, in attività presso il Cantiere di Veritas Spa – Isola della Giudecca”. IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA' Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, avente per oggetto “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”; lo Statuto del Comune di Venezia; il Regolamento Comunale delle Municipalità così come modificato dalla deliberazione n.17 del 26/02/2017; il Regolamento Interno della Municipalità; Vista la proposta di Ordine del Giorno presentata dalla maggioranza, relativa all’oggetto PG 166232 del 29/03/2019; Vista l’illustrazione