Mattm 88-89-90; Prov Ve 3.6 Componente "Paesaggio"
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Programma Del Festival Delle Arti 2016
1 CAMPO VAPORETTO Fermata Sacca Fisola Spazi Derive e nuovi approdi 2 CENTRO XXV APRILE Calle del Teatro 1, Sacca Fisola 3 GIUDECCA 795 ART GALLERY In un contesto difficile e distratto, il tema della settima edizione del Fondamenta S. Biagio 795 Festival delle Arti vuole essere un invito a salpare verso destinazioni 4 FONDAMENTA S. BIAGIO sconosciute e imprevedibili, usando la “deriva” psicogeografica come 5 AREA “CASETTE” pratica estetica di lettura di un territorio urbano in continua 6 CAMPO S. COSMO trasformazione. 7 EX CONVENTO SS. COSMA E DAMIANO Abbiamo invitato gli artisti a rapportarsi con lo spazio pubblico di Campo S. Cosmo 620/A Giudecca e Sacca Fisola con percorsi sino ad ora inesplorati, per 8 ASS. IL CENTRO DELLA LUCE DORATA sorprendersi, avere nuove visioni, aggiungervi dimensione ed Corte Nova 633 emozione, capirne le peculiarità, lasciandosi ispirare per opere 9 FONDAMENTA S. EUFEMIA Come raggiungerci Porticato della Chiesa inedite. 10 XFRAME STUDIO I partecipanti potranno misurare le proprie gesta performative con Fermate dei mezzi di trasporto pubblico Actv: Sacca Fisola, Palanca, Redentore, Zitelle Fondamenta S. Eufemia 673 l'aperto di corti e fondamenta, il percorribile di calli e callette, il > linea 2 e 4.1 da Ferrovia e da P.le Roma (parcheggio auto) direz. S.Zaccaria 11 FONDAMENTA S. EUFEMIA e CALLE DEL PISTOR navigabile di canali e lagune, lo scavalcabile dei muri e l’elevabile > linea 2 da Tronchetto (parcheggio auto) direzione S. Zaccaria 12 PATRONATO DON BOSCO delle altane. > linea 2 da Zattere direzione S. Zaccaria Calle lunga de l’Accademia dei Nobili 618 > linea 2 e 4.2 da S. -

Urban Accessibility of Historical Cities: the Venetian Case Study Valeria Tatano, Francesca Guidolin, Francesca Peltrera
World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Humanities and Social Sciences Vol:11, No:5, 2017 Urban Accessibility of Historical Cities: The Venetian Case Study Valeria Tatano, Francesca Guidolin, Francesca Peltrera original functionality or to add new functions, while always Abstract—The preservation of historical Italian heritage, at the safeguarding its historical and cultural value. urban and architectural scale, has to consider restrictions and In historical refurbishment intervention it is often necessary requirements connected with conservation issues and usability needs, to intervene ensuring appropriate levels of accessibility, which are often at odds with historical heritage preservation. Recent reducing as much as possible the presence of architectural decades have been marked by the search for increased accessibility not only of public and private buildings, but to the whole historical barriers. city, also for people with disability. Moreover, in the last years the Making the country’s heritage accessible to people with concepts of Smart City and Healthy City seek to improve disabilities, means restoring and adapting urban spaces, while accessibility both in terms of mobility (independent or assisted) and looking for solutions that are able to combine restoration fruition of goods and services, also for historical cities. The principles preservation requirements with those of Inclusive Design and of Inclusive Design have introduced new criteria for the improvement regulations that guarantee their correct application; however, it of public urban space, between current regulations and best practices. Moreover, they have contributed to transforming “special needs” into is not always to achieve this aim. This is especially the case in an opportunity of social innovation. -

Project of Territorial Governance of Tourism in Venice
Project of territorial governance of tourism in Venice Project of territorial governance of tourism in Venice 2 Project of territorial governance of tourism in Venice Table of Contents FOREWORD.............................................................................................................................................................7 FIRST PART:...........................................................................................................................................................11 THE START OF A PARTICIPATORY ROUTE.................................................................................................................11 1. The functions of tourism and the regulatory framework...............................................................................13 2. Tourism in Venice..........................................................................................................................................15 3. The resident population................................................................................................................................22 4. The stages of the participatory route.............................................................................................................25 5. Principal mission statements of the projects presented and adopted by the Technical Working Group..........27 SECOND PART:.......................................................................................................................................................43 OPERATIONAL -

From Railway Station Santa Lucia / Piazzale Roma from Airport Marco
S.Alvise Ponte della Libertà Sacca S.Alvise Fond.Dei Riformati Fond. Sacca S.Girolamo Canossiane 8 C.Lun.Penitenti Fond.Contarini Chiesa di C.d.Capitello C.d.Legname S.Alvise Rio S.Alvise C.d.Rotonda ISOLA DI MURANO Campo Fond.Coletti S.Alvise Ospedale Fatebenefratelli C.Capuccine C.d.Riformati Rio S.Girolamo Calle Fondamenta della Sensa C.llo Piave ISOLA DI Fondamenta de le Capuzine Chiesa della S.Girolamo C.Rubini Madonna dell'Orto C.lle Ferau Madonna dell'Orto Fond. de le Case Nove C.Pisani Calle Gradisca S.MICHELE C.te Cavallo Tre Fondamenta S.Girolamo Capitello Fond.Mad.Orto Archi 9 C.l.Piave Chiesa di C.Muneghe Campo S.Michele Corte C.llo Madonna Calle de l'Artigia Zappa d. Battello Fondamenta Ormesini dell'Orto en C.Angelo Fond. G. Contarini Ponte Calle LoredanFond.dei Mori Cristo dei Tre Archi C.Malvas. C.Brazzo C.llo Campo S.Michele Cimitero Cà Pesaro Madonna Nuovo Campo d.Mori Fond. S.Giobbe Corte Calle Scuro del Ghetto dei Vedei C.tintoret. no Basilica di C.d.ColoriMagazz Crea C.2 corti Fondamenta di Cannaregio Museo S.Maria Calle de le Beccarie Ebraico C.Forner e Donato Hotel ScalaVecchio mat. Fondamenta della C.Muti Calle del C.Larga Calle s.Giovanni Museo Paradiso Fond.Savorgnan Sinagoga Fondamente Nove Chiesa di Calle d.Chioverette G.NuovoC.lle d. Masena 24 del Vetro C.llo C.Gropp S.Giobbe Corte Vecchia Calle delle Conterie Soffiador Calle Cereria d. Scuole Misericordia Fond. Abbazia R.T.Crea Fondamenta Venier C.d.Forno Museo C.Busello Fond. -

Presentazione I Tesori Della Laguna Venezia 2015
Via Bastie, 112/D – 30034 Dogaletto di Mira (VE) - tel. 348 9491120 www.mavericknauticlub.com - email: [email protected] 16 – 17 maggio 2015 7° EDIZIONE “““I“III TESORI DELLA LAGUNA DI VENEZIAVENEZIA”””” Cari Soci e Amici, benvenuti alla VII° edizione dei Tesori della Laguna di Venezia. Anche quest’anno, andremo alla ricerca di angoli nascosti della nostra laguna, ovvero di qualche luogo che magari abbiamo già visitato con il nostro gommone, ma forse troppo in fretta e senza ben conoscerne la storia. Attraverseremo dunque tutta la laguna partendo da Sud (così potremo anche dar libero sfogo ai nostri cavalli, mare permettendo!), iniziando dalla Valle Millecampi, e per la precisione dal Casone Millecampi, caratteristico esempio di architettura lagunare dei secoli scorsi, inserito in un contesto ambientale molto suggestivo. E' l'unico lembo lagunare della Provincia di Padova, poco lontano da Chioggia, al di la dei grandi scavi di canalizzazione e deviazione dei fiumi Brenta e Bacchighione. Tutt'attorno la terraferma strappata alla laguna con le opere di bonifica iniziate già nel 1500 per volere del ricco possidente, nonché famoso mecenate, Alvise Cornaro. Qui ormeggeremo per una visita al luogo, recentemente ristrutturato. Pranzo al sacco, e nel pomeriggio, partenza per l’Isola della Certosa, situata nelle immediate vicinanze di Venezia, dove ormeggeremo e allestiremo le tende per la notte. L’isola, che fino a 10 anni fa giaceva in stato di abbandono, è stata recentemente interessata da un ampio processo di valorizzazione, nel rispetto dell’ambiente e del particolare contesto storico e ambientale della Laguna di Venezia. Infatti, dapprima è stata costruita una darsena, con circa 300 posti barca fino a 40 metri. -
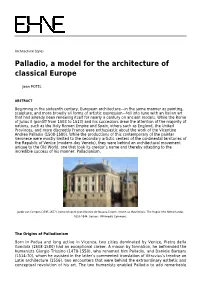
Palladio, a Model for the Architecture of Classical Europe
Architectural Styles Palladio, a model for the architecture of classical Europe Jean POTEL ABSTRACT Beginning in the sixteenth century, European architecture—in the same manner as painting, sculpture, and more broadly all forms of artistic expression—fell into tune with an Italian art that had already been renewing itself for nearly a century on ancient models. While the Rome of Julius II (pontiff from 1503 to 1513) and his successors drew the attention of the majority of nations, such as the Holy Roman Empire and Spain, others such as England, the United Provinces, and more discreetly France were enthusiastic about the work of the Vicentine Andrea Palladio (1508-1580). While the productions of this contemporary of the painter Veronese were mostly limited to the secondary artistic centers of the continental territories of the Republic of Venice (modern-day Veneto), they were behind an architectural movement unique to the Old World, one that took its creator’s name and thereby attesting to the incredible success of his manner: Palladianism. Jacob van Campen (1595-1657), home of count Jean-Maurice de Nassau-Siegen, known as Mauritshuis, The Hague (the Netherlands), 1633-1644. Source : Wikimedia Commons. The Origins of Palladianism Born in Padua and long active in Vicenza, two cities dominated by Venice, Pietro della Gondola (1508-1580) had an exceptional career. A mason by formation, he befriended the humanists Giorgio Trissino (1478-1550), who renamed him Palladio, and Daniele Barbaro (1514-70), whom he assisted in the latter’s commented translation of Vitruvius’s treatise on Latin architecture (1556), two encounters that were behind the extraordinary esthetic and conceptual revolution of his art. -
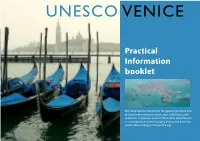
Practical Information Booklet
UNESCO VENICE Practical Information booklet This document is intended for the general guidance and practical information of visitors, new staff, interns, and volunteers. It provides pratical information about Venice, its transportation system, lodging, eating, and basic tips useful when visiting or living in the city Venice International airport Waterways The classical Venetian boat is the gondola, although it is now mostly www.veniceairport.it Climate used for tourists, or for weddings, funerals, or other ceremonies. Motorised waterbuses A visit to Venice in winter can be a great experience but you Alilaguna Shuttle Service (vaporetti) ply regular routes along the major canals and between the city’s islands. should be prepared for cold weather and for high water (acqua www.alilaguna.com Gondolas still in common use by Venetians are the traghetti, foot passenger boats cross- alta). Being by the sea, Venice rarely suffers from frost and an Associazione Alberghiera VeneziaSì Srl. tel. +39 041 5416555 ing the Grand Canal at certain points without bridges. average temperature in mid November is about 10 degrees fax: +39 041 522-1242 Water taxi Eating Cooperativa Motoscafi Call Center tel +39 041 522-2264 High waters Acqua Alta is the term for the exceptional tide peaks that occur pe- Venice is full of restaurants, featuring the cuisine of the Veneto. tel. +39 041 541-5084 Everyday from 8. a.m. to 9 p.m. riodically in the northern Adriatic Sea. The peaks reach their maximum in the Venetian For years Venice was the crossroads of the trading of spices Toll free number : 199 173 309 Lagoon, where they cause partial flooding of Venice and Chioggia. -

Contributo Di Accesso
CONTRIBUTO DI ACCESSO Proposta di delibera sul Regolamento per l’istituzione e la disciplina Elaborata con la collaborazione di: Intervento integrato • Messa a regime in 3 anni, conobiettivo l’obbligo della prenotazione per la gestione dei flussi, come indicato nel report inviato all’UNESCO • Conferma ZTLZTLZTL perperper l’accesso allaallaalla Città antica e avvio iter per l’assoggettamento al pagamento di una somma per i veicoli privati a motore, come già previsto dal Piano Urbano del Traffico • Campagna promozionale sulla stampa nazionale ed internazionale del progetto###EnjoyRespectVenezia #EnjoyRespectVenezia • Rafforzamento nel 2019 delcontingente dididi Polizia Locale, conconcon almeno 505050unitàunità, per aumentare il presidio ed il controllo della città. Perimetro di applicazione Il perimetro di applicazione è individuato: • nell’Ambito Territoriale Omogeneo nnn. n...111 “Venezia Città Antica” allegato al Piano di Assetto del Territorio; • ininintutte lelele “isole minori della laguna” deldeldel Comune dididi VeneziaVenezia: Lido di Venezia - Malamocco - Alberoni - Pellestrina - Cà Roman - Murano - Burano - Torcello - Mazzorbo - Mazzorbetto - San Francesco del Deserto - Sant’Erasmo - Vignole - Certosa - Sant’Andrea - San Servolo - San Lazzaro degli Armeni - San Clemente - La Grazia - Sacca Sessola - Poveglia - Lazzaretto Vecchio - Lazzaretto Nuovo - Madonna del Monte - San Ariano - San Giacomo in Paludo - Fisolo - San Giorgio in Alga - Sant’Angelo della Polvere - Santo Spirito - San Secondo - La Cura - Santa Cristina - Motta San -

Ocdpcn 616/2019
DECRETO DEL C.D. n. 4 del 18 aprile 2020 - ALLEGATO 1 O.C.D.P.C. N. 616/2019 - ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 12 NOVEMBRE 2019 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA Contributi per l’immediato sostegno alla popolazione – PRIVATI - art. 25, comma 2, lettera c), Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 QUADRO RIEPILOGATIVO SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO - PRIMO STRALCIO – ELENCO DEI CONTRIBUTI LIQUIDABILI A FAVORE DI PRIVATI LEGENDA: Indennizzi assicurativi quantificati: N=non quantificato Liquidazione Totale o Parziale del contributo richiesto: P=parziale; T=totale. GENERALITÀ RENDICONTAZIONE Rendicontato Liquidazione Costi effettivamente sostenuti, Totale o Indennizzi assicurativi ammissibile al netto CONTRIBUTO Numeraz. Numero Protocollo Nominativo del dichiarante Indirizzo unità immobiliare interessata documentati, ammissibili alla Parziale del quantificati degli indennizzi elenco domanda (COGNOME – NOME) dall’evento data del Decreto contributo EROGABILE (B) (A) (A-B) richiesto DORSODURO 1539, DORSODURO, S. 1 10 GALLOTTI DARIO POLO, S. CROCE, GIUDECCA, SACCA € 444,00 N € 444,00 T € 444,00 FISOLA SAN MARTINO DESTRA 513, BURANO, 2 17 CERINI FIORELLA € 610,00 N € 610,00 T € 610,00 MAZZORBO, TORCELLO PELLESTRINA 546, PELLESTRINA, S. 3 36 SCARPA MARIO € 550,00 N € 550,00 T € 550,00 PIETRO IN VOLTA CASTELLO 5091, S. MARCO, CASTELLO, S. 4 45 FORT LORENZO € 430,00 N € 430,00 T € 430,00 ELENA, CANNAREGIO DORSODURO 1904/E, DORSODURO, S. 5 80 COMERCI DANIELE POLO, S. CROCE, GIUDECCA, SACCA € 3.115,00 N € 3.115,00 T € 3.115,00 FISOLA PELLESTRINA 1062, PELLESTRINA, S. 6 94 GHEZZO MAURO € 1.448,00 N € 1.448,00 T € 1.448,00 PIETRO IN VOLTA DORSODURO 716, DORSODURO, S. -

Convegno Per La Conservazione
GIUSEPPE MORANDINI ELEMENTI GEOGRAFICI ED ASPETTI MORFOLOGICI DELLA LAGUNA 1. ELEMENTI GEOGRAFICI. - Lungo le coste della penisola italiana si notano particolari formazioni morfologiche dette lagune, il cui tipo è ben noto ai geografi e risponde a un particolare aspetto di specchio d'acqua, caratteristico delle spiaggie, separato dal mare da cordoni litoranei o lidi più o meno frastagliati o continui. La più nota delle lagune d'Italia è certamente la Laguna di Venezia sia per la Città che ne emerge, onusta d'arte e di storia, sia perché gli studi e le indagini antiche e recenti di taluni problemi che la riguardano sono raccolti in una monumentale Monografia (1) ancora in corso a cura del Comitato italiano della Commissione internazionale per l'esplorazione scientifica del Mediterraneo. Numerosi sono anche altri motivi di larga rinomanza nella veneta Laguna, ma è certo sufficiente l'accenno a quelli sovra ricordati. Ma, dovendo della Laguna lumeggiare qualche elemento geografico e morfologico risulta che essa è tra quelle d'Italia, per non dire tra tutte, certo una delle meglio conosciute sotto il profilo cartografico. Troppo lungo, e in un certo senso superfluo, sarebbe anche la sola menzione della serie di carte che della nostra Laguna mostrano la forma e rivelano anche qualche particolarità morfologica. 1 COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER L'ESPLORAZIONE SCIENTIFICA DEL MEDITERRANEO. DELEGAZIONE ITALIANA, La Laguna di Venezia. Monografia fondata da Giovanni Magrini e continuata con la collaborazione del Magistrato alle Acque di Venezia. Volumi finora pubblicati: Vol. I, Parte I, Tomo I - Vol. I, Parte II, Tomo II, Fasc. I, Fasc. III - Vol. -
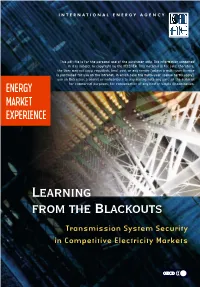
Learning from the Blackouts
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY This pdf-fi le is for the personal use of the purchaser only. The information contained in it is subject to copyright by the OECD/IEA. This material is for sale; therefore, the User may not copy, republish, lend, post on any server (unless a multi-user licence is purchased for use on the intranet, in which case the multi-user license terms apply), use on Web sites, transmit or redistribute to any mailing lists any part of the material ENERGY for commercial purposes, for compensation of any kind or simple dissemination. MARKET EXPERIENCE Learning from the Blackouts Transmission System Security in Competitive Electricity Markets INTERNATIONAL ENERGY AGENCY The International Energy Agency (IEA) is an autonomous body which was established in November 1974 within the framework of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) to implement an international energy programme. It carries out a comprehensive programme of energy co-operation among twenty-six of the OECD’s thirty member countries. The basic aims of the IEA are: • to maintain and improve systems for coping with oil supply disruptions; • to promote rational energy policies in a global context through co-operative relations with non-member countries, industry and international organisations; • to operate a permanent information system on the international oil market; • to improve the world’s energy supply and demand structure by developing alternative energy sources and increasing the efficiency of energy use; • to assist in the integration of environmental and energy policies. The IEA member countries are: Australia, Austria, Belgium, Canada, the Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Japan, the Republic of Korea, Luxembourg, the Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the United Kingdom, the United States. -

The Certosa Island Redevelopment: a Public - Private Partnership for Sustainability in the Venice Lagoon
The Certosa Island Redevelopment: A Public - Private Partnership for Sustainability in the Venice Lagoon Alessandro Costa Venice International University Head of Strategic Development & International Cooperation Ports, Maritime Transport & Insularity - Business, Innovation, Environment Piraeus, March 10-11, 2016 Venice International University In Venice / 14 universities from 3 continents / 1 common campus / facing global themes-issues / undergraduate – graduate / institutional capacity building / think tank / knowledge sharing 2 ISOLA DELLA CERTOSA V e n i c e 3 What I’ll be talking about • What is Certosa Island (and where) • A little bit of history… • The PPP masterplan • The remediation process • The sustainabe energy plan • Pilot projects • Q&A 4 Isola della Certosa New urban park, currently under completion, including a protected remenant woodland. Large marina (300+ berths), that can host yachts up to 60 m of length. Dry docks, shipyards, sailing school, hosting facilities (hotel, bar, restaurant). • Area: 24 hectares • Current built surface : 5.000 sqm • Next building develoment: additional 23.000 sqm (45 buildings demolished and to be re-built) Vento di Venezia (VdV) • Managed water surface: 45.000 sqm • Berths / average boat length : 320 / 16 m 5 Venice Lagoon Venice and its Lagoon 6 6 Certosa location Aeroporto Marco Polo MestreMestre Aeroporto Marco Polo Murano Murano S.ErasmoS.Erasmo VENEZIAVENEZIA Certosa Certosa LidoLido AdriaticMare Adriatico Sea 7 Certosa surroundings Certosa strategic position, at the heart of an insular subsystem. Vignole VENICE S.Andrea Certosa Lido Adriatic Sea 8 The history of Certosa Island Between the 13th and the 18th Century, the island was home to a monastery of Augustinian and Carthusian monks, who carried out both religious and agricultural activities.