Capitale Mafioso” in Emilia E in Lombardia Orientale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Uccisi I Cugini Del Pentito Calderone
VENERDÌ 11 SETTEMBRE 1992 IN ITALIA PAGINA 13 L'UNITÀ A Bari I killer della mafia hanno ammazzato Una delle vittime era parente dei Costanzo si ristruttura i fratelli Marchese, intoccabili della cosca L'altra era il vecchio capofamiglia il teatro dei clan dominanti della costa orientale Margherita legata al superlatitante di Cosa Nostra iS3b£&rrx«mèm: Da ieri il teatro Margherita di Bari (nella foto) è avvolto Gli investigatori: è l'inizio di una guerra Altri agguati in serata: un morto da teloni che ne riproducono la facciata e ravvivano nella memoria collettiva uno degli edifici più caratteri stici della città, eretto su palafitte di cemento armato al- : l'inizio del lungomare a fare da sfondo a corso Vittorio Emanuele, la cerniera fra il centro storico e i nuovi quar tieri dell'espansione ottocentesca. L'edificio, abbando nato da più di dieci anni e pesantemente degradato, è stato affidato in concessione dallo Stato al gruppo Dio- Uccisi i cugini del pentito Calderone guardi che nei prossimi 12 mesi provvedere a proprie spese (circa 400 milioni) ad evitare l'ulteriore degrado dell'immobile e alla redazione di un progetto per il re cupero e riutilizzo del teatro al quale collaboreranno ar chitetti, urbanisti, sociologi ed esperti di restauro guidati Faida a Catania, massacrati due uomini del boss Santapaola da Renzo Piano. Assassinato a Catania Salvatore Marchese, perso cusati di traffico di droga, Pa i Calderone da Rosario Grasso, «Gli acquarelli «Gli acquarelli di Adolf Hit naggio di spicco del clan Santapaola e cugino del squale Costanzo, zio della mo «sani u'bau». -

Andreotti a Processo L'amarezza Del Senatore: Un'ingiustizia
HEHEMl3MM» Si celebrera il 26 settembre. Caselli: «Legittime le nostre accuse* Andreotti a processo L'amarezza del senatore: un'ingiustizia • Ciulio Andreotti non £ peiseguitato dai cesso dei quale avrebbero comunque ialto vo- penliti. I giudici che lo accusano non sono vi- lenlieri a meno. Non e setvHo a nulla. Lex lea sionaii. Andreoni Gulio deve essere processato der dc con alle spalle mezzo secolo di rlballa a Palermo, per mafia. II piocesso Inziera il 26 politics nazionalee inlemazionate. reagisceco- Inchiesta vera settembre. alia quinta sezione. I! giudice dell'u- sl alia decisions che lo accusa di aver gesuto il dienza pteiiminare, Agostino Gristina, e gitinlo poteie favorendo anche assassini e traflicanti: ierisera, alle 17 e SO. doposei ore di camera di •Aflronto con amarezza un ingiusto processo. non un teorema consiglio, a una decisione clamorosa, per nulla Pensavo che due anni di mortificante atiesa los- scontata: respingere in teto gli argomenti dei di- sero sufficient per acquisire la verita. L'unico fensori di Andreotti. accogliere le lesl dei tre vantaggio del dibattiro pubbtco e che i lestimo- pubblci ministeri, Roberto Scarpinalo, Guido Lo ni possono essere inlerrogati e coniroinierroga- m WIPM CMJiMIOlA Forte. Gioacchino Navoli. Gli awocali difensori, ti». Per Andreotti. quelia di ieri estala. almeno in Odoardo Ascari e Franco Coppi, presentando apparenza, una giomala come le altre. Prima di I SONO DUE commenti, che ieri un'aHra memoria di 61 carlelle, awvano an chiudersi nel suo studio, ha delto: »Oggi sono hanno segulto e preceduto la cora una voMa martellato su due lasti: I'inatfida- qui per fare il senatore...*. -

STRUTTURE Cosa Nostra E 'Ndrangheta a Confronto
STRUTTURE Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto Francesco Gaetano Moiraghi Andrea Zolea WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea La mafia dura da decenni: un motivo ci deve essere. Non si può andare contro i missili con arco e frecce: in queste vicende certe intemperanze si pagano duramente. Con il terrorismo, con il consenso sociale, potevi permettertele: con la mafia non è così. Nella società c’è un consenso distorto. Altro che bubbone in un tessuto sociale sano. Il tessuto non è affatto sano. Noi estirperemo Michele Greco, poi arriverà il secondo, poi il terzo, poi il quarto. Giovanni Falcone 1 www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea PREMESSA Questo lavoro ha lo scopo di offrire uno sguardo d’insieme sulle articolazioni strutturali delle organizzazioni mafiose denominate Cosa nostra e ‘ndrangheta . La prima sezione, curata da Francesco Gaetano Moiraghi, si concentra sull’analisi di Cosa nostra. La seconda sezione, che sposta il focus sulla ‘ndrangheta, è curata da Andrea Zolea. Come si potrà notare, le due sezioni non sono state realizzate secondo uno stesso modello, ma analizzano le due organizzazioni con un approccio differente. Ad esempio, la parte su Cosa nostra avrà un orientamento maggiormente diacronico, diversamente da quella sulla ‘ndrangheta, basata su un approccio sincronico. Il presente testo ha infatti l’obiettivo di offrire due proposte di analisi differenti che riescano a mettere in luce le analogie e le differenze delle strutture delle due organizzazioni mafiose. -

Ius Novum 3-08.Indd
Ius Novum 3 2008 ISSN 1897-5577 WARSZAWA 2008 KOLEGIUM REDAKCYJNE Marek Chmaj, Teresa Gardocka (przewodnicząca), Bogudar Kordasiewicz, Maria Kruk-Jarosz, Franciszek Longchamps de Bérier, Andrzej Marek, Jerzy Menkes, Henryk Olszewski, Jacek Sobczak (zastępca przewodniczącego) REDAKCJA Ryszard A. Stefański (redaktor naczelny), Andrzej Szlęzak (zastępca redaktora naczelnego), Jacek Kosonoga (sekretarz redakcji) Copyright © by Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie Warszawa 2008 ISSN 1897-5577 Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43 tel. 0-22 54 35 450, 0-22 54 35 410 www.lazarski.pl [email protected] Opracowanie komputerowe, druk i oprawa: Dom Wydawniczy ELIPSA ul. Infl ancka 15/198, 00-189 Warszawa tel./fax 0-22 635 03 01, 0-22 635 17 85, e-mail: [email protected], www.elipsa.pl SPIS TREŚCI ARTYKUŁ Y Dr Zbigniew Ję drzejewski, UW System i topika w nauce o przestępstwie . 5 Dr Ryszard Szał owski, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Zakres przedmiotowy tajemnicy państwowej . 22 Mgr Adrianna Mię kina, Zabójstwo w środowisku mafijnym . 38 Dr hab. R yszard Stefań s k i, prof. WSHiP Zasady bezpieczeństwa w ruchu w doktrynie i orzecznictwie. Część II. 53 Dr Maria Sobczak, UAM Wolność sumienia i wyznania, jej gwarancje w systemie prawnym Rady Europy oraz w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu . 87 Mgr Aleksandra Gliszczyń s k a, Instytut Nauk Prawnych PAN Zalecenia Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji w zakresie walki z antysemityzmem oraz ich realizacja przez Polskę . 117 Dr Przemysł aw Szustakiewicz, adiunkt WSHiP Najwyższa Izba Kontroli – czwarta władza czy organ Sejmu . -

Nomi E Storie Delle Vittime Innocenti Delle Mafie
Nomi e storie delle vittime innocenti delle mafie a cura di Marcello Scaglione e dei ragazzi del Presidio “Francesca Morvillo” di Libera Genova Realizzato in occasione della mostra “900 Nomi vittime di mafia dal 1893 ad oggi” inaugurata ad Imperia il 21 Marzo 2016 in occasione della XXI Giornata della memoria e dell’impegno - ”Ponti di memoria, luoghi di impegno”. I nomi presenti nella mostra sono quelli accertati fino all'anno 2015, ed in particolare quelli letti a Bologna durante la XX Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo 2015). Il lavoro di ricerca, inizialmente limitato a quell'elenco, è stato poi implementato e aggiornato, comprendendo quindi le storie delle vittime innocenti i cui nomi sono stati letti durante la XXI Giornata della Memoria e dell'Impegno (21 marzo 2016). Sarà nostro impegno e cura eseguire successivamente gli aggiornamenti necessari. Siamo inoltre disponibili a intervenire sulle singole storie, laddove dovessero essere ravvisati errori e/o imprecisioni. EMANUELE NOTABARTOLO, 01/02/1893 Nato in una famiglia aristocratica palermitana, presto rimane orfano di entrambi i genitori. Cresciuto in Sicilia, nel 1857 si trasferisce prima a Parigi, poi in Inghilterra, dove conosce Michele Amari e Mariano Stabile, due esuli siciliani che lo influenzeranno molto. Avvicinatosi all'economia e alla storia, diventa sostenitore del liberalismo conservatore (quindi vicino alla Destra storica). Dal 1862 Emanuele Notarbartolo diventa prima reggente, poi titolare, del Banco di Sicilia, al quale si dedica a tempo pieno a partire dal 1876, salvandolo dal fallimento in seguito all'Unità d'Italia. Il suo lavoro al Banco di Sicilia inizia a inimicargli molta gente. -

“FINE PENA: ORA” DI ELVIO FASSONE Di Davide Galliani
Rivista di Studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata Cross Vol.2 N°1 (2016) ISSN 2421-5635 Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata INDICE Presentazione QUESTO NUMERO di N.d.C ....................................................................................................................................................................... 1 Recensione/dibattito 1 RIFLESSIONI SPARSE SUL DELITTO DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA. A PARTIRE DALLA TERZA EDIZIONE DEL LIBRO DI GIULIANO TURONE di Fabio Basile ......................................................................................................................................................... 3 Recensione/dibattito 2 UNA QUESTIONE DI LIMITI. A PROPOSITO DI “FINE PENA: ORA” DI ELVIO FASSONE di Davide Galliani ................................................................................................................................................ 13 Dibattito LA MOBILITASION ANTIMAFIA DE 1992 di Charlotte Moge ................................................................................................................................................ 32 La ricerca 1 TRA NARCOS E STATO. LE FORME DELLA RESISTENZA CIVILE IN MESSICO di Thomas Aureliani ........................................................................................................................................... 61 La ricerca 2 A PROPOSITO DI MAFIA CAPITALE. SPUNTI PER TIPIZZARE IL FENOMENO MAFIOSO NEI SISTEMI DI COMMON LAW di Anna Sergi ........................................................................................................................................................ -
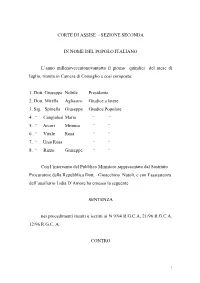
Processo Lima
CORTE DI ASSISE - SEZIONE SECONDA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L’anno millenovecentonovantotto il giorno quindici del mese di luglio, riunita in Camera di Consiglio e così composta: 1. Dott. Giuseppe Nobile Presidente 2. Dott. Mirella Agliastro Giudice a latere 3. Sig. Spinella Giuseppe Giudice Popolare 4. “ Cangialosi Maria “ “ 5. “ Arceri Mimma “ “ 6. “ Vitale Rosa “ “ 7. “ Urso Rosa “ “ 8. “ Rizzo Giuseppe “ “ Con l’intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Gioacchino Natoli, e con l’assisstenza dell’ausiliario Lidia D’Amore ha emesso la seguente SENTENZA nei procedimenti riuniti e iscritti ai N 9/94 R.G.C.A, 21/96 R.G.C.A. 12/96 R.G.C. A. CONTRO 1 1) RIINA Salvatore n. Corleone il 16.11.1930 Arrestato il 18.01.1993 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO- Detenuto per altro - Assente per rinunzia Assistito e difeso Avv. Cristoforo Fileccia Avv. Mario Grillo 2) MADONIA Francesco n. Palermo il 31.03.1924 Arrestato il 21.04.1995 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Giovanni Anania Avv. Nicolò Amato del foro di Roma 3) BRUSCA Bernardo n. San Giuseppe Jato il 09.09.1929 Arrestato il 21.10.1992 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Ernesto D’Angelo 4) BRUSCA Giovanni n. San Giuseppe Jato il 20.02.1957 Arrestato il 23.05.1996 - Scarcerato il 10.04.1998 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Luigi Li Gotti del foro di Roma Avv. -

Doc. XXIII, N. 44
CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA Doc. XXIII N. 44 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE (istituita con legge 19 luglio 2013, n. 87) (composta dai deputati: Bindi, Presidente, Attaguile, Segretario, Bossa, Bruno Bossio, Carbone, Costantino, Dadone, Di Lello, Segretario, D’Uva, Garavini, Magorno, Manfredi, Mattiello, Naccarato, Nuti, Piccolo, Piepoli, Prestigiacomo, Sammarco, Sarti, Savino, Scopelliti, Taglialatela e Vecchio; e dai senatori: Albano, Buemi, Bulgarelli, Capacchione, Cardiello, Consiglio, De Cristofaro, Di Maggio, Esposito, Falanga, Gaetti, Vicepresidente, Giar- russo, Giovanardi, Lumia, Marinello, Mineo, Mirabelli, Molinari, Moscar- delli, Pagano, Perrone, Ricchiuti, Tomaselli, Vaccari e Zizza). IL FURTO DELLA NATIVITÀ DEL CARAVAGGIO (Relatrice: on. Rosy Bindi) Approvata dalla Commissione nella seduta del 21 febbraio 2018 Comunicata alle Presidenze il 22 febbraio 2018 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. o), della legge 19 luglio 2013, n. 87 STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO PAGINA BIANCA Camera dei Deputati —3— Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XXIII N. 44 Camera dei Deputati —4— Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XXIII N. 44 Camera dei Deputati —5— Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XXIII N. 44 INDICE 1. Premessa .............................................................................. Pag. 7 2. Le indagini pregresse sul furto della Natività e le loro risultanze ............................................................................. » 8 3. L’inchiesta della Commissione parlamentare antimafia .. » 12 3.1. Le dichiarazioni di Gaetano Grado: “’U Caravaggiu”. » 13 3.2. Le dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia: “Ho detto che il quadro è stato bruciato” ............. -

Bomba All'addaura
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Alle ore 07.30 del 21 giugno 1989 su una piattaforma in cemento sulla scogliera antistante la villa abitata dal giudice Giovanni Falcone in località Addaura, sul lungomare Cristoforo Colombo n.2731, gli agenti di polizia in servizio di vigilanza Lo Re, Di Maria, Lo Piccolo e Lindiri nel corso di una ricognizione rinvenivano una muta subacquea, un paio di pinne, una maschera tipo “Solana” ed una borsa sportiva contenente una cassetta metallica con numerosi candelotti di esplosivo innescato da due detonatori elettrici collegati ad un congegno elettro-meccanico comandato da una apparecchiatura radio-ricevente. Sul luogo del rinvenimento dell’esplosivo veniva chiamato ad intervenire l’artificiere dei carabinieri Francesco Tumino il quale, per impedire l’esplosione della carica radiocomandata, aveva provveduto a fare esplodere una microcarica per disarticolare il collegamento tra la sostanza esplosiva ed il meccanismo di innesco, i cui frammenti erano stati successivamente recuperati anche attraverso l’impiego di sommozzatori nello specchio di mare antistante, prima di aprire la cassetta metallica in cui era stato poi rinvenuto l’esplosivo. La particolare collocazione della carica esplosiva induceva gli inquirenti 1 immediatamente intervenuti sul luogo a ritenere che la stessa fosse diretta alla realizzazione di un attentato nei confronti del predetto magistrato, da tempo impegnato in prima linea in numerosi processi contro la criminalità organizzata e, in particolare, contro la pericolosa organizzazione mafiosa “cosa nostra”, quale esponente di punta del cd. “pool antimafia” costituito presso l’ufficio istruzione del Tribunale di Palermo dal consigliere Rocco Chinnici, ucciso pochi anni prima in un attentato realizzato con l’impiego di una auto-bomba collocata difronte all’ingresso della sua abitazione. -

Processo Omicidio Francese
CORTE DI ASSISE DI APPELLO PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L’anno duemiladue il giorno 13 del mese di dicembre N° 61/2002 Sent. LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI PALERMO N° 30/2002 R.G. SEZIONE SECONDA N° 1314/96 N.R. composta dai Sigg.ri : D.D.A. PA 1. Dott.1 Vincenzo OLIVERI Presidente Art. ______________ 2. Dott.2 Gianfranco GAROFALO Consigliere Camp. Penale 3. Sig.3 Giovanni INCANDELA Giud. Popolare Art.______________ 4. Sig.4 Giovanni GAROFALO “ “ Campione Civile 5. Sig.5 Isabella ZUMMO “ “ 6. Sig.6 Nicola TURRISI “ “ Compilata scheda per il Casellario e per 7. Sig.7 Antonio RIGGIO “ “ l’elettorato Addì______________ 8. Sig.8 Giuseppa GIAMMARINARO “ “ Depositata in con l’intervento del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cancelleria Antonino GATTO e con l’assistenza del cancelliere B3 Sig. Addì_______________ Aurelio DI CRISTINA ha pronunziato la seguente Irrevocabile il _________________ S E N T E N Z A nei confronti di : 1) RIINA SALVATORE, fu Giovanni e Rizzo Maria Concetta, nato a Corleone il 16.11.1930 ed ivi residente in via La Rua del Piano n. 13. Detenuto in forza di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 12.11.1998 dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, notificata in carcere il 17.11.1998, in atto presso la Casa Circ.le di Ascoli Piceno. ASSENTE PER RINUNZIA Difensori: Avv. Cristoforo Fileccia del Foro di Palermo Avv. Domenico La Blasca “ “ 1 2) MADONIA FRANCESCO, fu Antonino e fu Trapani Rosa, nato a Palermo il 31.3.1924 ed ivi residente via Patti n. -

LA MAFIA PALERMITANA Fazioni, Risorse, Violenza (1943-1993)
EDIZIONI LA MAFIA PALERMITANA Fazioni, risorse, violenza (1943-1993) di Vittorio Coco Coco, Vittorio <1980-> La mafia palermitana / Vittorio Coco – Palermo : Centro di studi ed iniziative culturali Pio La Torre, 2010. (Collana studio e ricerca) 1. Mafia - Palermo - 1943-1993. 364.10609458231 CDD-21 SBN Pal0224465 CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace” Comitato Scientifico: Prof. Guido Corso, Prof. Alessandra Dino e Prof. Salvatore Lupo. 5 Nota editoriale di Vito Lo Monaco, Presidente Centro Pio La Torre 7 Prefazione di Salvatore Lupo, storico 9 Introduzione 11 Il contesto La Piana dei Colli e lo sviluppo urbano di Palermo dal secondo dopoguerra Parte Prima Tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Al centro della ripresa postbellica 23 Mafia ed edilizia: il costruttore Francesco Vassallo 31 L’ascesa di Angelo La Barbera 39 Da una guerra all’altra Parte Seconda Tra gli anni Settanta e Ottanta. Ai margini dopo l’antimafia 45 La perdita della centralità 51 Al fianco dei corleonesi 55 Dal maxi-processo alla riconquista dell’autonomia 61 Indice dei nomi 65 Indice dei luoghi di Vito Lo Monaco La ricerca di Vittorio Coco, a seguito di un bando pubblico del Centro Studi Pio La Torre che ha impegnato parte del contributo finanziario della Regione Sicilia, fa parte di un insieme di studi in via di pubblicazione. Per un anno tra il 2008 e il 2009 sei giovani ricercatori, guidati volontariamente da rispettivi comitati scientifici e tutor di alto profilo, hanno lavorato con tanto profitto da convincere il Centro a proseguire la ricerca nel 2010. L’idea generale della ricerca riguarda l’esplorazione della complessità del fenomeno ma- fioso tramite l’osservazione della storia e del rapporto col territorio di “famiglie” le cui relazioni interne ed esterne circoscrivono la natura specifica dell’organizzazione mafiosa e il suo rapporto organico con le classi dirigenti. -

Journal of Italian Translation
Journal of Italian Translation Journal of Italian Translation is an international journal devoted to the translation of literary works Editor from and into Italian-English-Italian dialects. All Luigi Bonaffini translations are published with the original text. It also publishes essays and reviews dealing with Italian Associate Editors translation. It is published twice a year. Gaetano Cipolla Michael Palma Submissions should be in electronic form. Trans- Joseph Perricone lations must be accompanied by the original texts Assistant Editor and brief profiles of the translator and the author. Paul D’Agostino Original texts and translations should be in separate files. All inquiries should be addressed to Journal of Editorial Board Italian Translation, Dept. of Modern Languages and Adria Bernardi Literatures, 2900 Bedford Ave. Brooklyn, NY 11210 Geoffrey Brock or [email protected] Franco Buffoni Barbara Carle Book reviews should be sent to Joseph Perricone, Peter Carravetta John Du Val Dept. of Modern Language and Literature, Fordham Anna Maria Farabbi University, Columbus Ave & 60th Street, New York, Rina Ferrarelli NY 10023 or [email protected] Luigi Fontanella Irene Marchegiani Website: www.jitonline.org Francesco Marroni Subscription rates: U.S. and Canada. Sebastiano Martelli Individuals $30.00 a year, $50 for 2 years. Adeodato Piazza Institutions $35.00 a year. Nicolai Single copies $18.00. Stephen Sartarelli Achille Serrao Cosma Siani For all mailing abroad please add $10 per issue. Marco Sonzogni Payments in U.S. dollars. Joseph Tusiani Make checks payable to Journal of Italian Trans- Lawrence Venuti lation Pasquale Verdicchio Journal of Italian Translation is grateful to the Paolo Valesio Sonia Raiziss Giop Charitable Foundation for its Justin Vitiello generous support.