QGL291-Varie- Quaderni Giorgiani 291
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Quaderni Di Archeologia Del Piemonte
Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli Quaderni di Archeologia del Piemonte Torino 2018 2 Direzione e Redazione Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo Sede operativa: piazza S. Giovanni 2 - 10122 Torino Tel. 011-195244 Fax 011-5213145 Direttore della Collana Egle Micheletto - Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo I contributi sono sottoposti a peer-review Comitato Scientifico Marica Venturino Federico Barello Francesca Garanzini Coordinamento Marica Venturino Comitato di Redazione Maurizia Lucchino Susanna Salines Segreteria di Redazione Maurizia Lucchino Editing ed elaborazione immagini Susanna Salines Progetto grafico LineLab.edizioni - Alessandria Editing dei testi, impaginazione e stampa La Terra Promessa Società Coop. Sociale - Onlus Polo Grafico di Torino AGIT Quando non diversamente indicato, i disegni dei reperti sono in scala 1:3 (ceramica, vetri), in scala 1:2 (industria litica levigata, metalli), in scala 1:1 (industria litica scheggiata) Il volume è stato pubblicato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino con la collaborazione della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti È possibile -

Politics and Policy: Rome and Liguria, 200-172 B.C
Politics and policy: Rome and Liguria, 200-172 B.C. Eric Brousseau, Department of History McGill University, Montreal June, 2010 A thesis submitted to McGill University in partial fulfillment of the requirements of the degree of Master of Arts. ©Eric Brousseau 2010 i Abstract Stephen Dyson’s The Creation of the Roman Frontier employs various anthropological models to explain the development of Rome’s republican frontiers. His treatment of the Ligurian frontier in the second century BC posits a Ligurian ‘policy’ crafted largely by the Senate and Roman ‘frontier tacticians’ (i.e. consuls). Dyson consciously avoids incorporating the pressures of domestic politics and the dynamics of aristocratic competition. But his insistence that these factors obscure policy continuities is incorrect. Politics determined policy. This thesis deals with the Ligurian frontier from 200 to 172 BC, years in which Roman involvement in the region was most intense. It shows that individual magistrates controlled policy to a much greater extent than Dyson and other scholars have allowed. The interplay between the competing forces of aristocratic competition and Senatorial consensus best explains the continuities and shifts in regional policy. Abstrait The Creation of the Roman Frontier, l’œuvre de Stephen Dyson, utilise plusieurs modèles anthropologiques pour illuminer le développement de la frontière républicaine. Son traitement de la frontière Ligurienne durant la deuxième siècle avant J.-C. postule une ‘politique’ envers les Liguriennes déterminer par le Sénat et les ‘tacticiens de la frontière romain’ (les consuls). Dyson fais exprès de ne pas tenir compte des forces de la politique domestique et la compétition aristocratique. Mais son insistance que ces forces cachent les continuités de la politique Ligurienne est incorrecte. -

I LIGURI APUANI Storiografia, Archeologia, Antropologia E Linguistica
I LIGURI APUANI storiografia, archeologia, antropologia e linguistica di Lanfranco Sanna I Liguri Prima di affrontare la storia dei liguri apuani è bene fare alcuni riferimenti sull' etnogenesi dei Liguri. Quando compare per la prima volta il nome «ligure» nella storia? Αιθιοπας τε Λιγυς τε ιδε Σκυθας ιππηµολγους «E gli Etiopi e i Liguri e gli Sciti mungitori di cavalle» L’esametro, citato da Eratostene di Cirene e da lui attribuito a Esiodo, conserva la più antica memoria dei Liguri giunta fino a noi (VIII-VII sec. a.C.). I Liguri, secondo i Greci, erano gli abitanti dell’Occidente. Esiodo L’aggettivo «ligure» ha un carattere letterario e linguistico allogeno, perché si deve totalmente inquadrare nell’evoluzione della fonetica greco-latina Ligues > Ligures. Anche oggi nessun dialetto ligure possiede il termine dialettale per definire se stesso tale, né un abitante delle regioni vicine chiamerà mai “liguri” gli abitanti della Liguria. Ma da dove deriva questo nome? All’inizio «Liguri» avrebbe significato «abitanti della pianura alluvionale del Rodano». I contatti dei navigatori e poi dei coloni greci proprio con le tribù liguri del delta del Rodano spiegherebbero la sua estensione a tutto ethnos. Sinteticamente l’origine e l’evoluzione del nome dei Liguri avrebbe seguito questo percorso: - 700 a. C.: i primi navigatori greci prendono contatti commerciali con gli Elysici di Narbona. Gli abitanti scendono nella pianura sottostante la rocca assumendo il nome di Ligues derivato dal sustrato indigeno e attribuito loro dai Greci. - 600 a. C.: i Focesi fondano Massalia (Marsiglia) e per estensione chiamano Ligues le popolazioni indigene sia a est cha a ovest del Rodano. -

1 Samnites, Ligurians and Romans Revisited John R. Patterson This
Samnites, Ligurians and Romans revisited John R. Patterson This volume has been peer-reviewed and will also be published by the Associazione Culturale “Cercellus” and GAL Alto Tammaro. 1 For Carlo Tartaglia Polcini 2 Contents/Indice Foreword (by Italo M. Iasiello) 4 Presentazione (di Italo M. Iasiello) 44 Preface 9 Prefazione 49 1. Introduction: problems and methodology 10 1. Introduzione: problemi e metodologia 50 2. The development of Rome and the conquest of Italy 14 2. Lo sviluppo di Roma e la conquista d’Italia 54 3. The expansion of the Roman Empire and the history of Samnium 16 3. L’espansione dell’impero romano e la storia del Sannio 56 4. Colonisation and the fall of the Republic 27 4. La colonizzazzione e le caduta della Repubblica 67 5. Municipal affairs at Ligures Baebiani 28 5. La vita municipale presso i Liguri Bebiani 69 6. Imperial generosity and rural poverty at Ligures Baebiani 32 6. Generosità imperiale e povertà rurale presso i Liguri Bebiani 73 7. The territory of the Ligures Baebiani 35 7. Il territorio dei Liguri Bebiani 75 8. Conclusions 40 8. Conclusione 81 Appendix: texts of inscriptions/Appendice: testi di iscrizioni 82 Abbreviations/Abbreviazioni 92 3 Foreword The publication of the first edition of Samnites, Ligurians and Romans, twenty-five years ago, has undoubtedly had a positive impact on the study of the valley of the Tammaro. The archaeological investigations initiated at Macchia di Circello in 1982 by Werner Johannowsky, an effective and generous Soprintendente, were extended into the territory from 1983 onwards by John Patterson, who was at that time studying at the British School at Rome. -
![An Atlas of Antient [I.E. Ancient] Geography](https://docslib.b-cdn.net/cover/8605/an-atlas-of-antient-i-e-ancient-geography-1938605.webp)
An Atlas of Antient [I.E. Ancient] Geography
'V»V\ 'X/'N^X^fX -V JV^V-V JV or A?/rfn!JyJ &EO&!AElcr K T \ ^JSlS LIBRARY OF WELLES LEY COLLEGE PRESENTED BY Ruth Campbell '27 V Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Boston Library Consortium Member Libraries http://www.archive.org/details/atlasofantientieOObutl AN ATLAS OP ANTIENT GEOGRAPHY BY SAMUEL BUTLER, D.D. AUTHOR OF MODERN AND ANTJENT GEOGRAPHY FOR THE USE OF SCHOOLS. STEREOTYPED BY J. HOWE. PHILADELPHIA: BLANQHARD AND LEA. 1851. G- PREFATORY NOTE INDEX OF DR. BUTLER'S ANTIENT ATLAS. It is to be observed in this Index, which is made for the sake of complete and easy refer- ence to the Maps, that the Latitude and Longitude of Rivers, and names of Countries, are given from the points where their names happen to be written in the Map, and not from any- remarkable point, such as their source or embouchure. The same River, Mountain, or City &c, occurs in different Maps, but is only mentioned once in the Index, except very large Rivers, the names of which are sometimes repeated in the Maps of the different countries to which they belong. The quantity of the places mentioned has been ascertained, as far as was in the Author's power, with great labor, by reference to the actual authorities, either Greek prose writers, (who often, by the help of a long vowel, a diphthong, or even an accent, afford a clue to this,) or to the Greek and Latin poets, without at all trusting to the attempts at marking the quantity in more recent works, experience having shown that they are extremely erroneous. -

Tauole Della Geografia Antica, Moderna, Ecclesiastica E
. , 7^ / Jf''/ [y T A V OLE D E L L A , CIVILE MODERNA . ECCLESIASTICA E antica , OVERO divisione Stati Prouincie, Nelle fup principali Parti , Regioni, Regni, ^ Città , 6c altri luoghi rigu^rdeuoli Ohristian^ssimo » Opera cominciata da*' Signon SAMsoN Geografi del Re i * auole per t^na» altra ^^fporpAta in Italiano:, accrefciuta 4 gran numero di o volgare de* nomi antichi latini ^ l' enumeratione Geografia , con la fpiegatione in e del fidondo 3 i Gradi di latitudine , de* principali Fiumi 3 Laghi3 fidenti il Catalogo de ILefeouadi e longitudine delle Città principali ì di ciafichedteno Stato 3 Antichi 3 e J\dpderni 3 e IDominip nete del fidondo * e delle Religioni 3 Lingue 3 e fido DA FRAHCESCO DjSHNjt . I GLQ C QM LIC FNZ A VE SFPBR IO RI LE Agl’ Illuflrils."', & Ecceilentifs.'"' Signori * I SIGNORI D* INNOCENZO. D* CAMILLO. E D‘ GIROLAMO P A M P H I L I I* AUENDO l’Eccellcnzc U oftre potuto ritrarre dalla feria applicazione» con cui ogni giorno fi auanzanoneiracquifto delle feienze, quanto fia neceffario ad vn Principe anche quello del- la Geografia , non meno in riguardo delle no- tizie, le quali per fe ftelTa ci communica , che per lo lume , con ' cui ci fà Icona alla perfetta cognitione dell’ Hiftoria, non è da merauigliarfi , che fi fiano poi fEcccllenze Uoftre inuaghitc di 1 aggiongere qucfto à glialrri virtuofi eflcrcizij , con cui animo loronobilifsimocosìgloriofamentecoltiuano; onde bramofo lo di cooperare in qualche parte alla confeguzione del loro in- tento, ardifeo con tutta rhumiltàd offerire, e dedicare all Ec- cellenze -
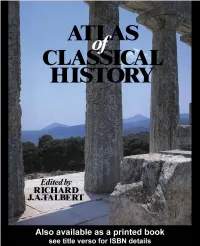
ATLAS of CLASSICAL HISTORY
ATLAS of CLASSICAL HISTORY EDITED BY RICHARD J.A.TALBERT London and New York First published 1985 by Croom Helm Ltd Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2003. © 1985 Richard J.A.Talbert and contributors All rights reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publishers. British Library Cataloguing in Publication Data Atlas of classical history. 1. History, Ancient—Maps I. Talbert, Richard J.A. 911.3 G3201.S2 ISBN 0-203-40535-8 Master e-book ISBN ISBN 0-203-71359-1 (Adobe eReader Format) ISBN 0-415-03463-9 (pbk) Library of Congress Cataloguing in Publication Data Also available CONTENTS Preface v Northern Greece, Macedonia and Thrace 32 Contributors vi The Eastern Aegean and the Asia Minor Equivalent Measurements vi Hinterland 33 Attica 34–5, 181 Maps: map and text page reference placed first, Classical Athens 35–6, 181 further reading reference second Roman Athens 35–6, 181 Halicarnassus 36, 181 The Mediterranean World: Physical 1 Miletus 37, 181 The Aegean in the Bronze Age 2–5, 179 Priene 37, 181 Troy 3, 179 Greek Sicily 38–9, 181 Knossos 3, 179 Syracuse 39, 181 Minoan Crete 4–5, 179 Akragas 40, 181 Mycenae 5, 179 Cyrene 40, 182 Mycenaean Greece 4–6, 179 Olympia 41, 182 Mainland Greece in the Homeric Poems 7–8, Greek Dialects c. -

Titi Livii Patavini Historiarum Libri Qui Supersunt Omnes
^ TITI LIVII PATAVINI HISTORIARUM LIBRI QUI SUPERSUNT OMNES tOMUS V N D ECIMUS ^i^kA.^x^rv^^ MANNHEMII Cura & Siimptibus Societatis literatas M DCC LXXXI Digitized by the Internet Archive ' in 2011 with funding from LYRASIS members and Sloan Foundation http://www.archive.org/details/titiliviipatavin11livy TITI LIVII PATAVINI HISTORIARUM AB URBE CONDITA LIBER XLI E P I T O M E J.GN IS in (zd^ F&Jl(Z cxjlinctus ejl, TL Scmpwnins Gracchus proconful Cdtibc^ Tos vicios in dcditioncm acctvlt , monu^ memumquc opcrum fuorum ^ Gracchiirim oppidum in ITifpania conjlituit^ Et a Pojiumio Alhino proconfuh Vacccci aC Lujitani fubacli funt, Utcrquc triumpha^ vit. Antiochus , Antiochi filius , ohfcs Romanis a patrc datus , mortuo fratr^ Schuco qui patri dcfitnclo 5 fuccejfcrat ^ in rcgnum Syrice ab urbc dimiffus» Luf trum a ccnforibus conditum cji, Ccnfa funi civium capita duccnta fcxaginta tria millia duccnta nona^inta quatuor, Qj, Voconius Saxa trihunus ptcbis hgcm tu- lit 5 nc quis hxrcdcm mulicrcm in(iitucr€t» A 2 4 E P I T O M E Suajit legem M. Cdto, Exflat oratio ejus, Pmterea res contra Ligures , IJlros^ Sardos 5 & Celtiheros , d complurihus ducibus projpere gejias , & initia helli continet Perjeus Phi^ Macedonici , quod , lippi Jilius j moliehatur. Mijerat enim ad Carthaginienjes legationem ^& ah iis noBc audita erat : Jed & alias Grcecice civita^ tes Jollicitahat. Qui prceter religionem^ quod quam multa templa magnijica muU tis locis erexit , Atlienis Jovis Olympii^ &Antiochi(& Capjtollni^ yilijjmum regem egit. , J A M per omnes Orbis terrarum partes supfL, I, vidtricia populus Romanus circumtulerat arma, diflitasque procul & fejunftas non uno mari regiones longe lateque pervaferat. -

Les Celtes Sous Le Regard Des Grecs Et Des Latins
LA VOCATION DE L’ARBRE D’OR est de partager ses admirations avec les lecteurs, son admiration pour les grands textes nourrissants du passé et celle aussi pour l’œuvre de contem- porains majeurs qui seront probablement davantage appréciés demain qu’aujourd’hui. Trop d’ouvrages essentiels à la culture de l’âme ou de l’identité de cha- cun sont aujourd’hui indisponibles dans un marché du livre transformé en industrie lourde. Et quand par chance ils sont disponibles, c’est finan- cièrement que trop souvent ils deviennent inaccessibles. La belle littérature, les outils de développement personnel, d’identité et de progrès, on les trouvera donc au catalogue de l’Arbre d’Or à des prix résolument bas pour la qualité offerte. LES DROITS DES AUTEURS Cet e-book est sous la protection de la loi fédérale suisse sur le droit d’auteur et les droits voisins (art. 2, al. 2 tit. a, LDA). Il est également pro- tégé par les traités internationaux sur la propriété industrielle. Comme un livre papier, le présent fichier et son image de couverture sont sous copyright, vous ne devez en aucune façon les modifier, les utiliser ou les diffuser sans l’accord des ayant-droits. Obtenir ce fichier autrement que suite à un téléchargement après paiement sur le site est un délit. Trans- mettre ce fichier encodé sur un autre ordinateur que celui avec lequel il a été payé et téléchargé peut occasionner des dommages informatiques suscepti- bles d’engager votre responsabilité civile. Ne diffusez pas votre copie mais, au contraire, quand un titre vous a plu, encouragez-en l’achat. -

3. La Situazione Del Territorio Ligure Fino Alla Conquista Romana
Luigi Gambaro 37 3. LA SITUAZIONE DEL TERRITORIO LIGURE FINO ALLA CONQUISTA ROMANA 3.1. INQUADRAMENTO STORICO ra contro Cartagine, questo intervento militare, ci sarebbe stata la minaccia che il presumibile pros- 1. Il territorio alto-tirrenico prima della simo intervento cartaginese nell’isola, volto a conquista - la situazione tra le due guerre sedare la ribellione dei mercenari, avrebbe potuto puniche (240-220 a.C.) portare anche a Roma89. Altre fonti attribuiscono ai Cartaginesi la responsabilità di aver fomentato Il primo intervento militare romano contro i insurrezioni contro Roma ad opera di Sardi, Corsi Liguri si inserisce nel più vasto scenario dell’azio- e Liguri90. Oltre che in funzione apertamente anti- ne di Roma nel mar Tirreno, subito dopo la fine cartaginese un’altra motivazione dell’intervento della prima guerra punica, e si collega con le vicen- di Roma nel mar Tirreno e in quello Ligure sareb- de che riguardano la Sardegna e la Corsica8 5. Le be stata la pirateria praticata da Sardi, Corsi e fonti attribuiscono al console del 238 a.C., Ti. Sem- Liguri, forse col beneplacito di Cartagine, a danno pronio Gracco, una prima spedizione vittoriosa di commercianti romani ed italici e dell’alleata contro popolazioni liguri86, proprio mentre i Carta- Marsiglia91. ginesi venivano obbligati, sulla base di clausole Anche se è stato ipotizzato che la decisione di aggiuntive al trattato di Catulo del 241 a.C., a agire contro la pirateria non soddisfacesse generi- sgomberare la Sardegna e la Corsica, dove suben- ci interessi commerciali ma potesse essere ispirata trarono le truppe romane87. da una precisa strategia del Senato, al cui interno Una parte della storiografia moderna ha giu- almeno dal 236 a.C. -

LA CAMPAGNA CONTRO I FRINIATES 179 A.C
LA CAMPAGNA CONTRO I FRINIATES 179 a.C. - 175 a.C. di Lanfranco Sanna Tutta la costa ligure da Pisa a Monaco è sotto il controllo di Roma, rimangono autonome le popolazioni del Piemonte meridionale ad ovest di Tortona (Bagienni, Statielli) e molte altre a nord dell'Appennino tosco-emiliano che si incuneano tra l'Etruria e l'Emilia: sono, queste ultime, riunite nella forte confederazione dei Friniates. Contro questi ultimi marcia nel 179 a.C. il console Quinto Fulvio Flacco, dopo aver attraversato «montagne senza sentieri e i gioghi del Ballista», forse il monte Valestra, riesce a impegnare il nemico in campo aperto, dove ancora una volta i legionari si dimostrano imbattibili: sono catturati 3.200 Liguri che sono subito trasferiti in pianura. Solo due anni dopo però ( 177 ) la rivolta riprende vigore proprio quando volge al termine la guerra contro gli Istri. Il Senato informa il console Caio Claudio Pulcro della situazione e gli lascia la facoltà di portarsi nel territorio dei Liguri. Il console porta le sue legioni contro i Friniates che si sono accampati nella spianata del fiume Scultenna (l’attuale torrente Scoltenna che, nato tra il monte Giovo e il passo dell’Abetone, va a formare il Panaro); affrontati in battaglia, i Liguri perdono 15.000 uomini tra morti e feriti, 700 prigionieri e 51 insegne, mentre i superstiti si rifugiano sui monti. In quello stesso anno è dedotta a Luna una colonia di 2.000 cittadini romani (Triumviri Publio Elio, Marco Emilio Lepido, Gneo Sicinio ). Ad ogni colono sono assegnati 51 iugeri e mezzo di terreno: una così cospicua assegnazione aveva un solo precedente e recentissimo, quello di Aquileia, a significare l'urgenza dei Romani di presidiare la zona. -

Civilisation Et Role Des Ligures De L'arno Au Var De L’Age Du Fer a La Conquete Romaine
CIVILISATION ET ROLE DES LIGURES DE L'ARNO AU VAR DE L’AGE DU FER A LA CONQUETE ROMAINE par Gérard CAUVIN docteur ès-lettres Résumé de thèse Les Ligures ont été et restent un des peuples les moins connus de notre Antiquité même si l'archéologie commence à livrer des renseignements importants. Quels peuvent donc être les rapports entre les images progressivement restituées par la recherche scientifique et les images reçues, héritées, transmises par les auteurs classiques ? Montagnes des Alpes et des Apennins, plateaux et vallées de l'arrière-pays, éperons effilés, plages et criques constituent le prélude nécessaire à la compréhension du peuplement mais aussi des caractéristiques, des ressources des différentes tribus ligures. LE CADRE NATUREL Dans une région compartimentée à l'infini par d'innombrables reliefs, la maîtrise de l'espace par l'homme jouera un rôle vital. Deux fleuves limitent notre zone d'étude : le Var à l'ouest et l'Arno à l'est. Polybe précise même : "Le territoire des Ligures s'étend du côté de la mer, jusqu'à Pise, la première ville étrusque à l'ouest, et vers l'intérieur jusqu'à Arretium" (1). Si les Apennins sont souvent, comparés aux Alpes, ce sont surtout celles-ci enveloppées de "l'horreur des neiges éternelles" (2) qui impressionnaient les anciens. Aussi les cols et les pistes muletières issues des sentiers tracés par les bergers et leurs troupeaux, reprises en fonction de leur utilité, permettaient de parcourir le haut-pays et de mettre en communication monts et vaux, de donner accès à des vallons isolés ou vers la mer, de franchir les reliefs et de faciliter la liaison entre la côte et les régions de l'intérieur (3).