Licata La Terra Del Re Sicano Cocalo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Notizie Storiche Sulla Torre Di Marmora Del Salice
NOTIZIE STORICHE SULLA TORRE DI MARMORA DEL SALICE Tramandate dall’Architetto Militare Camillo Camiliani e da altre fonti. Torre di Marmora Fonti storiche Torre Marmora del Salice Manoscritto di Tiburzio Spannocchi, ritrovato dallo storico francese Maurice Aymard presso la Biblioteca Nacional de Madrid. La Sicilia di Tiburzio Spannocchi – Una Cartografia per la conoscenza e il dominio del Territorio nel secolo XVI di Corradina Polto – Istituto Geografico Militare - Firenze. Descrizione in tre libri delle coste della Sicilia di Camillo Camiliani – Ingegnero del regno di Sicilia, ritrovato da Alessandro Vitale Brovarone, presso la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino – Sezione Manoscritti. L’Opera di Camillo Camiliani di Marina Scarlata - Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato - Libreria dello Stato. Torri di Guardia dei Litorali di Sicilia del Marchese di Villabianca a cura di Salvo Di Matteo. Le torri nei paesaggi costieri siciliani – a cura di Ferdinando Maurici, Adriana Fresina, Fabio Militello- Regione Siciliana – Palermo 2008. Notizie introduttive Le torri costiere della Sicilia costituivano il sistema difensivo, di avvistamento e di comunicazione lungo la fascia costiera del Regno di Sicilia. In Sicilia le prime torri costiere si fanno risalire nel periodo compreso tra il 1313 ed il 1345 come baluardo della monarchia aragonese contro le incursioni della flotta angioina che da Napoli muoveva all'assalto delle coste siciliane. A partire dal 1360 invece la minaccia provenne da sud, dal nord Africa maghrebino ad opera soprattutto di pirati e corsari tunisini. La minaccia maghrebina si intensificò con il sorgere della potenza navale turca, e a partire dal 1520, il corsaro Khayr al-Din Barbarossa operò per conto dell'Impero ottomano, divenendo nel 1533 Qapudan Pashà, cioè comandante supremo della flotta turca. -

Percorsi Etruschi "In Verità È Impressionante Constatare Che Per Due Volte, Nel VII Secolo A
2 Prefazione "L’uomo che non è mai stato in Italia, è sempre cosciente di un’inferiorità." Samuel Johnson Perché possiamo parlare dell’Italia come Opera Unica? Certo è che in essa sono concentrati la maggior parte dei beni artistici esistenti sul pianeta Terra, questo senza tener conto delle enormi ricchezze che ci rappresentano in alcuni tra i musei più importanti del mondo come il Louvre a Parigi, l’Heritage a San Pietroburgo o la National Gallery a Londra, visto e considerato che, insieme all’Egitto e alla Grecia, siamo tra i paesi più depauperati da un punto di vista patrimoniale, oltre che, da sempre, l’Arte Italiana fa scuola a studenti e artisti provenienti da ogni dove, talvolta diventati celeberrimi come Balthus, Picas- so e Turner, e che hanno affrontato i viaggi più avventurosi per studiare i no- stri capolavori i quali hanno influenzato visibilmente le loro opere. La famosa "Sindrome di Stendhal" prende nome proprio dalla reazione emo- tiva ansiogena che colse il famoso scrittore Francese e che egli racconta nel suo libro "Roma, Napoli e Firenze" descrivendola come una sintomatologia paralizzante dovuta all’improvvisa bellezza di un monumento e che lo colse uscendo dalla chiesa di Santa Croce, nel capoluogo toscano. Nel solo territorio Italiano contiamo cinquantacinque siti UNESCO a cui va aggiunto il Vaticano e senza tener conto che luoghi come Ercolano e Pompei sono considerati un unico sito. Trattasi di un numero pari a quello che può vantare la Cina, ma l’estensione dell’Italia, come si sa, è ben più ridotta. In sostanza, ovunque ci si trovi, nel nostro bel paese, si rischia di essere colpiti dalla stessa Sindrome che colse Stendhal. -

Original Characteristics of Sicilian Geography
Review of Historical Geography and Toponomastics, vol. VI, no. 11-12, 2011, pp. 7-14 ORIGINAL CHARACTERISTICS OF SICILIAN GEOGRAPHY Nunzio FAMOSO * Full professor of Geography, University of Catania, Faculty of Languages, Department of Humanistic Sciences, Piazza Dante, No. 32, 95124, Italy e-mail: [email protected] Abstract: Original characteristics of Sicilian geography. The study of Original characteristics of Sicilian geography represents an innovative approach in the overlook of the biggest island of the Mediterranean Sea. This paper tries to illustrate Sicily as a plurality of different entities, which are to be sought in reasons that are economic, social and historical. The paper is focused on men and territory throughout history and on the modernization recently experimented, which has witnessed an incessant development of activities, an extensive expansion of services and infrastructures. The final part of the paper is focused on the idea of a plurality of “Sicilies”, which is the only way to form an efficient idea of a reality that has profoundly altered its territorial framework to donate, far from stereotypes and memories, the identity of an island differentiated and inconsistent. Rezumat: Caracteristici originale ale Geografiei Siciliei. Studiul de faţă reprezintă o abordare nouă asupra celei mai mari insule din Marea Mediterană. Lucrarea încearcă să ilustreze Sicilia sub raport geografic ca o pluralitate a unor entităţi diferite care trebuie privite sub raport economic, social şi istoric. Lucrarea este centrată pe raportul dintre om şi teritoriu prin filtrul istoric şi cel al modernizării care a generat o dezvoltare puternică, mai ales prin filtrul dezvoltării infrastructurii teritoriale şi a serviciilor. -

Avvisi Di Chiusure Temporanee Degli Uffici Della Regione Siciliana
AVVISI DI CHIUSURE TEMPORANEE DEGLI UFFICI DELLA REGIONE SICILIANA UFFICIO/I SEDE/I GIORNO/I CAUSA Note Centro per l’impiego di Lercara Friddi Via Carlo Alberto dalla Chiesa n.7 – 22.07.2021 Disinfestazione locali (PA) Lercara Friddi (PA) Dipartimento Sviluppo Rurale (sede e Viale Regione Siciliana 4600 e Via N. 16.07.2021 Disinfestazione locali U.O Demanio Trazzerale) Garzilli, 36/38 - Palermo Centro per l’impiego di Santa Teresa Via Lungomare, 127 - Santa Teresa di 16.07.2021 Festività S. Patrono di Riva (ME) Riva (ME) Ufficio intercomunale agricoltura – C/da Rio Favara, snc – Ispica (RG) 16.07.2021 Festività S. Patrono Comprensorio di Ispica (RG) Assessorato regionale Turismo, Sport Uffici di via Notarbartolo, 9 - 16.07.2021 Disinfestazione,derattizzazione e Spettacolo Palermo e disinfezione locali Motorizzazione civile di Agrigento Viale Giovanni XXIII - Agrigento 09.07.2021 Sanificazione locali Soprintendenza Beni Culturali di Via L. Sturzo, 62 Catania 09.07.2021 Derattizzazione, Catania deblattizzazione e disinfestazione locali Ass. reg. infrastrutture e mobilità – Via Beato Bernardo, 5 - Catania 08.07.2021 dalle Sanificazione locali Dip. Reg. Tecnico - Servizio 6 ore 12:00 UIA del Comprensorio di Capo Via 2 Giugno, 12 – Patti (ME) 05.07.2021 Festività S. Patrono d’Orlando (ME) - Sede di Patti (ME) Motorizzazione civile di Agrigento Viale Giovanni XXIII - Agrigento Dal 05.07.2021 al Esigenze di servizio Ricevimento al pubblico 27.08.2021 nei giorni di martedì dalle sospesa normale 09:00 alle 12:00 e giovedì apertura al dalle 09:00 alle 12:00 e pubblico dalle 16:00 alle 17:30. -

School Carabiniere N
Legge Reg.le N. 20/2016 art. 7 Elenco Scuole Sicilia PROV COMUNE CAP DENOMINAZIONE INDIRIZZO AG AGRIGENTO 92100 Angioletti Birichini Via Dante n. 107 AG AGRIGENTO 92100 Associazione La Coccinella Viale Sicilia n. 19 AG AGRIGENTO 92100 Club dei Piccoli Via Tirreno, 4 AG AGRIGENTO 92100 Colleverde P.tta Pitagora 5 Sacro Cuore Ancelle AG AGRIGENTO 92100 Largo Mons.A.Celona, 6 Riparatrici scuola dell'infanzia Villaggio Mosè Via AG AGRIGENTO 92100 comunale "Il Cucciolo" Capuana n. 8 scuola dell'infanzia Quadrivio S. Santa - Via AG AGRIGENTO 92100 comunale "IL giardino Regione Siciliana n. 91 fiorito" AG AGRIGENTO 92100 Solletico Club Via L. Sciascia, 31 Via Fosse Ardeatine c/da S. AG AGRIGENTO 92100 La Primula Calogero AG AGRIGENTO 92100 Peter Pan Via Mazzini 159 AG AGRIGENTO 92100 Colleverde 2 Via Leonardo Sciascia, 19F AG AGRIGENTO 92100 Montessori Pinocchio Via Mazzini 109 AG AGRIGENTO 92100 SS.Angeli Custodi Via Teti n. 2-4 ALESSANDRIA DELLA AG 92010 Pio XII Via Margherita, 49 ROCCA AG BURGIO 92010 Venerabile Andrea Viale dell Vittoria, 1 CAMPOBELLO DI AG 92023 Anna Bella Via Garibaldi, 396 LICATA AG CANICATTI' 92024 Baby boom Via Gugino n. 1 AG CANICATTI' 92024 L'Orsetto Via Giudice Saetta n. 10 AG CANICATTI' 92024 Pepperland Via Ducezio n. 1 Mamma Margherita Baby Via Antonio Di Gioia AG 92024 CANICATTI' School Carabiniere n. 2 AG CANICATTI' 92024 S.Teresa Del Bambin Gesù C.so UmbertoI, 55 AG CANICATTI' 92024 happy Park Via Carlo Alberto, 280 AG CANICATTI' 92024 Maria Immacolata Via D.Cirillo 69 AG CASTELTERMINI 92025 Paperino’s School C/da Curma, 1/A AG FAVARA 92026 Baby School Via Olanda, 54/B AG FAVARA 92026 Gesuela Giudice P.zza Mazzini, 7 AG FAVARA 92026 Tinchitè Via Spagna n. -

Pof 14-15 I.C. Saponara.Pdf
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAPONARA Piano Offerta Formativa Anno scolastico 2014/2015 S P A D A F O R A R O M E T T A S A P O N A R A INDICE LA SCUOLA NEL NUOVO SCENARIO PAG 2 FINALITA' FORMATIVE DEL PROCESSO FORMATIVO PAG 3 LETTURA DEL TERRITORIO PAG 4 STRUTTURA DELL'ISTITUTO E EDILIZIA SCOLASTICA PAG 7 IDENTITA' DELLA SCUOLA PAG 11 TEMPO SCUOLA PAG 13 CALENDARIO SCOLASTICO PAG 14 ORGANIGRAMMA PAG 15 RESPONSABILI DI PLESSO PAG 16 FUNZIONI STRUMENTALI PAG 17 GLI OPERATORI DELLA SCUOLA PAG 18 ORGANI COLLEGIALI PAG 20 CRITERI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'FORMATIVA PAG 23 PROFESSIONALITA' DOCENTE PAG 24 CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME PAG 25 CRITERI ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI PAG 25 DIPARTIMENTI DISCIPLINARI PAG 26 L'INDIRIZZO MUSICALE PAG 27 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA PAG 29 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PAG 31 PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI PAG 32 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE PAG 37 LA VALUTAZIONE PAG 39 CONCLUSIONI PAG 41 1 Negli ultimi anni il mondo in generale ha subito un passaggio repentino da una società stabile ad una condizione di precarietà dettata da continui mutamenti e discontinuità; ciò fa si che ogni società e, nel proprio interno, ogni comunità e ogni persona ad essa appartenente sia in continua evoluzione ed esposta a rischi e opportunità sempre maggiori. Tali eventi sociali e culturali determinano l’ormai improrogabile necessità di rinnovare radicalmente l’impianto formativo della scuola e delle varie istituzioni scolastiche. Tuttavia, fra tante innovazioni, il compito della scuola rimane quello di formare ogni alunno sul piano personale e sociale secondo le proprie esigenze, considerando che l’ambiente scolastico oggi non è l’unico contesto dove i bambini e gli adolescenti acquisiscono competenze specifiche. -
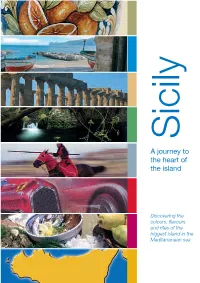
A Journey to the Heart of the Island
Sicily A journey to the heart of the island Discovering the colours, flavours and rites of the biggest island in the Mediterranean sea Regione Siciliana POR Sicilia UNIONE EUROPEA Assessorato Turismo, 2000-2006 Fondo Europeo Trasporti e Comunicazioni Misura 4.18 a/b Sviluppo Regionale www.regione.sicilia.it/turismo A journeySicily to the heart of the island Discovering the colours, flavours and rites of the biggest island in the Mediterranean sea index Knowing Sicily A paradise made of sea and sun island Treasure oasi Green pag 04 pag 12 pag 22 pag 54 Language ......................... 6 Among shores, The early settlements ..... 24 Regional parks ............... 56 cliffs and beaches .......... 14 Documents and Exchange . 6 The Greek domination .... 26 Reserves and The fishing villages, the protected areas .............. 58 The weather and what The Roman civilization ... 32 fishing tourism and wearing ............................ 6 The Arab-Norman period .. 34 Outdoor sports................ 60 the sea cooking .............. 16 Festivities ......................... 7 Frederick II and the Country tourism Minor Islands and marine Swabians ....................... 38 and baths ...................... 62 Trasportation .................... 7 protected areas: a paradise Medieval Sicily ............... 42 Roads ............................... 8 for diving and snorkelling .. 18 The explosion of Emergency numbers ........ 8 Marina Charters, tourist 02 harbours and the Baroque..................... 45 Geography ........................ 8 aquatic sports ................. 20 Bourbon’s age ................ 48 History ............................ 10 The Florio’s splendour .... 50 The museums ................ 52 The memory of the Island An island opened all the year Master in hosting Maps of the provinces pag 64 pag 76 pag 86 pag 100 The non-material Religious celebrations .... 78 The routes of wine ......... 88 Palermo ........................ 102 heritage register ............. 66 Theatre and Gastronomy ................... -
Picturesque and Noisy, Catania Is the City Of
The infinite island gorges formed by erosion by water. Lastly, the Lastly, bywater. formedbyerosion gorges deeply carvedoutby rock, above allcalcareous sion oftablelands formedbylava,tufaand isasucces- the easternpartofisland,there mountains ofCalabria.Furthersouth, againin the Peloritanscontinue,wholly similar tothe lowhills. dominating roundish formations,isolatedoringroups, calcareous theMadoniegivewaytoirregular river Torto, Justwestof the peaks goupto2000metres. andtheMadoniemountains, whose Nebrodi ofthePeloritans, isastretch west, there biggest oneinEurope. volcano, 3300m.high,isactive,andthe The park),intheeasternpartofSicily. nature byabig ofwhichisprotected (the wholearea Catania. withonlyonebigplainnear and hilly, Sicilian landscape:theislandismountainous movementinthe isgreat 1000 km.long.There tothenorth,andsandysouth,is rocky Itscoast,prevalently metres). er 25,708square the southPelagieandPantelleria(altogeth- Islands andUstica,tothewestEgadi, smaller islands:tothenorthAeolian isa seriesof itthere Around metres). square Sicily isthebiggestislandinlatter(25,460 To theeast,between Messina andEtna, To eastto Along thenortherncoast,from The mostimportantmassifistheEtnaone oftheMediterranean, Placed atthecentre Geography andgeology terrible. magnificentand darkandsunny, an island",mythologicalandconcrete, identities" (Bufalino). and,toboot,apluralnation, withsomanydifferent rather thanaregion ious tobeintegratedinthemodernworldandtimes,"anation at oncepoorandrich,closeddiffidentinitsnobledecadenceyetsoanx- yetstilltodayitisworthknowingit,thisSicilywithathousandfaces, -

Sicily (Sicilia)
Sicily (Sicilia) General Sicily (Italian: Sicilia) is an autonomous region of Italy, in Southern Italy along with surrounding minor islands, officially referred to as Regione Siciliana. Sicily is located in the central Mediterranean Sea, south of the Italian Peninsula, from which it is separated by the narrow Strait of Messina. Its most prominent landmark is Mount Etna, the tallest active volcano in Europe, and one of the most active in the world, currently 3,329 m (10,922 ft.) high. The island has a typical Mediterranean climate. Administrative Divisions Administratively, Sicily is divided into 9 administrative provinces, each with a capital city of the same name as the province. The areas and populations of these provinces are: Province of Agrigento ......................................... 3,042 km2 ....... pop. 453,594 Province of Caltanissetta .................................... 2,128 km2 ....... pop. 271,168 Province of Catania ............................................ 3,552 km2 .... pop. 1,090,620 Province of Enna ................................................ 2,562 km2 ....... pop. 172,159 Province of Messina ........................................... 3,247 km2 ....... pop. 652,742 Province of Palermo ........................................... 4,992 km2 .... pop. 1,249,744 Province of Ragusa ............................................ 1,614 km2 ....... pop. 318,980 Province of Siracusa ........................................... 2,109 km2 ....... pop. 403,559 Province of Trapani ............................................. 2,460 km2 ....... pop. 436,240 The City of Palermo is the Capital City of the region Small surrounding islands are also part of various Sicilian provinces: Aeolian Islands (Messina), The isle of Ustica (Palermo), Aegadian Islands (Trapani), The isle of Pantelleria (Trapani) and Pelagian Islands (Agrigento). Geography Sicily is the largest island in the Mediterranean Sea. It has a roughly triangular shape, earning it the name Trinacria. -

Les Tours Dans Les Paysages Côtiers Siciliens (Xiiième - Xixème Siècles)
Les tours dans les paysages côtiers siciliens (XIIIème - XIXème siècles) REGIONE SICILIANA Assessorato beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione Dipartimento dei beni culturali ed ambientali, dell’educazione permanente e dell’architettura e dell’arte contemporanea Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, fotogrammetrica e audiovisiva dei beni culturali ed ambientali UNION EUROPÉENNE P.O.R. SICILIA 2000 - 2006 Asse II - Misura 2.02 - Azione D Progetto: “Le torri nei paesaggi costieri siciliani” Avec la collaboration du COMANDO REGIONE CARABINIERI SICILIA Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, fotogrammetrica e audiovisiva dei beni culturali ed ambientali Les Tours dans les paysages côtiers siciliens (XIIIème - XIXème siècles) REGIONE SICILIANA Assessorato beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione Dipartimento dei beni culturali ed ambientali, dell’educazione permanente e dell’architettura e dell’arte contemporanea Palermo 2009 REGIONE SICILIANA Assessorato dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione Dipartimento dei beni culturali ed ambientali, dell’educazione permanente e dell’architettura e dell’arte contemporanea CRICD Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, fotogrammetrica e audiovisiva dei beni culturali ed ambientali Directeur : Sergio Gelardi P.O.R. SICILIA 2000 - 2006 Asse II - Misura 2.02 - Azione D Programma a titolarità regionale Progetto: “Le torri nei paesaggi costieri siciliani” codice locale: 1999. IT.16.1.PO. 011/2.02/9.3.13/0051 Traduction de Elisabeth Lesnes et Stéphanie Gallà Photos et réalisation graphique de Fabio Militello © 2009 - Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione, Dipartimento dei beni culturali, ambientali, dell’educazione permanente e dell’architettura e dell’arte contemporanea. -

Military Landscapes
MILITARY LANDSCAPES MILITARY LANDSCAPES ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE Scenari per il futuro del patrimonio militare PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE A future for militare heritage a cura di | edited by Donatella Rita Fiorino Quest’opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia. Per leggere una copia della licenza visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/ by-nc-nd/3.0/it/ o spedisci una lettera a Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. CC 2017 MiBACT - Polo Museale della Sardegna CC 2017 DICAAR - Università degli Studi di Cagliari CC 2017 Skira editore, Milano Prima edizione digitale, dicembre 2017 First digital edition, December 2017 ISBN: 978-88-572-3732-9 www.skira.net MILITARY LANDSCAPES SCENARI PER IL FUTURO DEL PATRIMONIO MILITARE Un confronto internazionale in occasione del 150° anniversario della dismissione delle piazzeforti militari in Italia A FUTURE FOR MILITARY HERITAGE An international overview event celebrating the 150th anniversary of the decommissioning of Italian fortresses a cura di | edited by Giovanna Damiani Donatella Rita Fiorino CONVEGNO INTERNAZIONALE | INTERNATIONAL CONFERENCE Organizzata da | Organized by: Coordinamento -

GIORGIO VASARI a PALAZZO ABATELLIS a PALAZZO ABATELLIS Zione Letteraria, L’Architettura
a cura di frammenti di storia e architettura 11 Stefano Piazza a cura di Stefano Piazza La mostra si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per i 500 anni dalla nascita di Giorgio Vasari (1511-2011), ricorrenza che, nel corso dell’anno, è stata oggetto di numerosi eventi culturali italiani e internazionali. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Biblioteca centrale della Regione siciliana “A. Bombace”, la sezione “Sfera” del Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo, e la Galleria Interdisciplinare Regionale della Sicilia, istituzione che custodisce, nella prestigiosa sede di Palazzo Abatellis, due grandi dipinti su tavola di Vasari, costituenti le ricurve parti laterali del trittico della “Caduta della manna”, realizzato nel 1545 per il refettorio di Santa Maria di Monteoliveto a Napoli. Le lunette vasariane, esposte in modo permanente dal 2009 ma ancora quasi del tutto scono- sciute a studiosi e pubblico, per l’occasione sono state ricollocate secondo gli originari rap- porti dimensionali con il perduto quadro centrale e poste in relazione con il disegno pre- paratorio dello stesso Vasari, oggi custodito presso l’École nationale supérieure des beaux- arts di Parigi. Il percorso analitico, che si è avvalso anche del prezioso contributo di Claudia GIORGIO VASARI Conforti, tra le più autorevoli studiose dell’artista aretino, e delle competenze tecniche dell’Associazione Culturale LapiS, è stato svolto secondo tre tematiche connesse alla polie- drica attività vasariana e al suo contesto culturale: la pittura e l’arte