Scarica Scarica
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Guillaume Tell Guillaume
1 TEATRO MASSIMO TEATRO GIOACHINO ROSSINI GIOACHINO | GUILLAUME TELL GUILLAUME Gioachino Rossini GUILLAUME TELL Membro di seguici su: STAGIONE teatromassimo.it Piazza Verdi - 90138 Palermo OPERE E BALLETTI ISBN: 978-88-98389-66-7 euro 10,00 STAGIONE OPERE E BALLETTI SOCI FONDATORI PARTNER PRIVATI REGIONE SICILIANA ASSESSORATO AL TURISMO SPORT E SPETTACOLI ALBO DEI DONATORI FONDAZIONE ART BONUS TEATRO MASSIMO TASCA D’ALMERITA Francesco Giambrone Sovrintendente Oscar Pizzo Direttore artistico ANGELO MORETTINO SRL Gabriele Ferro Direttore musicale SAIS AUTOLINEE CONSIGLIO DI INDIRIZZO Leoluca Orlando (sindaco di Palermo) AGOSTINO RANDAZZO Presidente Leonardo Di Franco Vicepresidente DELL’OGLIO Daniele Ficola Francesco Giambrone Sovrintendente FILIPPONE ASSICURAZIONE Enrico Maccarone GIUSEPPE DI PASQUALE Anna Sica ALESSANDRA GIURINTANO DI MARCO COLLEGIO DEI REVISORI Maurizio Graffeo Presidente ISTITUTO CLINICO LOCOROTONDO Marco Piepoli Gianpiero Tulelli TURNI GUILLAUME TELL Opéra en quatre actes (opera in quattro atti) Libretto di Victor Joseph Etienne De Jouy e Hippolyte Louis Florent Bis Musica di Gioachino Rossini Prima rappresentazione Parigi, Théâtre de l’Academie Royale de Musique, 3 agosto 1829 Edizione critica della partitura edita dalla Fondazione Rossini di Pesaro in collaborazione con Casa Ricordi di Milano Data Turno Ora a cura di M. Elizabeth C. Bartlet Sabato 20 gennaio Anteprima Giovani 17.30 Martedì 23 gennaio Prime 19.30 In occasione dei 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini Giovedì 25 gennaio B 18.30 Sabato 27 gennaio -

STRUTTURE Cosa Nostra E 'Ndrangheta a Confronto
STRUTTURE Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto Francesco Gaetano Moiraghi Andrea Zolea WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea La mafia dura da decenni: un motivo ci deve essere. Non si può andare contro i missili con arco e frecce: in queste vicende certe intemperanze si pagano duramente. Con il terrorismo, con il consenso sociale, potevi permettertele: con la mafia non è così. Nella società c’è un consenso distorto. Altro che bubbone in un tessuto sociale sano. Il tessuto non è affatto sano. Noi estirperemo Michele Greco, poi arriverà il secondo, poi il terzo, poi il quarto. Giovanni Falcone 1 www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea PREMESSA Questo lavoro ha lo scopo di offrire uno sguardo d’insieme sulle articolazioni strutturali delle organizzazioni mafiose denominate Cosa nostra e ‘ndrangheta . La prima sezione, curata da Francesco Gaetano Moiraghi, si concentra sull’analisi di Cosa nostra. La seconda sezione, che sposta il focus sulla ‘ndrangheta, è curata da Andrea Zolea. Come si potrà notare, le due sezioni non sono state realizzate secondo uno stesso modello, ma analizzano le due organizzazioni con un approccio differente. Ad esempio, la parte su Cosa nostra avrà un orientamento maggiormente diacronico, diversamente da quella sulla ‘ndrangheta, basata su un approccio sincronico. Il presente testo ha infatti l’obiettivo di offrire due proposte di analisi differenti che riescano a mettere in luce le analogie e le differenze delle strutture delle due organizzazioni mafiose. -

Nomi E Storie Delle Vittime Innocenti Delle Mafie
Nomi e storie delle vittime innocenti delle mafie a cura di Marcello Scaglione e dei ragazzi del Presidio “Francesca Morvillo” di Libera Genova Realizzato in occasione della mostra “900 Nomi vittime di mafia dal 1893 ad oggi” inaugurata ad Imperia il 21 Marzo 2016 in occasione della XXI Giornata della memoria e dell’impegno - ”Ponti di memoria, luoghi di impegno”. I nomi presenti nella mostra sono quelli accertati fino all'anno 2015, ed in particolare quelli letti a Bologna durante la XX Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo 2015). Il lavoro di ricerca, inizialmente limitato a quell'elenco, è stato poi implementato e aggiornato, comprendendo quindi le storie delle vittime innocenti i cui nomi sono stati letti durante la XXI Giornata della Memoria e dell'Impegno (21 marzo 2016). Sarà nostro impegno e cura eseguire successivamente gli aggiornamenti necessari. Siamo inoltre disponibili a intervenire sulle singole storie, laddove dovessero essere ravvisati errori e/o imprecisioni. EMANUELE NOTABARTOLO, 01/02/1893 Nato in una famiglia aristocratica palermitana, presto rimane orfano di entrambi i genitori. Cresciuto in Sicilia, nel 1857 si trasferisce prima a Parigi, poi in Inghilterra, dove conosce Michele Amari e Mariano Stabile, due esuli siciliani che lo influenzeranno molto. Avvicinatosi all'economia e alla storia, diventa sostenitore del liberalismo conservatore (quindi vicino alla Destra storica). Dal 1862 Emanuele Notarbartolo diventa prima reggente, poi titolare, del Banco di Sicilia, al quale si dedica a tempo pieno a partire dal 1876, salvandolo dal fallimento in seguito all'Unità d'Italia. Il suo lavoro al Banco di Sicilia inizia a inimicargli molta gente. -

“FINE PENA: ORA” DI ELVIO FASSONE Di Davide Galliani
Rivista di Studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata Cross Vol.2 N°1 (2016) ISSN 2421-5635 Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata INDICE Presentazione QUESTO NUMERO di N.d.C ....................................................................................................................................................................... 1 Recensione/dibattito 1 RIFLESSIONI SPARSE SUL DELITTO DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA. A PARTIRE DALLA TERZA EDIZIONE DEL LIBRO DI GIULIANO TURONE di Fabio Basile ......................................................................................................................................................... 3 Recensione/dibattito 2 UNA QUESTIONE DI LIMITI. A PROPOSITO DI “FINE PENA: ORA” DI ELVIO FASSONE di Davide Galliani ................................................................................................................................................ 13 Dibattito LA MOBILITASION ANTIMAFIA DE 1992 di Charlotte Moge ................................................................................................................................................ 32 La ricerca 1 TRA NARCOS E STATO. LE FORME DELLA RESISTENZA CIVILE IN MESSICO di Thomas Aureliani ........................................................................................................................................... 61 La ricerca 2 A PROPOSITO DI MAFIA CAPITALE. SPUNTI PER TIPIZZARE IL FENOMENO MAFIOSO NEI SISTEMI DI COMMON LAW di Anna Sergi ........................................................................................................................................................ -

Intervento Di Destra Sostenuto Dal Gruppo Senatoriale Della DC
Quotidiano / Anno XLVII / N. 200 (8ft;g,i5Bl ) Venarcfi 23 luglio 1971 / L 90 * ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO Si incrina U fronte padronale nelle campagne II presidente del «Comando della rivoluzione » catturato dai libici a Bengasi LONDRA — II colonnello En-Nur (a sinistra) ed il maggiore Hamadallah fotografati a Londra A Foggia prima vittoria prima della partenza dell'aereo che le autorita libiche hanho fa Mo atterrare a Bengasi dei braccianti in lotta SUDAN: NUOVO COLPO MILITARE Gli agrari costretti a firmare il contralto NUMEIRIRIPRENDE IL POTERE Appello del leader Sudanese alia « caccia al comunista » - Sanguinosi scontri Una grande manifestazione ha suggellato un mese di battaglia - Romeo: notevole contributo al piu vasto movimento per le riforme e il rinnovamento del Mezzogiorno - A Ban e nelle altre province nei punti nevralgici della capitale - II maggiore El Atta e i suoi compagni sono pugliesi il padronato continua a respingere le rivendicazioni dei lavoratori - leri giornata nazionale stati arrestati - Stato d'emergenza e coprifuoco proclamati in tutto il paese dei mezzadri per la trasformazione del contratto in affitto - Scioperi generali a Salerno e Livorno KHARTUM, M. leri il padronato agrario ha II colonnello Giafar El Numeiri, deposto due giorni fa da un colpo di stato diretto dal maggiore El Atta, •ubito la prima sconfltta. es- e tomato oggi a capo del Sudan in seguito ad un contro-colpc guidato da un gruppo di ufficiali dei re- sendo stato costretto ad accet- parti corazzati sudanesi. Dopo una serie di contraddittorie dichiarazioni rilasciate alia radio, mentre in- tare gran parte delle riven- torno al palazzo presidenziale di Khartum ed in altri quartieri unita dell'esercito fedeli al maggiore El Atta ed a Numeiri dicazioni dei lavoratori per il si scontravano in rapx'i ma sanguinosi combattimenti, nella tarda serata lo stesso Numeiri si recava ai microfoni di « Radio contratto provinciale di Fog Omdurman » per leggere un proclama. -
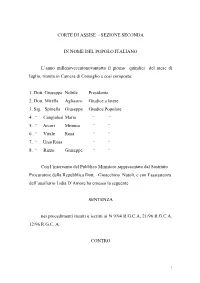
Processo Lima
CORTE DI ASSISE - SEZIONE SECONDA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L’anno millenovecentonovantotto il giorno quindici del mese di luglio, riunita in Camera di Consiglio e così composta: 1. Dott. Giuseppe Nobile Presidente 2. Dott. Mirella Agliastro Giudice a latere 3. Sig. Spinella Giuseppe Giudice Popolare 4. “ Cangialosi Maria “ “ 5. “ Arceri Mimma “ “ 6. “ Vitale Rosa “ “ 7. “ Urso Rosa “ “ 8. “ Rizzo Giuseppe “ “ Con l’intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Gioacchino Natoli, e con l’assisstenza dell’ausiliario Lidia D’Amore ha emesso la seguente SENTENZA nei procedimenti riuniti e iscritti ai N 9/94 R.G.C.A, 21/96 R.G.C.A. 12/96 R.G.C. A. CONTRO 1 1) RIINA Salvatore n. Corleone il 16.11.1930 Arrestato il 18.01.1993 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO- Detenuto per altro - Assente per rinunzia Assistito e difeso Avv. Cristoforo Fileccia Avv. Mario Grillo 2) MADONIA Francesco n. Palermo il 31.03.1924 Arrestato il 21.04.1995 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Giovanni Anania Avv. Nicolò Amato del foro di Roma 3) BRUSCA Bernardo n. San Giuseppe Jato il 09.09.1929 Arrestato il 21.10.1992 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Ernesto D’Angelo 4) BRUSCA Giovanni n. San Giuseppe Jato il 20.02.1957 Arrestato il 23.05.1996 - Scarcerato il 10.04.1998 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Luigi Li Gotti del foro di Roma Avv. -

It's 50 Years Since Caravaggio's Nativity Was Stolen in Palermo- Have
AiA News-Service ART CRIME It’s 50 years since Caravaggio’s Nativity was stolen in Palermo: have the police been chasing red herrings all this time? New enquiries suggest a US or Swiss connection through the mafia heroin trade BERNARDO TORTORICI DI RAFFADALI 8th October 2019 11:38 BST Caravaggio, Nativity with St. Francis and St. Lawrence (1600) Palermo, 18 October 1969: it’s a dark and stormy night and two low-lifes in a Piaggio Ape are driving along the Via Immacolatella in the historic centre. They stop at the Oratory of San Lorenzo, break in and make straight for Caravaggio’s Nativity hanging above the altar, cut the canvas from its frame with a razor, roll it up and leave. This is the opening sequence of one of the most notorious art thefts in history, a sequence that some still find credible. Fifty years on, though, the crime has still not been solved. The passage of time and the endless versions of events offered by informers and pseudo-detectives have taken over the inquiries, while the actual fate of the Nativity remains shrouded in mystery. Here we sum up a few of the most imaginative hypotheses based on the opening sequence outlined above. • The mafioso pentito ( a criminal turned state witness), Marino Mannoia , told Judge Giovanni Falcone in 1989—and he repeated the statement in 1996—that the Caravaggio had been stolen to order, but when the purchaser saw it, he turned it down because it was badly damaged and he subsequently ordered it to be cut up and burned. -

Zerohack Zer0pwn Youranonnews Yevgeniy Anikin Yes Men
Zerohack Zer0Pwn YourAnonNews Yevgeniy Anikin Yes Men YamaTough Xtreme x-Leader xenu xen0nymous www.oem.com.mx www.nytimes.com/pages/world/asia/index.html www.informador.com.mx www.futuregov.asia www.cronica.com.mx www.asiapacificsecuritymagazine.com Worm Wolfy Withdrawal* WillyFoReal Wikileaks IRC 88.80.16.13/9999 IRC Channel WikiLeaks WiiSpellWhy whitekidney Wells Fargo weed WallRoad w0rmware Vulnerability Vladislav Khorokhorin Visa Inc. Virus Virgin Islands "Viewpointe Archive Services, LLC" Versability Verizon Venezuela Vegas Vatican City USB US Trust US Bankcorp Uruguay Uran0n unusedcrayon United Kingdom UnicormCr3w unfittoprint unelected.org UndisclosedAnon Ukraine UGNazi ua_musti_1905 U.S. Bankcorp TYLER Turkey trosec113 Trojan Horse Trojan Trivette TriCk Tribalzer0 Transnistria transaction Traitor traffic court Tradecraft Trade Secrets "Total System Services, Inc." Topiary Top Secret Tom Stracener TibitXimer Thumb Drive Thomson Reuters TheWikiBoat thepeoplescause the_infecti0n The Unknowns The UnderTaker The Syrian electronic army The Jokerhack Thailand ThaCosmo th3j35t3r testeux1 TEST Telecomix TehWongZ Teddy Bigglesworth TeaMp0isoN TeamHav0k Team Ghost Shell Team Digi7al tdl4 taxes TARP tango down Tampa Tammy Shapiro Taiwan Tabu T0x1c t0wN T.A.R.P. Syrian Electronic Army syndiv Symantec Corporation Switzerland Swingers Club SWIFT Sweden Swan SwaggSec Swagg Security "SunGard Data Systems, Inc." Stuxnet Stringer Streamroller Stole* Sterlok SteelAnne st0rm SQLi Spyware Spying Spydevilz Spy Camera Sposed Spook Spoofing Splendide -

Peppino Impastato Peppino Impastato Nacque a Cinisi, Nella Provincia Di Palermo, Il 5 Gennaio 1948, Da Felicia Bartolotta E Luigi Impastato
Peppino Impastato Peppino Impastato nacque a Cinisi, nella provincia di Palermo, il 5 gennaio 1948, da Felicia Bartolotta e Luigi Impastato. La sua era una famiglia inserita negli ambienti mafiosi locali: il padre Luigi era stato inviato al confino durante il periodo fascista, una sorella di Luigi aveva sposato il capomafia Cesare Manzella, considerato uno dei boss che individuarono nei traffici di droga il nuovo terreno per accumulare denaro. Proprio Cesare Manzella fu ucciso nel 1963 in un agguato nella sua Alfa Romeo Giulietta imbottita di tritolo. Peppino frequentò il Liceo Classico di Partinico e in quegli anni si avvicinò alla politica. Nel 1965 fondò il giornalino “L'idea socialista” che, dopo alcuni numeri, fu sequestrato e aderì al PSIUP, formazione politica nata dopo l'ingresso del PSI nei governi di centro-sinistra. Il ragazzo ruppe presto i rapporti con il padre Luigi che lo cacciò di casa. Quando questi morì in un misterioso incidente automobilistico, durante il funerale Peppino Impastato rifiutò di stringere la mano ai boss locali. Dal 1968 in poi partecipò col ruolo di dirigente alle attività dei gruppi comunisti. Condusse le lotte dei contadini espropriati per la costruzione della terza pista dell'aeroporto di Palermo in territorio di Cinisi, degli edili e dei disoccupati. Emblematiche le parole scritte in una biografia dallo stesso Peppino, chiara testimonianza delle emozioni e delle paure che lo portarono alle sue coraggiose scelte: "Arrivai alla politica nel lontano novembre del '65, su basi puramente emozionali: a partire cioè da una mia esigenza di reagire ad una condizione familiare ormai divenuta insostenibile. -

Doc. XXIII, N. 44
CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA Doc. XXIII N. 44 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE (istituita con legge 19 luglio 2013, n. 87) (composta dai deputati: Bindi, Presidente, Attaguile, Segretario, Bossa, Bruno Bossio, Carbone, Costantino, Dadone, Di Lello, Segretario, D’Uva, Garavini, Magorno, Manfredi, Mattiello, Naccarato, Nuti, Piccolo, Piepoli, Prestigiacomo, Sammarco, Sarti, Savino, Scopelliti, Taglialatela e Vecchio; e dai senatori: Albano, Buemi, Bulgarelli, Capacchione, Cardiello, Consiglio, De Cristofaro, Di Maggio, Esposito, Falanga, Gaetti, Vicepresidente, Giar- russo, Giovanardi, Lumia, Marinello, Mineo, Mirabelli, Molinari, Moscar- delli, Pagano, Perrone, Ricchiuti, Tomaselli, Vaccari e Zizza). IL FURTO DELLA NATIVITÀ DEL CARAVAGGIO (Relatrice: on. Rosy Bindi) Approvata dalla Commissione nella seduta del 21 febbraio 2018 Comunicata alle Presidenze il 22 febbraio 2018 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. o), della legge 19 luglio 2013, n. 87 STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO PAGINA BIANCA Camera dei Deputati —3— Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XXIII N. 44 Camera dei Deputati —4— Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XXIII N. 44 Camera dei Deputati —5— Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XXIII N. 44 INDICE 1. Premessa .............................................................................. Pag. 7 2. Le indagini pregresse sul furto della Natività e le loro risultanze ............................................................................. » 8 3. L’inchiesta della Commissione parlamentare antimafia .. » 12 3.1. Le dichiarazioni di Gaetano Grado: “’U Caravaggiu”. » 13 3.2. Le dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia: “Ho detto che il quadro è stato bruciato” ............. -

De Mauro Strangolato Dalla Mafia Un Pentito Rivelacom E Fu Ucciso Il Giornalista Scomodo
Il cronista de «l'Ora» scomparve 23 anni fa Il movente del delitto: «Rompevicoglioni» Gaspare Mutolo ora racconta che l'ordine Adesso i giuclia n^riranno l'incHestaK fu dato dal boss Stefano Bontate Pure Mario Francese; del «Giornaledi Sicilia» Quattro i killer, tutti poi morti ammazzati fu assassinato dai sicari di Cosa Nostra De Mauro strangolato dalla mafia Un pentito rivela come fu ucciso il giornalista scomodo Sarà riaperta l'inchiesta sulla scomparsa, avvenuta "Papà non è ancora tornato", avranno fatto"... Alle nove e quel villino di campagna), tra i 23 anni fa, di Mauro De Mauro. Secondo il racconto - mi disse, e raccontò della mac mezzo bussarono alla porta: quattro uomini d'onore corre -•H;fcM>r.V.,M[. 55 del pentito Gaspare Mutolo, il giornalista de «l'Ora» china che ripartiva. Verso le tre quattro uomini. Il primo si fece un cenno. Tre di loro afferrano fu strangolato. Quattro killer su mandato del boss .telefonammo al giornale di Si avanti e salutò. "Buongiorno" k il giornalista per le braccia. Il cilia, per vedere se magari fos disse. "Sono il commissario : quarto gli mette una «cordicel Stefano Bontate. «Rompeva i coglioni». Aveva sco se là. Non c'era nessuno. Re- ' Boris Giuliano, della squadra la» intomo ai collo. Cosi muore perto gli intrecci del golpe Borghese? Mutolo rac -. starnino ad aspettarlo. Faceva- ; omicidi". Si mìsero subito a - Mauro De Mauro: strangolato Le mille piste conta che anche Mario Francese, del «Giornale di " mo l turni alla finestra». ' verbalizzare il racconto di mia • 'Allora, in Cosa Nostra, non Sicilia», fu ucciso dalla mafia («Dava fastidio»). -
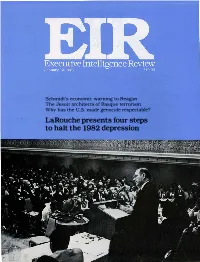
Executive Intelligence Review, Volume 9, Number 2, January 12, 1982
Schmidt's economic warning to Reagan The Jesuit architects of Basque terrorism Why has the U.S. made genocide respectable? LaRouche presents four steps to halt the 1982 depression EIR Executive Intelligence Review Special Reports The special reports listed below, prepared by the EIR staff, are now available. 1. Prospects for Instability in the Arabian Gulf 5. The Significance of the Shakeup at Pemex A comprehensive review of the danger of instabil EIR correctly forecast the political troubles of ity in Saudi Arabia in the coming period. Includes former Pemex director Jorge Diaz Serrano, and analysis of the Saudi military forces, and the in this report provides the full story of the recent fluence of left-wing forces, and pro-Khomeini net shakeup at Pemex.lncludes profile of new Pemex works in the country. $250. director Julio Rodolfo Moctezuma Cid, implica tions of the Pemex shakeup for the upcoming 2. Energy and Economy: Mexico in the Year 2000 presidential race, and consequences for Mexico's A development program for Mexico compiled energy policy. $200. jointly by Mexican and American scientists.Con cludes Mexico can grow at12 percent annually for 6. What is the Trilateral Commission? the next decade, creating a $100 billion capital The most complete analysis of the background, goods export market for the United States. De origins, and goals of this much-talked-about tailed analysis of key economic sectors; ideal for organization. Demonstrates the role of the com planning and marketing purposes. $250. mission in the Carter administration's Global 2000 report on mass population reduction; in the 3.