Luoghi Storia Memoria
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

COPIA Deliberazione Del Consiglio Comunale
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO PROVINCIA DI MODENA COPIA Deliberazione del Consiglio Comunale N. 74 del 25/11/2014 OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE FRA I COMUNI DI SAVIGNANO SUL PANARO, VIGNOLA, CASTELVETRO DI MODENA, MARANO SUL PANARO, GUIGLIA, ZOCCA E MONTESE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL CANILE INTERCOMUNALE, PERIODO 01/01/2015 - 13/06/2017. Seduta n. 12 Il Sindaco Germano Caroli ha convocato il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, l’anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 25 (venticinque) del mese di novembre, alle ore 20.30 nella Sala consiliare. La convocazione è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge e secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale di Savignano sul Panaro. Il Sindaco Germano Caroli assume la presidenza dell’adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta. Lo stesso Sindaco-Presidente procede, quindi, a designare scrutatori i consiglieri Tedeschi, Piccinini e Bonasoni. Risultano presenti: presente assente Caroli Germano – Sindaco X Consiglieri presenti assenti Consiglieri presenti assenti Linari Erio X Piccinini Patrizia X Tabilio Ana Maria X Tedeschi Maurizio X Balestri Angelo X Venturelli Walter X Govoni Andrea X Pisciotta Davide X Montaguti Carmen X Quartieri Cristina X Muzzioli Jennifer X Bonasoni Matteo X Assegnati: n. 13 In carica: n. 13 Totale Presenti: n. 13 Totale Assenti: n. 0 Assessori non consiglieri presente assente Corsini Alessandro X Marchioni Giuseppe X Assiste il Segretario Comunale dott. Paolo Dallolio. La seduta è: (X) pubblica ( ) segreta. (X) Atto dichiarato immediatamente eseguibile. __________________________________________________________________________________________________________ La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio in data 02/12/2014 (prot. -

Pia Ano Di Cl Lassif Fica
PIANO DI CLASSIFICA degli immobili per il riparto degli oneri consortili anno 2015 ALLEGATO 2 Elenco degli interventi di bonifica in montagna e collina Documentazione: ‐ Elenco degli interventi dal 01/10/2009 al 31/12/2014 ‐ Cartografia Elenco degli interventi dal 01/10/2009 al 31/12/2014 IMPORTO N° N° prog. Prov. COMUNE FINANZIAMENTO TITOLO TIPOLOGIA PREVALENTE Progetto Art. 146 D.P.R. 554/1999 – Lavori d’urgenza – Ripristino e ricostruzione opere pubbliche di 1 255 MO Pievepelago Regione Emilia‐Romagna € 55 000 Opere idrauliche bonifica nel Rio Perticara e Rio Grosso in Comune di Pievepelago (MO) Ripristino officiosità idraulica Rio Rivella tra le Zocca 2 256 MO Consorzio località I Pianacci e Mulino Casaccia – Comuni di € 19 500 Funzionalità idraulica Montese Montese e Zocca (MO) Ripristino e consolidamento opera idraulica di 3 257 BO Lizzano in B. Consorzio bonifica nel Fosso dei Castagnacci a valle S.P. 324 in € 40 000 Opere idrauliche Comune di Lizzano in B. (BO) Ricostruzione opera idraulica di bonifica nel Rio 4 258 MO Vignola Consorzio Sassoccia (o Bressola) a monte strada comunale Via € 40 000 Opere idrauliche Sassoccia in Comune di Vignola (MO) Consolidamento pendici in dissesto idrogeologico 5 259 MO Pavullo Consorzio nel Fosso Volpara in frazione di Benedello – Comune € 70 000 Versanti e pendici in dissesto di Pavullo (MO) Consolidamento pendici in dissesto idrogeologico in 6 260 MO Serramazzoni Consorzio € 29 000 Versanti e pendici in dissesto località Granarolo – Comune di Serramazzoni (MO) Interventi manutentori alle opere pubbliche di bonifica nel Bacino del Torrente Motte in Comune di 7 261 PT Abetone Consorzio Abetone – Provincia di Pistoia (Ricostruzione € 30 000 Opere idrauliche cunettone Fosso del Serretto – 3° tratto). -

Ufficio Del Territorio Di MODENA
Ufficio del territorio di MODENA Data: 24/10/2017 Ora: 11.39.43 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2017 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.- del - n.181 del 27/06/2017 REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 VALLI DEL DRAGONE E DEL ROSSENNA ALTO PANARO Comuni di: FRASSINORO, MONTEFIORINO, PALAGANO, POLINAGO Comuni di: FANANO, FIUMALBO, LAMA MOCOGNO, MONTECRETO, MONTESE, PAVULLO NEL FRIGNANO, PIEVEPELAGO, RIOLUNATO, SESTOLA, ZOCCA COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) BOSCO CEDUO DEGRADATO 2000,00 2400,00 BOSCO CEDUO GOVERNATO 4400,00 4600,00 BOSCO D`ALTO FUSTO - DA 0 A 20 ANNI 6400,00 6900,00 BOSCO D`ALTO FUSTO - DA 20 A 40 8600,00 9200,00 ANNI BOSCO D`ALTO FUSTO - OLTRE 40 ANNI 12500,00 13200,00 BOSCO MISTO DEGRADATO 3300,00 3500,00 BOSCO MISTO GOVERNATO 5900,00 6100,00 CASTAGNETO DA FRUTTO 3900,00 4400,00 DEGRADATO CASTAGNETO DA FRUTTO 8000,00 9600,00 GOVERNATO COLTIVO ABBANDONATO 3900,00 4000,00 FRUTTETO DI POMACEE - 14000,00 BASSA/MEDIA DENSITA Pagina: 1 di 9 Ufficio del territorio di MODENA Data: 24/10/2017 Ora: 11.39.43 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2017 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.- del - n.181 del 27/06/2017 REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 VALLI DEL DRAGONE E DEL ROSSENNA ALTO PANARO Comuni di: FRASSINORO, MONTEFIORINO, PALAGANO, POLINAGO Comuni di: FANANO, FIUMALBO, LAMA MOCOGNO, MONTECRETO, MONTESE, PAVULLO NEL FRIGNANO, PIEVEPELAGO, RIOLUNATO, SESTOLA, ZOCCA COLTURA Valore Sup. -

ENTRIAMO NEL FUTURO Emilia
castelfranco emilia PERIODICO COMUNALE DI INFORMAZIONE news ENTRIAMO NEL FUTURO Care cittadine e cari cittadini, sono giorni im- portanti per la nostra Città, giorni in cui an- drà in approvazione il bilancio preventivo del 2016. Il nostro Comune ha bisogno di ga- rantire tenuta sui servizi ed accelerare su- gli investimenti: per rilanciare la qualità urba- na e la fruizione degli spazi pubblici. Abbia- mo un patrimonio pubblico straordinario per entità e complessità che, anche solo per la gestione ordinaria, genera spese importanti. La capacità di investimento è stata rinnova- ta e rilanciata attraverso il nuova assetto or- ganizzativo del quale abbiamo dotato gli uffi- ci comunali, aumentandone l’efficienza e ra- zionalizzando funzioni e costi, così come in- cide anche la ridefinizione ed il conseguen- te allentamento dei lacci del patto di stabi- lità, che ora ci permette di attingere di in- vestire maggiori risorse. Mentre scrivo que- sto editoriale è in discussione la legge di sta- bilità nazionale e quindi, a giorni, sapremo cosa il Legislatore nazionale avrà deciso cir- ca fiscalità locale e finanziamento di Comu- ni ed enti locali. Ad oggi sappiamo che dal primo di gennaio 2016 scadrà il benefit del differimento del rimborso mutui per l’area del sisma 2012, non si potranno più utiliz- zare gli oneri di urbanizzazione accertati in I tre pilastri del Bilancio corso d’anno per finanziare le manutenzio- ni ordinarie, ed il Fondo che garantisce i cre- diti di dubbia esigibilità aumenterà di circa 356.000,00 euro: questi tre elementi, assie- SCUOLA me, determinano complessivamente mag- CULTURA SOCIALE RILANCIO giori spese per 1.200.000,00 euro che tut- GIOVANI SICUREZZA DELLA CITTA’ SPORT €€6.703.6.703.968968 €€3.462.1833.462.183 tavia non si traducono né in opere né in ser- €€ 7.004.283 vizi. -

Campionato Provinciale Pallavolo 2018-19
Commissione Tecnica Pallavolo Comitato di Modena - Comitato di Carpi Campionato Provinciale Pallavolo 2018-19 Note Cat. Open Misto Amatori Età: Senza Limiti Set: 3 fissi Rete: m. 2,35 - Per FASI FINALI, PROMOZIONI e RETROCESSIONI manderò comunicato a parte Punti Classifica 3 punti in caso di vittoria per 3-0 o 2-1 (da 2-0) 2 punti in caso di 2-1 (da 1-1) 1 punto in caso di sconfitta per 1-2 0 punti in caso di sconfitta per 0-3 - Si ricorda che dal 1° luglio 2017 con il Decreto Balduzzi è obbligatorio per le squadre ospitanti (squadra prima menzionata) mettere a disposizione DAE (defibrillatore) e operatore addetto al DAE. E' necessario indicare in elenco atleti, in fondo nell'apposito spazio, i dati dell'operatore DAE, il numero di attestato e la firma. - TESSERATI FIPAV: Possono partecipare atleti i cui nominativi siano inseriti nei tabulati FIPAV ma che non partecipino ad attività federali di qualsiasi livello nell'anno sportivo in corso, ad esclusione delle donne che possono prendere parte a campionati di 1a, 2a e 3a divisione. Inoltre in ogni squadra sono ammessi: CAT. ECCELLENZA: 1 uomo in campo che partecipi alla 1°Divisione (i tesserati di 1° Divisione devo-no essere indicati ad elenco obbligatoriamente con asterisco); uomini di 2a e 3a Divisione senza limiti. CAT. PROMOZIONE: NESSUN tesserato Fipav uomo. - Il tesseramento di atleti/e già tesserati/e per la corrente stagione sportiva presso altre Società affiliate CSI non costituisce doppio tesseramento se accompagnato dal nullaosta della Società di provenienza. - Trasferimento giocatori: è possibile il trasferimento di atleti/e da una società all’altra previo presenta-zione del nullaosta della società cedente ed entro il 31/01/2019 - Alle fasi finali provinciali possono partecipare solo atleti tesserati almeno 45 giorni prima dell'inizio delle stesse ed essere stati inseriti in elenco atleti ad almeno 5 partite, mentre per la fase Regionale i termini saranno comunicati dalla Commissione di competenza. -
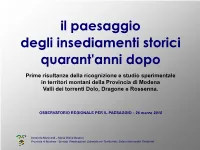
Presentazione Di Powerpoint
il paesaggio degli insediamenti storici quarant'anni dopo Prime risultanze della ricognizione e studio sperimentale in territori montani della Provincia di Modena Valli dei torrenti Dolo, Dragone e Rossenna. OSSERVATORIO REGIONALE PER IL PAESAGGIO - 26 marzo 2018 Antonella Manicardi – Maria Giulia Messori Provincia di Modena - Servizio Pianificazione Urbanistica e Territoriale, Sistemi Informativi Territoriali riferimenti Il CODICE DEI BENI CULTURALI (art.133) + DM 25/09/2008 (art.3) − attività assegnate agli Osservatori: ANALISI – STUDI - PROPOSTE − rete di Osservatori nazionale e regionali per definire tra Ministero e Regioni: “Politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio”. LEGGE REGIONALE n. 24/2017 (art. 68) disciplina l’Osservatorio Regionale per la qualità del paesaggio come in precedenza già faceva l’articolo 40octies della LR 20/2000 (Osservatorio Regionale istituito con DG. 2060 del 20/12/2017) I compiti assegnati sono: 1. Monitorare l’attuazione della pianificazione paesaggistica e le evoluzioni delle trasformazioni del paesaggio. 2. Realizzare studi 3. Raccogliere ed elaborare dati 4. Formulare proposte 5. Collaborare con Enti per l’esercizio dei propri compiti 6. Redazione dello STATO DEL PAESAGGIO da parte della Giunta ogni 3 anni 7. Realizzare attività di informazione per i cittadini Concordia Mirandola Novi San Possidonio il progetto San Felice Finale E. Cavezzo Medolla Carpi San Prospero Camposanto Bomporto Soliera Ravarino 1° AREA STUDIO Bastiglia Campogalliano Nonantola Appennino Ovest Modena Castelfranco -

Mirandola Carpi Modena Finale Emilia
Piano Interno - Allegato II - Associazioni e volontari sul territorio provinciale MIRANDOLA CARPI MODENA ANPAS - PC (20) AGESCI Carpi (15) Gruppo Comunale Modena (84) ANA ARI Carpi (22) AGESCI Modena (12) S. POSSIDONIO ULM Carpi (8) ANPAS- PC (10) GEV Antenna 2000 (28) UNUCI Modena (3) S. PROSPERO GEV ARI Modena (15) ANPAS - PC (5) ANA AVIS (8) GEV CAMPOGALLIANO A.N.M. CRI (9) ANA GEV Centro Modena Sub (4) CONCORDIA NOVI DI MODENA MASCI (4) MEDOLLA Gruppo Comunale Novi (24) Radio Club 81 (25) CAVEZZO SOLIERA Sea Sub (10) Gruppo Comunale Soliera (24) VAB (PROVINCIALI - 30) ANPAS - PC (10) GEV (PROVINCIALI - 51) ANA FINALE EMILIA BASTIGLIA Gruppo Comunale Finale Emilia (23) ANPAS - PC (2) CAMPOSANTO BOMPORTO Gruppo Comunale Camposanto (20) Gruppo Comunale Bomporto (55) ANPAS - PC (10) CASTELFRANCO EMILIA S. FELICE SUL PANARO GEV GSC CUD (15) ANA ANPAS - PC (6) NONANTOLA ORSA (1) Piano Interno - Allegato II - Associazioni e volontari sul territorio provinciale SASSUOLO FRIGNANO MODENA OVEST AS Paracadutisti (15) PAVULLO MONTEFIORINO ANC Sassuolo (10) Gruppo Comunale Pavullo (24) ANA GEV GEV FRASSINORO ANA ANPAS - PC (10) ANA FIORANO M. ANA PALAGANO ANPAS - PC (3) FANANO ANPAS - PC (2) GEV GEV ANA ANA ANA PRIGNANO FORMIGINE FIUMALBO ANA Gruppo Comunale Formigine (15) ANA ANPAS - PC (5) LAMA MOCOGNO GEV ANPAS - PC (3) MODENA EST ANA ANA GUIGLIA MARANELLO MONTECRETO Gruppo Comunale Guiglia (8) ANPAS - PC (3) ANPAS - PC (3) GEV GEV ANA ANA ANA PIEVEPELAGO MONTESE GEV ANPAS - PC (5) ANA ANA VIGNOLA POLINAGO ZOCCA GI Terre Castelli (12) ANPAS - PC (3) GFZ (5) ANPAS - PC (4) ANA ANPAS - PC (2) GEV RIOLUNATO ANA ANA ANA MARANO CASTELVETRO DI M. -

Repubblica Italiana
REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA Parte seconda - N. 193 Anno 45 31 luglio 2014 N. 241 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 LUGLIO 2014, N. 1210 Autorizzazione del sostegno al reddito a favore dei lavoratori autonomi o parasubordinati delle aree colpite dal sisma del maggio 2012 delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, di cui alla DGR 1857/2013 e ss.mm. - Secondo provvedimento - Modifica alla DGR 974/2014 2 31-7-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 241 REGIONE EMILIA-ROMAGNA - da una successiva verifica effettuata sull’”Elenco dei collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 LU- agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autono- GLIO 2014, N. 1210 mi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, Autorizzazione del sostegno al reddito a favore dei lavora- iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assisten- tori autonomi o parasubordinati delle aree colpite dal sisma za, ammessi al sostegno al reddito per sospensione dell’attività a del maggio 2012 delle province di Bologna, Ferrara, Modena causa degli eventi sismici” di cui all’allegato 1 parte integrante e e Reggio Emilia, di cui alla DGR 1857/2013 e ss.mm. - sostanziale della propria deliberazione n. 974/2014, più volte ri- Secondo provvedimento - Modifica alla DGR 974/2014 chiamata, sono emersi meri errori materiali di digitazione dei dati, e che quindi si ritiene opportuno approvare il suddetto allegato LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA con i dati corretti; Richiamate le proprie deliberazioni: Ritenuto, pertanto, sulla base delle risultanze dell’esito - n. -

Patto Corresponsabilità Estate.Pdf
IL FUTURO INIZIA… dall’estate! Insieme per le famiglie e i bambini Patto di corresponsabilità tra la Famiglia e ASP Terre di Castelli - G. Gasparini PREMESSA L’ASP Terre di Castelli - G. Gasparini, propone un servizio estivo di supporto educativo innovativo, partecipato e di stimolo per la fascia di bimbi 12-36 mesi le cui famiglie, alla ripresa dell’attività lavorativa, devono necessariamente ri- affidare i bimbi, in modo progressivo dopo il periodo del dialogo a distanza del periodo di sospensione. Dopo i “giardini aperti”, questo servizio estivo ha l’obiettivo di far proseguire i bambini iscritti al Nido e frequentanti i servizi di ASP Terre di Castelli “Giorgio Gasparini” nel percorso di ripresa di una buona relazione e socializzazione a partire dall’esperienza di chiusura dei servizi causa COVID-19. E’ altresì importante, tra le mission principali di ASP, essere di aiuto ai bisogni dei genitori che hanno ripreso l’attività lavorativa, offrendo dunque un utile supporto alla loro conciliazione. Alla frequenza saranno ammessi bambini già iscritti presso i nidi di ASP Terre di Castelli “G. Gasparini”. SERVIZI PROPOSTI: • ATTIVITA’ ESTIVA PART TIME PRESSO IL NIDO AZZURRO DI CASTELNUOVO R. • ATTIVITA’ ESTIVA BABY SITTING FULL TIME PRESSO IL NIDO LE MARGHERITE DI SPILAMBERTO FINALITA’ Il progetto offre alle famiglie che operano in attività lavorative, la possibilità di poter fruire di un qualificato servizio ricreativo per l’infanzia proponendo ai bambini un’esperienza di giochi, stimoli e attività in particolar modo afferenti alla pedagogia dell’ outdoor education . INNOVATIVO perché - le famiglie saranno parte integrante della costruzione dei gruppi e dei percorsi educativi scelti e coordinati dalla supervisione della coordinatrice pedagogica di ASP Terre di Castelli- G.Gasparini e Unione Terre di Castelli. -

Venceslao Santi Pievepelago E La Rivoluzione Del 1831 I. I Fatti
Venceslao Santi Pievepelago e la rivoluzione del 1831 I. I fatti precedenti Le frequenti ruberie, le molteplici requisizioni, le leve forzate e le violenze di ogni maniera che dal 1796 al 1814 furono fatte anche nella provincia di Modena dai Francesi calati in Italia per portarvi, dicevano essi, la libertà e l’eguaglianza, avevano suscitato nell’animo dei Frignanesi, forse più che negli abitanti delle città e della pianura, una così profonda avversione contro la dominazione e gli ordinamenti di quei nuovi apostoli di libertà, che nel 1814 anche quassù fu accolta con gioia la noti- zia della disfatta di Napoleone I e venne salutata con entusiasmo l’instaurazione nel ducato di Mo- dena di Francesco IV, già preannunciata quale apportatrice di pace, di giustizia e di prosperità mate- riale e morale. E, come accade sempre nelle forti reazioni, il popolo non si restrinse a stigmatizzare gli eccessi del- la rivoluzione e della egemonia francese, ma arrivò perfino a giudicare come funeste nella vita pra- tica quelle dottrine fondamentali civili e politiche che formano la conquista più bella di quel grande rivolgimento. Si ebbe così una novella prova che i nemici più funesti alla vera libertà sono coloro che di questa fanno maggiore abuso. Dall’altra parte il nuovo duca, prodigando ai suoi sudditi blandizie paterne, proteste amorevoli, ge- nerose largizioni, secondandone i desideri col ripristino di istituzioni predilette, colla costruzione o col riattamento di strade, colla somministrazione di lavoro e di commestibili nelle annate penuriose, esonerandoli o alleggerendoli da tasse gravose, li rese più devoti e più sottomessi al principato asso- luto e perciò più alieni dalle innovazioni e dai mutamenti politici. -

Rinnovo Accreditamento Definitivo CRA Montese
Unione di Comuni Terre di Castelli (Provincia di Modena) Determinazione nr. 1355 Del 20/12/2019 Welfare Locale OGGETTO: Rinnovo concessione accreditamento definitivo a favore di Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale per il servizio di Casa Residenza Anziani di Montese. LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO Richiamata la normativa della Regione Emilia-Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari ed in particolare: - l’art. 38 della L.R. n.2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; - la DGR n. 772/2007; - l’art. 23 della L.R. n.4/2008; - la DGR n. 514/2009 e successive integrazioni e modificazioni (DGR n.390/2011, DGR n.1899/2012, n.1828/2013, DGR n. 715/2015, DGR n. 664/2017); - le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2110/2009, n. 219/2010, n.1336/2010, n.292/2014, n.1800/2014, n. 273/2016, n.1516/2018 e n. 1429/2019 inerenti il sistema di remunerazione; - le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2109/2009 e n. 1018/2014 relative all’organismo tecnico di ambito provinciale (OTAP); Viste le indicazioni regionali in materia di accreditamento definitivo dei servizi socio- sanitari ed in particolare: - la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 7597 del 06/06/2014 avente ad oggetto l’approvazione dello schema-tipo della domanda di rilascio dell’accreditamento definitivo; - la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 17320 del 21/11/2014 avente ad oggetto l’approvazione degli schemi-tipo valevoli -

HISTORY of the 85Th MOUNTAIN INFANTRY REGIMENT
HISTORY of the 85th MOUNTAIN INFANTRY REGIMENT 4 JANUARY 1945 — 31 MAY 1945 John B. Woodruff Captain, 85th Mountain Infantry Historical Records Officer 1945 HISTORY of the 85th MOUNTAIN INFANTRY in ITALY 4 JANUARY 1945 — 31 MAY 1945 DEDICATED TO Our comrades in the 85th Mountain Infantry who made the supreme sacrifice that we might live as free men. Digitized and edited by Barbara Imbrie, 2004 CONTENTS OVERSEAS TRANSPORT: HAMPTON ROADS, VIRGINIA TO BAGNI DI LUCCA.....................1 (4 Jan — 19 Jan) PATROLS AND RAIDS FROM MONTEFEGATESI AND MONTI DI VILLA...................................2 (20 Jan — 12 Feb) ATTACK ON MT. GORGOLESCO AND MT. DELLA TORRACCIA .................................................6 (13 Feb — 28 Feb) February Attack Objectives C through H.....................................................................................16 ATTACK ON MT. DELLA SPE ................................................................................................................17 (1 Mar — 31 Mar) March Attack Objectives A through Q .........................................................................................32 BREAKOUT INTO THE PO VALLEY.....................................................................................................33 (1 Apr — 30 Apr) LAKE GARDA TO SURRENDER ............................................................................................................62 (1 May — 31 May) COMBAT ORGANIZATION OF THE 85TH REGIMENT ...................................................................72 CASUALTIES