Comuni Di Argenta, Migliarino, Ostellato, Portomaggiore E
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

06 Miccoli Presentazione Sett 2018 SS
Progetto IDROVIA FERRARESE Provincia di Ferrara progetto REGIONE EMILIA ROMAGNA Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile SERVIZIO AREA RENO e PO DI VOLANO Dott. Claudio Miccoli Ferrara, 28 Settembre 2018 OPERE FINANZIATE L’Idrovia Ferrarese è un progetto promosso dalla Regione Emilia-Romagna, coordinato dalla Provincia di Ferrara e finanziato con fondi statali (L. 413/98), per un importo totale di: €. 145,00 Mln Il progetto generale prevede un importo totale di circa €. 240 Mln Estensione totale dell’asta: 70 km 1° LOTTO : tratto compreso tra la conca di Pontelagoscuro e il Ponte Prinella (tratto cittadino) - €. 78,0 Mln 2° LOTTO : tratto di Final di Rero – Tresigallo-Migliarino - €.25,4 Mln 3° LOTTO : tratto compreso tra la conca di Valle Lepri e l’accesso al mare di Porto Garibaldi - €. 27 Mln LOTTO Nuovo Ponte di Ostellato – Ostellato - €. 8,0 Mln LOTTO Arni – Ostellato - €. 6,5 Mln MAPPA DEGLI INTERVENTI DELL’IDROVIA FERRARESE PORTO GARIBALDI LIDO ESTENSI LAVORI APPALTATI per un totale di €. 75 Mln INTESA PRELIMINARE e OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO Il progetto IDROVIA prende origine nell’anno 1999 con il Protocollo d’intesa per lo sviluppo del sistema idroviario padano-veneto stipulato tra Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venzia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto. In questo quadro la Regione Emilia Romagna condivide l’iniziativa riguardante l’adeguamento ed il potenziamento della via d’acqua esistente che collega il Po al Mare attraverso il territorio Provinciale. Il progetto IDROVIA Risezionamento del canale e di FERRARESE ha lo scopo di alcune curve per garantire il realizzare un collegamento via rettangolo di navigazione minimo acqua dalla conca di previsto per la classe Va e un Pontelagoscuro a Porto tracciato a norma. -
Servizio Idro-Meteo-Clima Viale Silvani, 6 – Bologna 051 6497511
Rapporto dell’evento meteorologico dal 12 al 14 novembre 2017 A cura di Unità Radarmeteorologia, Radarpluviometria, Nowcasting e Reti non convenzionali Area Centro Funzionale e Sala Operativa Previsioni BOLOGNA, 21/11/2017 Riassunto Il maltempo ha interessato diffusamente la Regione portando copiose nevicate, anche a quote molto basse, come a Bologna città e Imola. Moltissimi sono stati i rami caduti in varie zone dell'Emilia, a causa della neve caduta sui rami ancora ricchi di fogliame. La neve ha interessato interamente l’Appennino dal Piacentino fino alla Romagna. Nel Ferrarese e sulla costa si sono verificate, inoltre, fortissime raffiche di vento che hanno causato la caduta di alberi. In copertina: l’albero caduto sulla linea ferroviaria Porrettana (Fonte: il resto del Carlino Bologna) e la neve sull’Appennino modenese (Fonte: il Resto del Carlino Modena) Indice 1. Evoluzione generale e zone interessate .................................................................... 4 2. Analisi dell’evoluzione alla mesoscala sull’Emilia-Romagna ................................. 9 3. Cumulate di precipitazione ....................................................................................... 13 4. Analisi della neve ed effetti al suolo ........................................................................ 18 5. Analisi del vento ed effetti al suolo ......................................................................... 27 1. Evoluzione generale e zone interessate Il giorno 12 novembre sull’Europa è presente una intensa saccatura con minimo sul Mare del Nord, estesa fino all'Europa centrale. Dall'Atlantico si estende invece verso l'Europa occidentale una estesa area anticiclonica che tende a convogliare aria fredda di origine artica lungo il suo bordo settentrionale sino alle nostre latitudini. Sul bacino del Mediterraneo è comunque presente un'estesa area temperata delimitata a sud da un piccolo minimo depressionario che lambisce le coste settentrionali dell'Africa (Figura 1). -

The Waterway of Ferrara in the European Core Network
THE WATERWAY OF FERRARA IN THE EUROPEAN CORE NETWORK Waterways to connect Europe In October 2011, the European THEIL SISTEMAWATERWAY Commission submitted an OF FERRARA amendment proposal for the IDROVIARIO regulations governing the trans- PROJECT AS PART European transport networks PADANO-VENETOOF THE EUROPEAN (TEN-T) to the European Parliament and Council. CORE NETWORK The proposal entailed two distinct parts: Guidelines for the development of the Trans- European Transport Network and Connecting Europe Facility. In December 2013 both proposals were approved and published in the Official Journal of the European Union. The program is being developed on two levels, with the goal of improving the planning of new TEN-T networks: • A global, Comprehensive network to be completed by 2050 and intend- ed to supply the central network via regional and national connections. • A central, Core network composed of 9 corridors, to be completed and operational by 2030. It will serve the most important connections and hubs within the TEN-T network: capitals, large urban hubs, the main harbours and airports. It will be at the heart of the TEN-T network, as it will contain the areas of the global network with the highest strategic value. These are key elements paramount to achieving the general goals of the project, as well as added-value goals for the EU, such as establishing missing transborder connections, multimodal nodes, and eliminating the main bottlenecks. Within the current revision of the TEN-T network, the entire “Padano-Veneto waterway system” is part of the “Core network”. All funding is provided for studies or con- struction work contributing to the project’s global objectives. -

Il Giorno19 Febbraio 2002, Ai Sensi
Prot. n. (VIM/08/290285) _____________________________________________________________ LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 1 PREMESSO CHE: 1.1 la Provincia di Ferrara – Settore Tecnico, Infrastrutture, Edilizia Scolastica, Protezione Civile, ha presentato, con nota del 15 giugno 2007 prot. n. 53556, domanda di attivazione della procedura di VIA di cui al Titolo III della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, relativa al progetto di adeguamento dell'idrovia ferrarese al traffico idroviario di classe V europea; 1.2 l’istanza e la relativa documentazione sono state acquisite agli atti della Regione con prot. n. 164229 del 20 giugno 2007; 1.3 con avviso pubblicato, ai sensi dell’art. 14 comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 20 giugno 2007, è stata data comunicazione dell’avvenuto deposito, presso la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Ferrara ed i Comuni di Ferrara, Formignana, Tresigallo, Copparo, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Comacchio, degli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura di VIA, ed è iniziato a decorrere il periodo di 45 giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati; 1.4 con avviso pubblicato, ai sensi dell’articolo sopra citato, sui quotidiani “la Nuova Ferrara” ed “il Resto del Carlino” del 20 giugno 2007, è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), del progetto definitivo e della sintesi non tecnica relativi al progetto sottoposto alla presente procedura di VIA; 1.5 il progetto depositato prevede l’adeguamento dell’Idrovia ai parametri previsti per la classe V, tramite interventi consistenti sostanzialmente in scavi di risezionamento del canale ed adeguamento dei manufatti di attraversamento; 1.6 con nota prot. -

Piano Strutturale Comunale in Forma Associata ARGENTA-MIGLIARINO-OSTELLATO PORTOMAGGIORE-VOGHIERA
Piano Strutturale Comunale in Forma Associata ARGENTA-MIGLIARINO-OSTELLATO PORTOMAGGIORE-VOGHIERA PROVINCIA DI FERRARA P S C L.R. 20/2004 QUADRO CONOSCITIVO Capitolo D IL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE stesura approvata Sindaco di Argenta Antonio Fiorentini Sindaco di Migliarino Sabina Mucchi Sindaco di Ostellato Andrea Marchi Sindaco di Portomaggiore Gian Paolo Barbieri Sindaco di Voghiera Claudio Fioresi GRUPPO DI LAVORO Coordinamento generale arch. Natascia Frasson - responsabile dell'Ufficio di Piano Intercomunale Ufficio di Piano Comune di Argenta - arch. Natascia Frasson, arch. Leonardo Monticelli collaboratori - geom. Nicola Baldassari, dr.ssa Nadia Caucci, geom. Paolo Orlandi Comune di Migliarino - arch. Antonio Molossi Comune di Ostellato - geom. Claudia Benini Comune di Portomaggiore - ing. Luisa Cesari, geom. Gabriella Romagnoli Comune di Voghiera - arch. Marco Zanoni collaboratori - geom. Massimo Nanetti Consulente responsabile del presente elaborato: tecnicoop arch. Rudi Fallaci arch. Franco Tinti dott. agr. Fabio Tunioli dott. Paolo Trevisani arch. Barbara Marangoni arch. Filippo Boschi cartografia - Andrea Franceschini INDICE D – IL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE 1 D.1 – LA PIANIFICAZIONE REGIONALE, PROVINCIALE E DI BACINO 1 D.1.1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale D.1.2. La fase di aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 9 D.1.3. Il piano infraregionale delle attività estrattive 2002-2011 16 D.1.4. I piani per l’assetto idrogeologico delle Autorità di Bacino 22 D.1.5. Il Piano di Tutela delle Acque 28 D.2 – LA TUTELA DELLE RISORSE NATURALI, STORICHE E PAESAGGISTICHE 33 D.2.1. Valori naturali e del paesaggio 33 D.2.2 La Convenzione di Ramsar e le zone umide 35 D.2.3. -

C O M U N E D I F I S C a G L
C O M U N E d i F I S C A G L I A (Comune istituito il 01.01.2014 L. Regionale E.R. n.18/07.11.2013 mediante fusione dei Comuni di Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino) Provincia di F E R R A R A Settore Affari Generali ESITO PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO – 2018/2020 (Art. 29 e 98 D.Lgs.vo 50/2016) 1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Fiscaglia – P.zza XXV Aprile, 8 44027 Fiscaglia (FE) tel. 0533 654150 – fax 0533 654772 - posta elettronica: [email protected] indirizzo internet: www.comune.fiscaglia.fe.it 2. Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente territoriale; 3. Codice CIG: 729575684E 4. Codice CPV: 66518100-5 5. Codice NUTS del luogo di presentazione: ITH56 6. Descrizione dell’Appalto : Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo Anni 2018/2020. Importo posto a base di gara: € 56.716,00 nel periodo di validità di anni tre, con facoltà di rinnovo di anni due e proroga tecnica art. 106 co. 11 D.Lgs.vo 50/2016. 7. Procedura di gara: Procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. esperita sul mercato elettronico della centrale di committenza della Regione Emilia Romagna Intercent-Er rivolta a tutti gli operatori economici accreditati e abilitati per il settore oggetto di gara ed in possesso dei requisiti richiesti 8. Criterio di aggiudicazione : Aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs.vo n. -

Studio Di Fattibilità Per Il Processo Di Fusione Tra I Comuni Di Migliaro, Migliarino, Massa Fiscaglia
1 Comune di Comune di Comune di MIGLIARO MIGLIARINO MASSA FISCAGLIA STUDIO DI FATTIBILITÀ PER IL PROCESSO DI FUSIONE TRA I COMUNI DI MIGLIARO, MIGLIARINO, MASSA FISCAGLIA ALLEGATO 1: DATI RELATIVI ALLA DIMENSIONE ECONOMICO FINANZIARIA ALLEGATO 2: ITER NORMATIVO E ATTI COSTITUTIVI ALLEGATO 3: ADEMPIMENTI E OBBLIGHI PER PICCOLI COMUNI/INDENNITÀ DI CARICA dicembre 2012 rev. 1 Poleis Consulting Srl Via Baccelli, 44 – Modena | Via Gulinelli, 11 – Ferrara Sommario ALLEGATO 1 ......................................................................................................................................................................3 RENDICONTO E INDICI ....................................................................................................................................................3 2 PROSPETTO COMPARATIVO DEL CONTO DEL PATRIMONIO E DEL CONTO ECONOMICO .................................5 COSTI DELLA POLITICA E DI SEGRETERIA GENERALE ................................................................................................7 DATI DAL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 ...................................................................................................................7 ALLEGATO 2 ......................................................................................................................................................................8 ITER NORMATIVO E ATTI COSTITUTIVI........................................................................................................................8 ALLEGATO 3 -

Studio Di Fattibilità Per Il Processo Di Fusione Tra I Comuni Di Migliaro, Migliarino, Massa Fiscaglia
Comune di Comune di Comune di MIGLIARO MIGLIARINO MASSA FISCAGLIA STUDIO DI FATTIBILITÀ PER IL PROCESSO DI FUSIONE TRA I COMUNI DI MIGLIARO, MIGLIARINO, MASSA FISCAGLIA dicembre 2012 rev. 1 Poleis Consulting Srl Via Baccelli, 44 – Modena | Via Gulinelli, 11 – Ferrara Sommario PREMESSA GENERALE ............................................................................................................................ 5 PARTE PRIMA ......................................................................................................................................... 8 LA DIMENSIONE POLITICO-ISTITUZIONALE NEI COMUNI DI MIGLIARO, MIGLIARINO E MASSA FISCAGLIA . 8 3 POLITICHE TERRITORIALI E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE ...................................................................................... 9 ECONOMIA ............................................................................................................................................. 10 POLITICHE DEI SERVIZI ............................................................................................................................... 12 SERVIZI E FUNZIONI INTERNE ALLE AMMINISTRAZIONI ........................................................................................ 14 COSTI DELLA POLITICA E RAPPRESENTANZA TERRITORIALE ................................................................................... 15 LA DIMENSIONE DEMOGRAFICA DEI COMUNI DI MIGLIARO, MIGLIARINO E MASSA FISCAGLIA .............. 18 PREMESSA ............................................................................................................................................. -
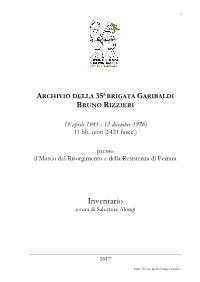
Inventario Analitico
0 A ARCHIVIO DELLA 35 BRIGATA GARIBALDI BRUNO RIZZIERI 19 aprile 1945 - 12 dicembre 1976) 11 bb. (con 2.421 fascc.) presso il Museo del Risorgimento e della Resistenza di Ferrara Inventario a cura di Salvatore Alongi 2017 http://sa-ero.archivi.beniculturali.it/ 1 SOMMARIO INTRODUZIONE p. 2 Nota storica p. 3 Nota archivistica p. 4 INVENTARIO p. 5 Busta 1 (A-Berta) p. 6 Busta 2 (Berte-Bu) p. 31 Busta 3 (C) p. 55 Busta 4 (D-E-F) p. 84 Busta 5 (G) p. 112 Busta 6 (H-I-K-L-Ma) p. 139 Busta 7 (Me-N-O-Pa) p. 165 Busta 8 (Pe-Q-R) p. 191 Busta 9 (S-Ta) p. 218 Busta 10 (Te-U-V) p. 241 Busta 11 (Z) p. 262 http://sa-ero.archivi.beniculturali.it/ 2 INTRODUZIONE http://sa-ero.archivi.beniculturali.it/ 3 Nota storica La 35a brigata Garibaldi trae le sue origini da un gruppo di azione patriottica (gap) attivo a Ferrara fin dall’inizio del 1944 in azioni di sabotaggio delle linee ferroviarie e di attacco ai centri di comando tedeschi. Nell’aprile di quello stesso anno il gruppo prese il nome di 35a brigata Garibaldi Ferrara, mutato poco dopo in 35a brigata Garibaldi Bruno Rizzieri in onore del patriota ucciso dai fascisti il 30 aprile 1944. La brigata, sotto la guida di Gino Lambertini (alias Dante), coadiuvato dal commissario politico Giovanni Guerzoni (alias Libero), fu organizzata in distaccamenti intitolati ad altrettanti caduti: “Mario Bisi” (operante nella zona di Bondeno), “Luigi Rispoli” (operante nella zona di Cento), “Luigi Cavicchini” (operante nella zona di Jolanda di Savoia). -
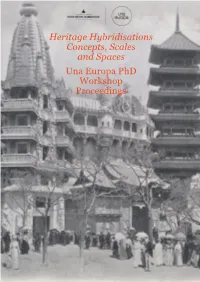
Proceedings of the First Una Europa
Heritage Hybridisations Concepts, Scales and Spaces Una Europa PhD Workshop Proceedings Heritage Hybridizations Conceps, Scales and Spaces Una Europa PhD Workshop Paris 1 Panthéon-Sorbonne May 10-12, 2021 Una Europa: Freie Universität Berlin Alma Mater Studiorum – Università di Bologna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie University of Edinburgh Helsingin Yliopisto KU Leuven Universidad Complutense de Madrid Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Texts sumited by their authors. Editing: Maria Gravari-Barbas & Isidora Stanković Graphic design: Isidora Stanković Paris, May 2021 9 Introductions Explaining the Framework Maria Gravari-Barbas, Alain Duplouy, Dominique Poulot and 10 Isidora Stanković Heritage Hybridizations 13 Maria Gravari-Barbas and Dominique Poulot Inaugural Lecture Conservation, Conversation, and Conflict. Unpacking Hybridity and the Making of Heritage 16 Noémie Étienne 21 Papers of PhD Candidates (i) Political, transnational and community negotiations and 22 heritage hybridisation Far-right Populist PEGIDA and Dresden’s Cultural Heritage: Politics, Ideology, and Hybridization 23 Sabine Volk Presenting the national history of Lebanon after a civil conflict: a heritage hybridisation? 28 Zoé Vannier Prospected heritage manifested through translation criticism – the case of Rocznik Literacki [The Literary Annual] 1932- 1938 32 Joanna Sobesto Terroir as heritage: protected geographical indications and anchoring the Intangible in the race for authenticity 36 Jenny L. Herman “Nos Ancêtres les Aztèques” Representations of the Pre-Columbian past and hybrid national and heritage narratives in 19th century Parisian 40 World Fairs Susana Stüssi Garcia Archiving as Resistance: Remembering Feminist Heritage in the Feminist Art Program 46 Verena Kittel The collection of pre-Columbian artefacts in the Public Museums of Argentina. 51 María Agustina Arnulfo The emergence of a preservation framework for Ottoman architectural vestiges in interwar Greece. -

CBD Fourth National Report
Republic of Italy Ministry of the Environment, Land and Sea Convention on Biological Diversity Fourth National Report 31/03/2009 Executive Summary ............................................................................................................................. 4 CHAPTER I - Overview of status, trends and threats to biodiversity ................................................. 8 I.A THE COUNTRY ...................................................................................................................... 8 I.A.1 Geography and Geo-morphology................................................................................. 8 I.A.2 Climate overview ......................................................................................................... 9 I.A.3 Pedology..................................................................................................................... 10 I.A.4 Land cover and use .................................................................................................... 10 I.B BIODIVERSITY OVERVIEW ................................................................................................... 14 I.B.1 Landscape and habitat ................................................................................................ 14 I.B.2 Marine environment ................................................................................................... 17 I.B 3 Terrestrial species: fauna and flora ............................................................................ 18 I.B 4 Marine -
A Historical Collection of Termites in Ferrara: Recovery, Cataloguing and Geographical Analyses
insects Article A Historical Collection of Termites in Ferrara: Recovery, Cataloguing and Geographical Analyses Davide Curci 1, Chiara Scapoli 1, Maria Gabriella Marchetti 1, Milvia Chicca 1, Marilena Leis 1, Chiara Beatrice Vicentini 1, Teresa Bonacci 2 and Marco Pezzi 1,* 1 Department of Life Sciences and Biotechnology, University of Ferrara, Via L. Borsari 46, 44121 Ferrara, Italy; [email protected] (D.C.); [email protected] (C.S.); [email protected] (M.G.M.); [email protected] (M.C.); [email protected] (M.L.); [email protected] (C.B.V.) 2 Department of Biology, Ecology and Earth Sciences, University of Calabria, Via P. Bucci, Arcavacata di Rende, 87036 Cosenza, Italy; [email protected] * Correspondence: [email protected] Simple Summary: Termites, an insect group relevant for recycling of organic matter, are also biodete- riogenic organisms that cause serious damages to wooden structures in anthropogenic environments. Professor Antonio Springhetti, a renowned Italian entomologist who studied termites in Italy from 1950 to around 1990, collected many specimens during his field campaigns, and his collection was enriched by termite samples from around the world donated by other entomologists. His precious collection, preserved at the University of Ferrara, represents not only a valuable scientific tool for studies on ecologically relevant insects that may seriously damage historical buildings and ancient libraries but also an important cultural asset. Citation: Curci, D.; Scapoli, C.; Abstract: Termites are an insect group relevant for recycling of organic matter, but they are also Marchetti, M.G.; Chicca, M.; Leis, M.; biodeteriogenic and may cause serious damages to wooden structures (including historical buildings Vicentini, C.B.; Bonacci, T.; Pezzi, M.