Fervore Meccanico a Torino
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
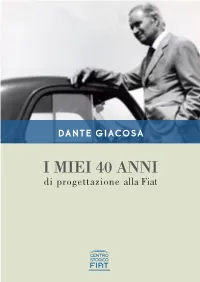
I MIEI 40 ANNI Di Progettazione Alla Fiat I Miei 40 Anni Di Progettazione Alla Fiat DANTE GIACOSA
DANTE GIACOSA I MIEI 40 ANNI di progettazione alla Fiat I miei 40 anni di progettazione alla Fiat DANTE GIACOSA I MIEI 40 ANNI di progettazione alla Fiat Editing e apparati a cura di: Angelo Tito Anselmi Progettazione grafica e impaginazione: Fregi e Majuscole, Torino Due precedenti edizioni di questo volume, I miei 40 anni di progettazione alla Fiat e Progetti alla Fiat prima del computer, sono state pubblicate da Automobilia rispettivamente nel 1979 e nel 1988. Per volere della signora Mariella Zanon di Valgiurata, figlia di Dante Giacosa, questa pubblicazione ricalca fedelmente la prima edizione del 1979, anche per quanto riguarda le biografie dei protagonisti di questa storia (in cui l’unico aggiornamento è quello fornito tra parentesi quadre con la data della scomparsa laddove avve- nuta dopo il 1979). © Mariella Giacosa Zanon di Valgiurata, 1979 Ristampato nell’anno 2014 a cura di Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. Logo di prima copertina: courtesy di Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. … ”Noi siamo ciò di cui ci inebriamo” dice Jerry Rubin in Do it! “In ogni caso nulla ci fa più felici che parlare di noi stessi, in bene o in male. La nostra esperienza, la nostra memoria è divenuta fonte di estasi. Ed eccomi qua, io pure” Saul Bellow, Gerusalemme andata e ritorno Desidero esprimere la mia gratitudine alle persone che mi hanno incoraggiato a scrivere questo libro della mia vita di lavoro e a quelle che con il loro aiuto ne hanno reso possibile la pubblicazione. Per la sua previdente iniziativa di prender nota di incontri e fatti significativi e conservare documenti, Wanda Vigliano Mundula che mi fu vicina come segretaria dal 1946 al 1975. -

RAPID Ceirano & C., Welleyes, F.Lli Ceirano
RAPID Ceirano & C., Welleyes, F.lli Ceirano, STAR Rapid, Matteo C. & C., Itala, Ceirano-Ansaldo, SPA, Junior, SCAT, S.A.Giovanni Ceirano: sono undici aziende, accomunate da due denominatori, sono tutte nate a Torino e sono tutte sorte per iniziativa di uno o dell'altro dei fratelli Ceirano. Addentrarsi nelle vite e nelle frenetiche attività dei quattro fratelli, distinguendo l'apporto di ciascuno, non è facile. I Ceirano sono una famiglia piemontese, originaria di Cuneo, composta da padre, madre e quattro fratelli: Giovanni Battista, nato nel 1860, Giovanni, nato nel 1865, Matteo, il viveur della famiglia, di cinque anni più giovane, ed Ernesto, nato dopo altri cinque anni. A questi si aggiunge in un secondo tempo il figlio di Giovanni che, con una certa mancanza di fantasia, è battezzato Giovanni e chiamato Ernesto. Come si vede, ci sono già i presupposti per una bella confusione, anche a prescindere dai rispettivi caratteri, che sicuramente devono essere stati piuttosto determinati, per non dire litigiosi e testardi, anche perché uno dopo l'altro si consacrano al medesimo mestiere: fondare aziende automobilistiche. Fondare, per poi andarsene, o fonderle con altre, o scioglierle, o rilevarle, in un caleidoscopio di società che vivacizzarono ed arricchirono molto il panorama industriale torinese ed italiano. Il primo a muoversi è naturalmente Giovanni Battista, il più anziano. Fonda la Ceirano & C. nel 1898 e la Welleyes nel 1899; quindi nel 1901, insieme a Matteo, la F.lli Ceirano, in corso Vittorio Emanuele 9. Liquidata questa nel 1903, nel 1904 trasforma la Ceirano & C. in STAR, Società Torinese Automobili Rapid, oggetto di questa breve indagine. -

San Salvario Il Quartiere Della Nascita Dell'auto a Torino
San Salvario Il quartiere della nascita dell'auto a Torino A cura di Enrico Miletto, Fondazione Vera Nocentini e Donatella Sasso, Istituto di studi storici Gaetano Salvemini 1 Origini e topografia del quartiere Il quartiere deriva il proprio nome dalla chiesa di San Salvatore in Campagna (da qui la popolare denominazione di San Salvario), edificata da Amedeo di Castellamonte tra il 1646 e il 1653, per volontà della Madama Reale Cristina di Francia. Da un punto di vista topografico, l’area di San Salvario è delimitata dai corsi Massimo d’Azeglio, Vittorio Emanuele II, Bramante e dalla via Nizza. Il borgo vero e proprio inizia a prendere forma soltanto a partire dalla metà dell’Ottocento, quando sorgono i primi insediamenti urbani, attigui alla campagna circostante. Orti, giardini, campi e vivai definiscono la porzione di territorio che dalla strada reale di Nizza (l’attuale via Nizza) arriva fino al Valentino. 2 Porta Nuova e commercio 1848-1852 Viene inaugurato il primo tratto ferroviario che collega Torino a Moncalieri seguito, nel 1853, da quello con Genova. Lo sviluppo dello scalo ferroviario di Porta Nuova, la cui direttrice divide San Salvario dai vicini rioni della Crocetta e di San Secondo, favorisce la crescita nel quartiere di attività commerciali. Sorgono così botteghe e aziende artigianali che contribuiscono a disegnare un’immagine di un quartiere dai ritmi concitati, una piccola city, operosa e indaffarata, le cui strade, ricche di negozi e botteghe, sono percorse, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, da carri trainati da cavalli, tramways e carretti. San Salvario conta all’epoca 50 isolati, circa 200 abitazioni ed è sede di una delle 10 preture cittadine. -

TECNICHE E TECNOLOGIE INNOVATIVE NELLE VETTURE ITALA Conferenza Di Carlo Otto Brambilla Milano, 8 Ottobre 1994 Museo Nazionale Della Scienza E Della Tecnologia
TECNICHE E TECNOLOGIE INNOVATIVE NELLE VETTURE ITALA Conferenza di Carlo Otto Brambilla Milano, 8 ottobre 1994 Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia ALESSANDRO COLOMBO Il nostro socio, Carlo Brambilla, che sta ultimando un libro sull’Itala, ha aderito alla mia richiesta su alcune anticipazioni su quello che sarà detto in questo libro, in particolare per quello che riguarda le soluzioni tecniche innovative che l’itala ha posto in alcune sue vetture, quindi questo è il tema della conferenza, diamo inizio senz’altro. Grazie a tutti. CARLO OTTO BRAMBILLA L’argomento è vastissimo perché l’Itala ha avuto una produzione estremamente diversificata di vetture e di motori, che variavano molto rapidamente. Premetterò quindi dei cenni generali sull’Itala, da un punto di vista tecnico e industriale, e poi cercherò di focalizzare l’attenzione su alcuni fatti particolarmente interessanti, ciò perché fare una trattazione con un minimo di approfondimento sui temi tecnici sviluppati dell’Itala, sostanzialmente 25 anni di produzione automobilistica, e anche di più se si considerano i derivati della ’61, sarebbe impossibile in così poco tempo, oppure sarebbe troppo superficiale e poco interessante. La prima cosa da dire è sicuramente che questa conferenza, e il libro che sto preparando ormai da molti anni, è possibile esclusivamente grazie al lavoro del Conte Carlo Biscaretti di Ruffia. Carlo Biscaretti di Ruffia, fu negli anni dal ’16 al ’30, il capo ufficio stampa dell’Itala, però la sua attività non fu solo quella di capo ufficio stampa, fu un’attività un po’ particolare, un’attività di consulente, sia dell’Itala sia di una serie di altre case automobilistiche, in qualità di libero professionista. -

Cronologia Di Torino Industriale 1959
Cronologia di Torino industriale 1959 - 2011 A cura di Cristina Accornero, ISMEL CITTA' DELLA INNOVAZIONE 1861-1918 Da capitale politica a capitale industriale 1859 Nasce la Scuola d’Applicazione per gli Ingegneri 1860 Dal 1 gennaio si avvia la pubblicazione della «Gazzetta di Torino» fondata per iniziativa dell’avvocato Giovanni Piacentini 1861 Torino diventa capitale del Regno d’Italia 1862 Il Comune istituisce la Commissione per lo studio delle modalità di sviluppo di Torino 1862 Nascita del Regio Museo Industriale (23 novembre), direttore Giuseppe Devincenzi 1864 Trasferimento della capitale a Firenze; tumulti popolari del 21 e 22 settembre; appello del sindaco Emanuele Luserna di Rorà rivolto agli imprenditori d’Oltralpe 1864 Creazione della Società degli Ingegneri e degli industriali (25 marzo) 1864 Costruzione della Caserma Cernaia (progetto del gen. Barabino e Giovanni Castellazzi (allievo di Carlo Promis) 1864 Su progetto di Giuseppe Bollati si realizza Piazza Statuto con capitale internazionale (inglese) 1865 Fondazione dell’Associazione Generale degli Operai (AGO) con sede in Corso Siccardi 1867 Nascita della «Gazzetta Piemontese» 1867 Ristrutturazione dell’Arsenale di Borgo Dora (progetto di G. Castellazzi) 1868 Nasce l’attività di Moriondo-Gariglio, fabbrica di cioccolato con negozio e laboratorio in piazza San Carlo 1868 Nasce lo stabilimento Giovan Battista Fornara fabbrica di telai metallici 1868 Ricostruzione della Stazione di Porta Nuova (Alessandro Mazzucchetti con la collaborazione di Carlo Ceppi) 1868 Creazione della Scuola di Chimica tecnologica (direttore Emilio Kopp) 1868 Realizzazione della Basilica Maria Ausiliatrice nella città Salesiana (progetto dell’arch. Spezia) 1869 Pubblicazione della guida Torino descritta di Pietro Baricco 1870 Costruzione delle Carceri Nuove (progetto di Giuseppe Polani) 1871 Creazione della Stazione Agraria Sperimentale all’interno del Regio Museo Industriale 1871 Realizzazione del Traforo del Frejus (progetto di Germain Sommeiller, Sebastiano Grandis e Severino Grattoni). -

STORIA DELLA JUNIOR Ma La Junior Esistette Veramente?
STORIA DELLA JUNIOR Ma la Junior esistette veramente? Fu veramente fondata nel 1904, come affermano le cronache “a posteriori”, o, nel “mare magnum” delle aziende che sorsero come per incanto tra il 1904 e il 1907, magari quotate in borsa prima ancora di avere uno stabilimento, degli operai, un progetto a cui lavorare (per non parlare di un mercato), anche la Junior si rivelò una delle tante speculazioni finanziarie del periodo, destinate a fare la fine di una bolla di sapone? Sorge il dubbio della effettiva esistenza di questa azienda, visto che di un atto di fondazione, nelle riviste e nei documenti d’epoca, non c’è traccia. Su “Auto” del 1904 campeggia, fin dai primi fascicoli, una pubblicità della “Fabbrica di Automobili G.G.F.lli Ceirano”, ossia della società formatasi tra Giovanni e Giovanni Battista Ceirano. La vettura proposta è, naturalmente, “semplice-pratica-economica-sicura”, ed è fornita in due diverse motorizzazioni da 9 e da 12 HP. Dei fratelli Ceirano Auto d’Epoca si è già occupata (vedi storia della Rapid nel numero del giugno 2001), e già perciò sappiamo di questi quattro fratelli cuneesi che, grazie alla loro “esuberanza” imprenditoriale, alla loro litigiosità e vivacità diedero vita a ben undici fabbriche automobilistiche diverse, nell’arco di anni tra il 1898 e il 1919. Alcune di queste ebbero vita brevissima, altre, come Itala, diventarono così importanti da porsi come l’unica vera rivale della Fiat, di altre ancora si sa poco, altre ancora acquistarono un ruolo, come la Spa, nel settore dei veicoli pesanti. Ma tutte comunque lasciarono un segno, e nell’insieme i Ceirano possono essere considerati non soltanto dei pionieri ma i veri e propri padri fondatori dell’industria automobilistica italiana. -

Martiai Law Tightened Bedrooms, Large Kit AVAILABLE Im M E BUICK, INC
— MANCHESTER HERALD. Wednesday. June 7. 1989 1 ^ HOMES ROOMS APARTMENTS I HOMES mTV/8TERE0/ I CARS CARS I CARS FOR SALE FOR RENT FOR RENT FOR RENT l^oirAPPLIANCES FOR SALE FOR SALE FOR SALE TOLLAND. Single fur T E N rooms, two full plus MANCHESTER. Two and SOUTH Windsor. Large WHIRLPOOL heavy duty MAZDA RX7 LS, 1980. C H EV Y Citation. 1981, CHORCHES MOTORS Hostages Champ Speaker two holt baths, enor nished room. Heat, three bedrooms. Se six bedroom Contem washer and Fridgidar Garaged winters, low 80 Oakland St. electicitv and parking. Automatic, air, two mous first floor family curity and references. porary home. Three dryer. 684-6576. mileage. $3,200 or best door hatchback. Front- Manchester, CT - r . room, delux oak kit $80. weekly. 875-0337. Call 645-8201. full baths, two car gar offer. 742-6141._______ ELEC T R IC Stove. Sears wheel drive, new front 1 9 e e DOOOE DYNASTY *12.138 Iranian official Foley rejects chen, full walk-out M ANCH ESTER. One bed age plus pool and deck. 20", 4 burner. White BUICK Skylark, 77. Two struts, tires, body M H S’s Cruz proves mettle $1300 monthly. Call IMS CHRYSLER SIh AVE *14BM basement. In-law setup WE DELIVER room apartment. $475 Nutone Coppertone door fully equipped. good. 875-6991. on first floor and lots For Home Delivery. Call per month Includes D.W. Fish Realty, 871- Range hood with vent Dependable car. $600. IMS OOOQE ARIES *7.SM m ak e s an offer /7 at the Girls’ State Open /13 role as czar /9 more! $219,900. -

TORINO E LE FABBRICHE Percorsi Multimediali Sulla Storia Industriale Della Città
CENTRO ON LINE STORIA E CULTURA DELL’INDUSTRIA il Nord Oves t dal 1850 PROPOSTE DIDATTICHE PER LE SCUOLE TORINO E LE FABBRICHE Percorsi multimediali sulla storia industriale della città 1 Con il sostegno di Con la collaborazione di 2 Indice Percorso storico L’INDUSTRIA TORINESE SUL FINIRE DEL XIX SECOLO ...................................5 LA NASCITA DELLE BARRIERE OPERAIE .....................................................5 BARRIERA DI MILANO ..............................................................................6 BORGO SAN PAOLO .................................................................................6 BORGO VITTORIA ....................................................................................7 BORGO REGIO PARCO ..............................................................................8 PRIMA GUERRA MONDIALE .......................................................................9 LA SECONDA GUERRA MONDIALE ............................................................ 10 I BOMBARDAMENTI ............................................................................... 10 DALLA RICOSTRUZIONE AL BOOM ECONOMICO ..........................................11 DA SUD A NORD: LA CITTÀ E I MOVIMENTI MIGRATORI ...............................11 LE FABBRICHE...................................................................................... 13 Le fonti e il loro uso nella ricerca .............................................................. 19 Per saperne di più… ............................................................................ -

2017 02135/064 Area Partecipazioni Comunali MP 0/B
Direzione Patrimonio, Partecipate e Appalti 2017 02135/064 Area Partecipazioni Comunali MP 0/B CITTÀ DI TORINO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 6 giugno 2017 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli Assessori: Roberto FINARDI Paola PISANO Stefania GIANNUZZI Sergio ROLANDO Marco GIUSTA Alberto SACCO Francesca Paola LEON Sonia SCHELLINO Federica PATTI Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora Maria LAPIETRA. Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. OGGETTO: CIMITERO MONUMENTALE - POSA DI CIPPO FUNERARIO E TARGA COMMEMORATIVA IN MEMORIA DI GIOVANNI BATTISTA CEIRANO E DEI SUOI FRATELLI. 2017 02135/064 2 Proposta dell’Assessore Giusta. Il RACI (Registro Ancetres Club Italia), con lettera protocollata numero 799/2017 del 21 marzo 2017, esprimeva la volontà di commemorare la memoria di Giovanni Battista Ceirano e dei suoi fratelli Giovanni e Matteo e la storia della locomozione a Torino, con la posa di un cippo funerario e di una targa commemorativa presso il Cimitero Monumentale di Torino, essendo ivi sepolti. La Città di Torino, avendo valutato la richiesta meritevole di accoglimento in virtù dell’importanza rivestita dai fratelli Ceirano nello sviluppo dell’industria automobilistica della città di Torino e nell’ottica di perseguire una sempre maggiore valorizzazione del proprio patrimonio cimiteriale, ha invitato, con nota protocollo 838/2017 del 22 marzo 2017, AFC Cimiteri Spa, in qualità di soggetto gestore dei cimiteri cittadini, a farsi parte attiva nei confronti dell’Associazione, al fine di definire il luogo della posa e le caratteristiche tecniche del progetto, nonché a definire il contenuto dell’epigrafe. Successivamente, con lettera protocollata numero 1525 del 19/05/2017, l’Associazione RACI trasmetteva agli uffici della Città il progetto contenente disegni, fotografia ed epigrafe, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante (all. -

Lezione 6 Industria Dell'auto File
L’evoluzione dell’industria dell’automobile in Italia: Il caso di Torino Si ringraziano Aldo Enrietti e Ken Simons per l’utilizzo dei loro lucici Aldo Geuna Indice Gli albori dell’auto: fine ottocento primi del novecento, nasce un industria. – USA, Italia, Torino I principali attori dello sviluppo dell’auto a Torino: – Ceirano, Lancia, FIAT L’evoluzione dell’industria dell’auto negli USA: Il Fordismo, il modello T L’evoluzione dell’ industria dell’auto in Italia ed a Torino L’evoluzione dell’industria dell’auto e lo Shakeout Gli albori dell’auto GLI ALBORI DELL’AUTO: fine ‘800, Inizio del ‘900 1.1 L’AUTO COME PRODOTTO 1.2 L’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA NEGLI USA E IN EUROPA 1.3 L’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA IN ITALIA E A TORINO 1.1 L’AUTO COME PRODOTTO Nasce per sostituire la trazione animale e si è servita, di volta in volta, di motori diversi a seconda dei sistemi di alimentazione Il primo prototipo funzionante è del 1769 ed ha un motore a vapore: il carro di CUGNOT era in grado di trainare 4 ton. di peso Gli sviluppi del motore a vapore furono tali che già nel 1828 le città di Londra e Bath erano collegate da autobus, appunto a vapore Durante il 1800 si svilupparono ricerche sia per il motore endotermico che per quello elettrico: quest’ultimo si dimostrava assai performante, al punto che nel 1899 Camille Jenatzy superava i 100 km/h con La Jamais Contente Bisogna aspettare la fine del secolo XIX per vedere le prime vetture circolanti Un salto in avanti nella motorizzazione avvenne nel 1876 grazie a Nikolaus August Otto, inventore del primo motore a combustione interna a quattro tempi. -

“In Una Rete Di Linee Che Si Intersecano”
Viana Conti “In una rete di linee che si intersecano” user Viana Conti 0 1 La maggior parte degli intervistatori ritengono che il pensiero dell’intervistatore sia più importante di quello dell’intervistato. L’intervista è un male del giornalismo, perché evita di pronunciare giudizi, evita di fare articoli critici. L’intervista è un fatto di grande immoralità e pigrizia da parte dei giornali. Ha senso quando per la prima volta riesce a far parlare un personaggio che non si è mai espresso e allora riesce a bloccarlo in un dialogo, cosa che avviene ogni tanto. I giornali devono dare i fatti e poi dei commenti. Umberto Eco, intervistato da Gianni Riotta in L’eco della storia, 2015 (https://www.raicultura.it/storia/articoli/2018/12/-Incontro-con-Umberto-Eco-790a9d6b-da2f- 4d63-9c48-956de0585f76.html) 2 3 Indice Alcune Note Introduttive 8 1. From Viana to Viana: Becoming 10 Documento 1 – Edoardo Manzoni - Come lo ricorda Viana Conti 11 Documento 2 - Viana Conti, Quattro momenti di un’azione 16 2. Collaborazione con il Comune di Genova 17 Documento 3 – Pamela Pastori, Situazioni 18 2.1 Claudio Costa, Antropologia e Controculture 19 Documento 4 – Genova: mostre e notizie – Ottobre/Dicembre 1976 24 2.2 Intervista a John Cage 29 Documento 5 – Lasciar essere i suoni. Incontro con John Cage 33 2.3 L’Arte e la Città 35 2.3.1 Il Gergo Inquieto 36 Documento 6 – Uno spazio per la città – 43 2.3.2 Sapere e Potere 47 2.3.2.1 Rassegna stampa 63 2.3.2.2 Gli Atti del Convegno 65 2.3.3 Cinema Off e Jack Smith 69 2.3.4 “L’Unità” – Arte e Città – Genova negli anni ’80 75 Documento 7 – Arte e città – Inchiesta 76 2.4 Pittura di Corta Memoria 91 2.5 Uno sguardo sul mondo 96 2.6 Giappone Avanguardia del Futuro 100 Documento 8 – L’impero dei segni ha invaso Genova 103 2.7 Pittura in Liguria 116 2.7.1 Giovani pittori in Liguria al Museo di Villa Croce 119 Documento 9 – Nel giorno dopo il dibattito 121 3. -

Atti E Rasseg a Tec
A&RT ATTIDELLA SOCIETÀ E DEGLI RASSEG A I GEG ERI E DEGLI ARCHITETTI TEC ICA I TORI O RIVISTA FONDATA A TORINO NEL 1867 NUOVA SERIE - ANNO LXIV - Numero 3 - DICEMBRE 2010 Direttore: Vittorio Neirotti (fino al 31.12.2010), Carla Barovetti (dal 01.01.2011) Segretario: Davide Rolfo Tesoriere: Claudio Vaglio Bernè Art Director: Riccardo Franzero Comitato di redazione: Domenico Bagliani, Alessandro De Magistris, Guglielmo Demichelis, Marco Filippi, (fino al 31.12.2010) Alessandro Martini, Franco Mellano, Paolo Picco, Costanza Roggero, Valerio Rosa, Paolo Rosani, Mauro Sudano, Marco Trisciuoglio Comitato di redazione: Domenico Bagliani, Alessandro De Magistris, Guglielmo Demichelis, Marco Filippi, (dal 01.01.2011) Alessandro Martini, Franco Mellano, Paolo Picco, Costanza Roggero, Valerio Rosa, Andrea Rolando, Mauro Sudano, Mauro Volpiano Sede Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino Corso Massimo d’Azeglio 42, 10123 Torino, telefono 011 - 6508511 - www.siat.torino.it ISSN 0004-7287 Periodico inviato gratuitamente ai Soci della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino. ATTI E RASSEGNA TECNICA DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO N.S. A. 64 - N. 3 - DICEMBRE 2010 3 A&RT Numero pubblicato con il contributo della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Torino. Curatore del numero: Alessandro De Magistris. Immagine di copertina: incisione di Onorato De Roni, 1781, tratta da Mario Oreglia, Contrappunto nel paesaggio urbano torinese di torri, campanili, cupole, in Augusto Cavallari Murat, Politecnico di Torino. Istituto di architettura tecnica, Forma urbana ed architettura nella Torino barocca. Dalle premesse classiche alle conclusioni neoclassiche, UTET, Torino 1968, pag. 1037. ATTI E RASSEGNA TECNICA 4 DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO N.S.