L'elisir D'amore
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
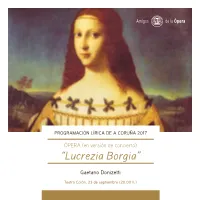
“Lucrezia Borgia”
PROGRAMACIÓN LÍRICA DE A CORUÑA 2017 ÓPERA (en versión de concierto) “Lucrezia Borgia” Gaetano Donizetti Teatro Colón, 23 de septiembre (20.00 h.) PROGRAMACIÓN LÍRICA DE A CORUÑA 2017 EDITA Amigos de la Ópera de A Coruña DISEÑO Y MAQUETACIÓN Lamarck Publicidad TRADUCCIÓN Roxelio Xabier García Romero IMPRIME Imprenta da Deputación da Coruña Gaetano Donizetti Lucrezia Borgia Ópera en un prólogo y dos actos, con libreto de Felice Romani, basado en el drama Lucrèce Borgia de Víctor Hugo, y música de Gaetano Donizetti, estrenada en el Teatro alla Scala de Milán el 26 de diciembre de 1833. REPARTO Lucrezia Borgia Mariella Devia, soprano Gennaro Celso Albelo, tenor Don Alfonso Luiz-Ottavio Faria, bajo Maffio Orsini Elena Belfiore, mezzosoprano Rustighello Francisco Corujo, tenor Astolfo Axier Sánchez, barítono Jacoppo Liverotto Enrique Alberto Martínez, tenor Apostolo Gazella David Sánchez, bajo Oloferno Vitellozzo Ramón Farto, tenor Ascanio Petrucci Pedro Martínez Tapia, barítono Gubetta Jeroboám Tejera, bajo Coro Gaos Fernando Briones, director Orquesta Sinfónica de Galicia Andriy Yurkevych, director 6 Lucrezia Borgia Ópera en só un prólogo e dous actos, con libreto de Felice Romani, baseado no drama Lucrèce Borgia de Víctor Hugo, e música de Gaetano Donizetti, estreada no Teatro alla Scala de Milán o 26 de decembro de 1833. REPARTO Lucrezia Borgia Mariella Devia, soprano Gennaro Celso Albelo, tenor Don Alfonso Luiz-Ottavio Faria, baixo Maffio Orsini Elena Belfiore, mezzosoprano Rustighello Francisco Corujo, tenor Astolfo Axier Sánchez, barítono Jacoppo Liverotto Enrique Alberto Martínez, tenor Apostolo Gazella David Sánchez, baixo Oloferno Vitellozzo Ramón Farto, tenor Ascanio Petrucci Pedro Martínez Tapia, barítono Gubetta Jeroboám Tejera, baixo Coro Gaos Fernando Briones, director Orquestra Sinfónica de Galicia Andriy Yurkevych, director 7 ARGUMENTO El prólogo se desarrolla en Venecia, y el drama en Ferrara, a comienzos del siglo XVI. -

Stagione Lirica 2015
JESI / TEATRO G.B. PERGOLESI 48a STAGIONE LIRICA DI TRADIZIONE ottobre - dicembre 2015 dedicata a Mario Del Monaco nel centenario della nascita MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE / ORE 16* MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE / ORE 16* MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE / ORE 16* VENERDÌ 16 OTTOBRE / ORE 20.30 VENERDÌ 13 NOVEMBRE / ORE 20.30 VENERDÌ 11 DICEMBRE / ORE 20.30 DOMENICA 18 OTTOBRE / ORE 16 DOMENICA 15 NOVEMBRE / ORE 16 DOMENICA 13 DICEMBRE / ORE 16 NABUCCO DON PASQUALE LA VEDOVA ALLEGRA di Giuseppe Verdi di Gaetano Donizetti di Franz Lehár Dramma lirico in quattro parti Dramma buffo in tre atti Operetta in tre parti Libretto di Temistocle Solera Libretto di Giovanni Ruffini Libretto di Victor Léon e Leo Stein interpreti Carlos Almaguer, Maria Billeri, interpreti Paolo Bordogna, Pablo Garcia interpreti Valeria Esposito, Alessandro Ramaz Chikviladze, Elisa Barbero, Ruiz, Maria Mudryak, Pietro Adaìni, Safina, Francesca Tassinari, Christian Collia, Leonardo Gramegna, Paolo Battaglia, Claudio Grasso Armando Ariostini, Gennaro Cannavacciuolo, Enrico Giovagnoli, Alex Martini Roberto Carli, Alice Molinari direttore Giuseppe La Malfa direttore Antonio Pirolli direttore Aldo Sisillo regia Andrea Cigni regia Vittorio Sgarbi regia e scene Stefano Monti scene e costumi Lorenzo Cutuli regista assistente Cinzia Gangarella elementi scenici dello scultore Vincenzo Balena FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana coreografie Cinzia Scuppa costumi Massimo Carlotto Coro Lirico Marchigiano “V. Bellini” FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana Orchestra dell’Opera Italiana maestro del coro, Carlo Morganti Coro Lirico Marchigiano “V. Bellini” Coro Lirico Marchigiano V. Bellini maestro del coro, Carlo Morganti coproduzione Fondazione Pergolesi Spontini, maestro del coro Carlo Morganti Teatro “G. Donizetti” di Bergamo, Teatro produzione Fondazione Pergolesi Spontini coproduzione Teatro Comunale Sociale di Como, Teatro “A. -

|L'elisir D'amore
|L’ELISIR D’AMORE Gaetano Donizetti - Nouvelle production de l’Opéra Grand Avignon - Répétition générale Vendredi 17 mai – 14h00 Opéra Confluence Durée 2h10 |L’ELISIR D’AMORE Opéra en deux actes de Gaetano Donizetti Livret de Felice Romani d’après Eugène Scribe pour Le Philtre d’Auber Créé au Teatro della Canobbiana, Milan le 12 mai 1832 Dernière représentation à Avignon le 11 mars 2008 - Nouvelle production de l’Opéra Grand Avignon - Direction musicale Samuel Jean Études musicales Ayaka Niwano Mise en scène Fanny Gioria Chorégraphie Éric Belaud Décors et lumières Hervé Cherblanc Costumes Irène Bernaud Assistante costumes Alexandra Langlois Adina Maria Mudryak Giannetta Pauline Rouillard Nemorino Sahy Ratia Belcore Philippe-Nicolas Martin Dulcamara Sébastien Parotte Assistant de Dulcamara Baptiste Joumier Chœur, Ballet et Maîtrise de l’Opéra Grand Avignon Orchestre Régional Avignon-Provence - L’Elisir d’Amore Chanté en italien, surtitré en français Durée 2h10 L’ELISIR D’AMORE Opéra Grand Avignon Égalité 2018 |A PROPOS DE GAETANO DONIZETTI… Domenico Gaetano Maria Donizetti naît un 29 novembre 1797 à Bergame, ville située au nord-est de Milan, dans la belle région de la Lombardie. Imaginons un instant la « Città Alta », sa grande porte vénitienne de San Giacomo, ses superbes remparts d’où les levers et les couchers de soleil deviennent le spectacle le plus fabuleux qui soit et suivons un moment la course heureuse de l’enfant Donizetti qui vient ici prendre de la hauteur. Cette ville, Donizetti la connait dans ses moindres recoins, il y vit entouré des siens, cinquième enfant des six de la famille. Les parents, de condition modeste, sont néanmoins très attentifs au devenir de chacun, ainsi on rêve déjà d’une carrière d’avocat pour le jeune Gaetano qui pour l’heure, tout à sa songerie matinale et passionné de dessin s’imagine devenir architecte. -
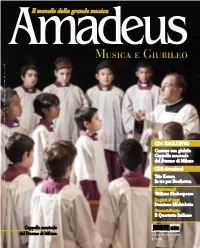
Musica E Giubileo, Essa Niente È Stato Fatto Di Ciò Che Esiste» Internazionale Svoltosi a Roma Nel Giugno in Quello Stesso Anno Santo Si Erano Giusto E Così Via
314 2016 Il mensile della grande musica - GENNAIO GENNAIO - I ANNO XXVII ANNO Amadeus Musica e Giubileo CD1 ESCLUSIVO 2016 EURO 11,00 MENSILE POSTE ITALIANE SPED. IN A. P - D.L. 353/2003 CONV. L. 46/2004, ART. 1, C. 1, LO/ MI Cantare con giubilo Cappella musicale GENNAIO del Duomo di Milano CD2 download Musica&Giubileo / Quartetto Italiano / Michieletto / Grubinger Bauermeister-Stockhausen / Shakespeare Trio Kanon In tre per Beethoven ANNO XXVIII - NUMERO 1 (314) (314) 1 NUMERO XXVIII - ANNO Anniversari William Shakespeare Registi d'oggi Damiano Michieletto Storia&Storie Il Quartetto Italiano 60001 Cappella musicale s 9 771120 454004 u de del Duomo di Milano numero 314 gennaio 2016 a m € 11,00 A 2 Amadeus Amadeus 3 Wolfgang Amadeus Mozart AGORÀ Le Serenate Una porta aperta Accademia Litta bbiamo già avuto più volte il privilegio di ospitare la firma di Sua Eminenza Gianfranco Ravasi sulle pagine di Amadeus: “Pietre, spade, vomeri” è il titolo di un suo prezioso contributo Carlo De Martini, concertazione Aper uno Speciale Amadeus dedicato a Gerusalemme, «sposa contesa materialmente e spiritualmente». Era il dicembre del 2005, esattamente dieci anni fa. Un bel tratto di tempo, se misurato col metro dei comuni mortali, ma poco più di un batter di ciglio se il metro è quello delle Cofanetto 6 cd + booklet con guida all'ascolto Sacre Scritture. Un batter di ciglio che oggi ci mostra contese (o guerre) non solo per Gerusalemme, ma per tutto il Medio Oriente e buona parte dell’Africa. A distanza dunque di “soli” dieci anni e solo per un a soli 25 euro evento fuori dalla portata del nostro normale lavoro di cronisti della musica ritorna l’illustre firma (la trovate a pag. -

Constructing the Archive: an Annotated Catalogue of the Deon Van Der Walt
(De)constructing the archive: An annotated catalogue of the Deon van der Walt Collection in the NMMU Library Frederick Jacobus Buys January 2014 Submitted in partial fulfilment for the degree of Master of Music (Performing Arts) at the Nelson Mandela Metropolitan University Supervisor: Prof Zelda Potgieter TABLE OF CONTENTS Page DECLARATION i ABSTRACT ii OPSOMMING iii KEY WORDS iv ACKNOWLEDGEMENTS v CHAPTER 1 – INTRODUCTION TO THIS STUDY 1 1. Aim of the research 1 2. Context & Rationale 2 3. Outlay of Chapters 4 CHAPTER 2 - (DE)CONSTRUCTING THE ARCHIVE: A BRIEF LITERATURE REVIEW 5 CHAPTER 3 - DEON VAN DER WALT: A LIFE CUT SHORT 9 CHAPTER 4 - THE DEON VAN DER WALT COLLECTION: AN ANNOTATED CATALOGUE 12 CHAPTER 5 - CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 18 1. The current state of the Deon van der Walt Collection 18 2. Suggestions and recommendations for the future of the Deon van der Walt Collection 21 SOURCES 24 APPENDIX A PERFORMANCE AND RECORDING LIST 29 APPEDIX B ANNOTED CATALOGUE OF THE DEON VAN DER WALT COLLECTION 41 APPENDIX C NELSON MANDELA METROPOLITAN UNIVERSTITY LIBRARY AND INFORMATION SERVICES (NMMU LIS) - CIRCULATION OF THE DEON VAN DER WALT (DVW) COLLECTION (DONATION) 280 APPENDIX D PAPER DELIVERED BY ZELDA POTGIETER AT THE OFFICIAL OPENING OF THE DEON VAN DER WALT COLLECTION, SOUTH CAMPUS LIBRARY, NMMU, ON 20 SEPTEMBER 2007 282 i DECLARATION I, Frederick Jacobus Buys (student no. 211267325), hereby declare that this treatise, in partial fulfilment for the degree M.Mus (Performing Arts), is my own work and that it has not previously been submitted for assessment or completion of any postgraduate qualification to another University or for another qualification. -

Ebbene Sì, Ancora Rigoletto! Quando Mariani Prese La Bacchetta
n. 125 - dicembre 2017 PERIODICO DI INFORMAZIONE MUSICALE DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEL CARLO FELICE E DEL CONSERVATORIO N. PAGANINI Autorizzazione del Tribunale di Genova del 22/1/92 Quando Mariani Ebbene sì, prese la bacchetta... ancora Rigoletto! opo l’exploit di “We - sottolineate due novità impor - ome, ancora Rigoletto?”, mugugnerà qualcuno … Ragio - st side story”, splen - tanti che il Carlo Felice propose ni di cassetta, si dirà. La presenza di Traviata in cartello - D dida esperienza da quella sera. Proprio alla prima “C ne (mag - ripetere, il Carlo Felice torna al dell’opera verdiana, infatti, fu gio 2018) sembre - teatro tradizionale con “Rigo - inaugurata l’illuminazione a gas rebbe poi confermare letto”. Qui accanto e nella pa - del Teatro del Barabino. una simile ipotesi. In R— igoligoletetto gina successiva Aureliano Zat - L’altra novità riguarda il podio. realtà un teatro che Giuseppe VVerdierderdi toni si sofferma sulla celebre Scrisse ”La Maga”: “Faremo riproponga i capisaldi opere verdiana. Qui vogliamo pure i nostri complimenti al Si - del repertorio è sem - solo proporre una riflessione gnor Mariani Direttore dell’Or - pre il benvenuto, a storica. chestra per la sua solita bravu - patto che non si ri - Direttore d’orchestra Francesco Ivan Ciampa 6, 9, 10, 12 Era il 26 dicembre ra nel dirigerla, nunci a nuove produ - Dorian Wilson 22, 23, 2777,, 29 Regia RolandoRolando Panerai Regista assistente 1852 quando il Carlo ma avremmo pre - zioni o ad esperienze Vivien Hewitt Scene NuovoNuovo Allestimento Teatro Carlo Felice ferito di vederlo teatrali poco esplora - dada un’idea di Rolando Panerai Felice ospitò per la Costumi ReginaRegina Schreckere Luci dirigere col suo Luciano Novelli prima volta “Rigolet - te, anche se meno Orchestra e Coro TTeatroeeatroatro Carlo Felice Maestro del Coro to”. -

Unmistakably French
Unmistakably French Offenbach's The Tales of Hoffmann, reviewed by GIUSEPPE PENNISI In Jacques Offenbach's Les contes d'Hoffmann, the protagonist (a poet and a would-be womanizer, but with very little luck) tells his love stories to a group of drinking buddies while awaiting his latest conquest, the singer Stella with a lead role in Mozart's Don Giovanni in the nearby theatre. The stories he tells are more bitter than sweet; in each act, he unsuccessfully courts a different woman. When Don Giovanni is over and Stella arrives, the fellow is totally drunk. Of course, she goes out to dinner (and what not) with some other chap. Some time ago, I reviewed the English National Opera / Munich National Theater joint production (Innovative Dramaturgy, 6 August 2012). Last year, a new production began touring small provincial theatres such as those of Pisa, Livorno, Lucca and Novara (Unlucky in Love, 13 February 2014). This season, two additional productions are touring Italy and France. The first started its travels in Rouen. After a stop at the Royal Theatre of Versailles, it is visiting Pavia, Como, Jesi, Cremona and Brescia, for more than thirty performances. The second will debut in Piacenza in January 2015, and after stops in Modena and Reggio Emilia, will reach Toulon and other French cities. There are major economic advantages no doubt in terms of sharing costs and having a larger number of performances. In this specific case, there is an additional bonus; whilst the Munich staging was quite British and many productions seen in Italy had an Italian flavor, the performance I saw in Jesi on 29 November 2014 was unmistakably French. -

Le Vie Dell'amicizia 1997
Le vie dell’amicizia 1997 - 2019 1997 SARAJEVO Centro Skenderija 1998 BEIRUT Forum di Beirut 1999 GERUSALEMME Piscina del sultano 2000 MOSCA Teatro Bolshoi 2001 EREVAN - ISTANBUL Palazzo dell’Arte e dello Sport - Convention & Exhibition Centre 2002 NEW YORK Ground Zero - Avery Fisher Hall (Lincoln Center) 2003 IL CAIRO Ai piedi delle Piramidi 2004 DAMASCO Teatro Romano di Bosra 2005 EL DJEM Teatro Romano di El Djem 2006 MEKNÈS Piazza Lahdim 2007 CONCERTO PER IL LIBANO Roma, Palazzo del Quirinale 2008 MAZARA DEL VALLO Arena del Mediterraneo 2009 SARAJEVO Olympic Hall Zetra 2010 ITALIA-SLOVENIA-CROAZIA Piazza Unità d’Italia, Trieste 2011 NAIROBI Uhuru Park 2012 CONCERTO DELLE FRATERNITÀ Pala De Andrè, Ravenna 2013 CONCERTO PER LE ZONE TERREMOTATE DELL’EMILIA Piazza della Costituente, Mirandola 2014 REDIPUGLIA Sacrario Militare, Fogliano di Redipuglia 2015 OTRANTO Cattedrale di Otranto 2016 TOKYO Teatro Bunka Kaikan - Metropolitan Theatre 2017 TEHRAN Vahdat Hall 2018 KIEV Piazza Sofiyska 2019 ATENE Odeon di Erode Attico Pellegrinaggi laici, che toccano città ferite; che riallacciano antichi legami con luoghi che hanno fatto la storia; che costruiscono ‘ponti di fratellanza’. Ravenna Festival ha chiamato questi momenti ‘Vie dell’Amicizia’ e, dal 1997, continua a tracciarne ogni anno di nuove. Sono lo spirito profondo della manifestazione, il culmine del suo progetto culturale, la sintesi più alta. A guidare questi viaggi, ambasciatore di cultura nel mondo, è da sempre Riccardo Muti, sul podio di orchestre e cori come il Teatro Alla Scala, Il Maggio Musicale Fiorentino, la Cherubini e la Giovanile Italiana oppure formatesi per l’occasione, come avvenne nel 2002 per il concerto a New York con i ‘Musicians of Europe United’. -

Staged Treasures
Italian opera. Staged treasures. Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini and Gioacchino Rossini © HNH International Ltd CATALOGUE # COMPOSER TITLE FEATURED ARTISTS FORMAT UPC Naxos Itxaro Mentxaka, Sondra Radvanovsky, Silvia Vázquez, Soprano / 2.110270 Arturo Chacon-Cruz, Plácido Domingo, Tenor / Roberto Accurso, DVD ALFANO, Franco Carmelo Corrado Caruso, Rodney Gilfry, Baritone / Juan Jose 7 47313 52705 2 Cyrano de Bergerac (1875–1954) Navarro Bass-baritone / Javier Franco, Nahuel di Pierro, Miguel Sola, Bass / Valencia Regional Government Choir / NBD0005 Valencian Community Orchestra / Patrick Fournillier Blu-ray 7 30099 00056 7 Silvia Dalla Benetta, Soprano / Maxim Mironov, Gheorghe Vlad, Tenor / Luca Dall’Amico, Zong Shi, Bass / Vittorio Prato, Baritone / 8.660417-18 Bianca e Gernando 2 Discs Marina Viotti, Mar Campo, Mezzo-soprano / Poznan Camerata Bach 7 30099 04177 5 Choir / Virtuosi Brunensis / Antonino Fogliani 8.550605 Favourite Soprano Arias Luba Orgonášová, Soprano / Slovak RSO / Will Humburg Disc 0 730099 560528 Maria Callas, Rina Cavallari, Gina Cigna, Rosa Ponselle, Soprano / Irene Minghini-Cattaneo, Ebe Stignani, Mezzo-soprano / Marion Telva, Contralto / Giovanni Breviario, Paolo Caroli, Mario Filippeschi, Francesco Merli, Tenor / Tancredi Pasero, 8.110325-27 Norma [3 Discs] 3 Discs Ezio Pinza, Nicola Rossi-Lemeni, Bass / Italian Broadcasting Authority Chorus and Orchestra, Turin / Milan La Scala Chorus and 0 636943 132524 Orchestra / New York Metropolitan Opera Chorus and Orchestra / BELLINI, Vincenzo Vittorio -

Alvise Casellati Is Considered One of the Emerging Talents of the Latest Years in Addition to Being an Innovator and Manager. H
Alvise Casellati is considered one of the emerging talents of the latest years in addition to being an innovator and manager. He is creator and Music Director of Opera Italiana is in the Air (www.operaitalianaisintheair.com – as of November 2016), European and International trademark since September 2019, an event with the aim of promoting knowledge and appreciation of Italian Opera through a free open air event that saw its debut in Central Park, New York in July 2017, attended by thousands of people, broadcast by TVs, local radios (NY1, NBC TV, WNYC radio) and RAI TV (Rainews, TG1 and TG2), advertised through an important media and social campaign (220 million impressions, broadcast/online 112 million, listings 107 million are the data of the 2019 New York campaign). The fundraising activity involves American and Italian partners: Intesa Sanpaolo bank, ENI, Brooks Brothers, San Benedetto Water, Foundation for Italian Art & Culture, ACP Group, Bracco, MSC, etc. Through a collaboration with the Sloan Kettering Memorial Cancer Hospital of New York, children and adults who are part of the Music Therapy program will participate with the aim of future involvement of unprivileged social categories. Through a collaboration with New York Philharmonic, Young Composers Program, the event opens with a short composition of a young composer (age 11/12). Due to Covid-19, the following 2020 performances have been postponed: April 3rd in Bayfront Park Miami, May 29th in Villa Borghese Park, Rome, June 15th in Millennium Park, Chicago, June 28th in Central Park, New York, July in Hyde Park, London. The most recent performances include the concert in Regatta Park, Miami, on April 13, 2019, in Central Park, New York, on July 1, 2019 and last October 4, 2019 in Galleria Umberto I in Naples, Italy, with Teatro di San Carlo, Accademia del Teatro alla Scala singers and Conservatory of Benevento. -

Ci Muove La Passione
Ci muove la Passione l Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno contribuire così alla straordinaria programmazione conferma, con il programma della stagione artistica della Regione Campania che nella lirica e 2017, le sue caratteristiche d’eccellenza nella nella musica classica investe ingenti risorse. Iselezione dei titoli, nella scelta dei protagonisti, I cartelloni del Teatro di San Carlo e del Teatro nell’offerta variegata di spettacoli in grado di “Giuseppe Verdi”, i grandi eventi come Un’Estate assecondare i gusti molteplici. da Re alla Reggia di Caserta e la Lirica nell’Arena Tanto gli appassionati del belcanto quanto coloro Flegrea di Napoli, grazie al loro valore artistico, che si avvicinano a questa straordinaria forma di diventano anche un enorme attrattore culturale spettacolo potranno trovare ampia soddisfazione e turistico per la nostra terra contribuendo a in un cartellone che propone grandi concerti ed diffonderne un’immagine mirabile nel mondo con opere di repertorio, illustri regie, strepitosi interpreti importanti benefici economici ed occupazionali per internazionali. l’intera economia campana e nazionale. La direzione artistica del Maestro Daniel Oren è Una sinergia operativa e culturale che consente uno straordinario valore aggiunto. Il suo prestigio anche di ampliare ed esportare le produzioni in Italia internazionale e la sua trascinante passione e nel Mondo. consentono al Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” A tutti i protagonisti impegnati nella stagione di Salerno d’inserirsi a pieno titolo nel novero dei l’auspicio più caloroso di grandi successi ed al principali teatri d’opera d’Italia e d’Europa e di pubblico un benvenuti all’opera e buon divertimento. Vincenzo De Luca Presidente Regione Campania resentiamo con orgoglio il cartellone della che la mission del Teatro Municipale “Giuseppe stagione lirica e di concerti 2017 del Verdi” sia quella di essere punta di diamante Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di e modello ispiratore di una programmazione PSalerno. -

48 Stagione Lirica Di Tradizione
JESI / TEATRO G.B. PERGOLESI 48a STAGIONE LIRICA DI TRADIZIONE ottobre - dicembre 2015 dedicata a Mario Del Monaco nel centenario della nascita MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE / ORE 16* MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE / ORE 16* MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE / ORE 16* VENERDÌ 16 OTTOBRE / ORE 20.30 VENERDÌ 13 NOVEMBRE / ORE 20.30 VENERDÌ 11 DICEMBRE / ORE 20.30 DOMENICA 18 OTTOBRE / ORE 16 DOMENICA 15 NOVEMBRE / ORE 16 DOMENICA 13 DICEMBRE / ORE 16 NABUCCO DON PASQUALE LA VEDOVA ALLEGRA di Giuseppe Verdi di Gaetano Donizetti di Franz Lehár Dramma lirico in quattro parti Dramma buffo in tre atti Operetta in tre parti Libretto di Temistocle Solera Libretto di Giovanni Ruffini Libretto di Victor Léon e Leo Stein interpreti Carlos Almaguer, Maria Billeri, interpreti Paolo Bordogna, Pablo Garcia interpreti Valeria Esposito, Alessandro Ramaz Chikviladze, Elisa Barbero, Ruiz, Maria Mudryak, Pietro Adaìni, Safina, Francesca Tassinari, Christian Collia, Armando Ariostini, Gennaro Cannavacciuolo, Leonardo Gramegna, Paolo Battaglia, Claudio Grasso Enrico Giovagnoli, Alex Martini Roberto Carli, Alice Molinari direttore Giuseppe La Malfa direttore Antonio Pirolli direttore Aldo Sisillo regia Andrea Cigni regia Vittorio Sgarbi Stefano Monti scene e costumi Lorenzo Cutuli regia e scene regista assistente Cinzia Gangarella Vincenzo Balena elementi scenici dello scultore FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana coreografie Cinzia Scuppa costumi Massimo Carlotto Coro Lirico Marchigiano “V. Bellini” FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana Orchestra dell’Opera Italiana maestro del coro, Carlo Morganti Coro Lirico Marchigiano “V. Bellini” Coro Lirico Marchigiano V. Bellini maestro del coro, Carlo Morganti coproduzione Fondazione Pergolesi Spontini, Carlo Morganti maestro del coro Teatro “G. Donizetti” di Bergamo, Teatro produzione Fondazione Pergolesi Spontini coproduzione Teatro Comunale Sociale di Como, Teatro “A.