Una 500 a Zonzo Tra I Ricordi
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
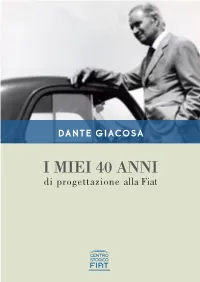
I MIEI 40 ANNI Di Progettazione Alla Fiat I Miei 40 Anni Di Progettazione Alla Fiat DANTE GIACOSA
DANTE GIACOSA I MIEI 40 ANNI di progettazione alla Fiat I miei 40 anni di progettazione alla Fiat DANTE GIACOSA I MIEI 40 ANNI di progettazione alla Fiat Editing e apparati a cura di: Angelo Tito Anselmi Progettazione grafica e impaginazione: Fregi e Majuscole, Torino Due precedenti edizioni di questo volume, I miei 40 anni di progettazione alla Fiat e Progetti alla Fiat prima del computer, sono state pubblicate da Automobilia rispettivamente nel 1979 e nel 1988. Per volere della signora Mariella Zanon di Valgiurata, figlia di Dante Giacosa, questa pubblicazione ricalca fedelmente la prima edizione del 1979, anche per quanto riguarda le biografie dei protagonisti di questa storia (in cui l’unico aggiornamento è quello fornito tra parentesi quadre con la data della scomparsa laddove avve- nuta dopo il 1979). © Mariella Giacosa Zanon di Valgiurata, 1979 Ristampato nell’anno 2014 a cura di Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. Logo di prima copertina: courtesy di Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. … ”Noi siamo ciò di cui ci inebriamo” dice Jerry Rubin in Do it! “In ogni caso nulla ci fa più felici che parlare di noi stessi, in bene o in male. La nostra esperienza, la nostra memoria è divenuta fonte di estasi. Ed eccomi qua, io pure” Saul Bellow, Gerusalemme andata e ritorno Desidero esprimere la mia gratitudine alle persone che mi hanno incoraggiato a scrivere questo libro della mia vita di lavoro e a quelle che con il loro aiuto ne hanno reso possibile la pubblicazione. Per la sua previdente iniziativa di prender nota di incontri e fatti significativi e conservare documenti, Wanda Vigliano Mundula che mi fu vicina come segretaria dal 1946 al 1975. -

Teatro Nazionale Di Genova
teatronazionalegenova.it Teatro Ivo Chiesa Teatro Eleonora Duse Teatro Gustavo Modena Sala Mercato Ivo Chiesa cento anni Ivo teatronazionalegenova.it Teatro Ivo Chiesa Teatro Eleonora Duse Teatro Gustavo Modena Sala Mercato Ivo Chiesa cento anni Ivo teatronazionalegenova.it Teatro Ivo Chiesa Teatro Eleonora Duse Teatro Gustavo Modena Sala Mercato “… vi scrivo all’alba di questo giorno e all’inizio di questa stagione teatrale e vi aspetto perché insieme rendiamo la nostra società civile...” Stagione 20.21 ph. Eugenio Pini Ivo Chiesa cento anni Ivo Care spettatrici e cari spettatori, con grande gioia vi scrivo all’alba di una nuova stagione teatrale, la mia In questi primi mesi gli spettatori potranno seguirci in un’ampia rifles- prima da direttore del Teatro Nazionale di Genova. Una stagione che au- sione sulla tragedia classica per raccontare la nostra contemporaneità con spichiamo possa alimentare il senso di comunità che un’istituzione così “Elena” di Euripide, da me diretto, con protagonista Laura Marinoni, spet- fondante per la città ha la responsabilità di creare e rinvigorire. tacolo dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa che ha battu- Desidero ringraziare tutti gli spettatori che hanno rinunciato al rimborso to ogni record di incassi. Rimane costante anche l’interesse per la dram- di biglietti e abbonamenti, dimostrando una volta di più il legame profon- maturgia contemporanea, come dimostrano le altre nostre produzioni: la do che questo Teatro ha col proprio pubblico. mia regia di “Grounded” di George Brant con Linda Gennari e “Tintarella di luna” diretto da Giorgio Gallione. Inoltre abbiamo inserito nel cartel- Non vi parlerò del momento difficile che viviamo, ogni giorno, insieme. -

Cutty Sark “564” ***
Cutty Sark “564” *** BUILDING INSTRUCTION This model is Copyright protected. All Copyrights to the designs of this version of the Cutty Sark belongs to Billing Boats Denmark Aps www.billingboats.com 040119 CUTTY SARK, 1869 Masterne anbringes i skroget som vist på hovedtegningen med den korrekte hældningsgrad. De Det mest berømte af klipperskibene, Cutty Sark, Nu tilpasses mellemstykkerne. De skal glide nemt på fastgøres med det stående gods (stag, vanter etc. af ligger idag bevaret for efterverdenen i en tørdok i plads. Derefter limes de fast. rigningstråd). Denne del af rigningen er nummereret Greenwich. Det blev bygget til at fragte fra Kina og og kendetegnet med et ”R”, så De kan se, hvor hver var konstrueret af Hercules Linton med det formål Mellemlisterne afkortes på længde (se tegning) og enkelt del fastgøres på skroget. at slå Termopylae, der mentes at være den tids limes i hakket ved spant og bjælkebugt. hurtigste skib, begge skibe havde stort set samme hoveddimensioner: længde 64,7m, bredde 11m og Tegningen viser, hvor mange spanter listerne skal dybde 6,4m, Cutty Sark havde en nettotonnage på spænde over. Fig. 12-14 921 tons mod Termopylaes 948 tons. Da det grundet Hakkene i dækket tilpasses. mange århundreders skibsbyggeri var vanskeligt at Montering af ræer. Disse anbringes på masterne som vist på plan 1. få godt egetræ i England, og da man desuden havde Delene sammenlimes som vist på tegningen. lagt mærke til, at egespanterne tog for meget af Hvis modellen skal have sejl, er det bedst, at montere det dyrebare lastrum, var det blevet moderne med sejlene på ræerne nu. -

Why Conserve the Cutty Sark? Transcript
Why conserve the Cutty Sark? Transcript Date: Monday, 17 October 2011 - 1:00PM Location: Museum of London 17 October 2011 Why Conserve the Cutty Sark? Richard Doughty Good afternoon. My name is Richard Doughty, and I am the Chief Executive of The Cutty Sark Trust. Gresham College have invited me here today to address the question: Why Conserve the Cutty Sark? One of the main advantages of talking about Cutty Sark is being able to say, without sparing anybody’s blushes, this is a ship which needs no introduction. Captain Moodie, her first captain, claimed she would ‘last forever’. So far he seems to have been proved right. Although she was built to have a working life of just thirty years, she is still with us 143 years on – nearly fivefold her original life expectancy. Famously Cutty Sark survived the fire in May 2007 which stretched from stem to stern, and reached temperatures in excess of 1000oc. If there was anything positive that came out that day, it was that this was not just a local story, not even a national story, but an international story.The four corners of the earth were shocked at what they saw and heard on worldwide broadcasts. I have always maintained Cutty Sark – the greyhound of the sea – is the best known historical vessel and for me that day proved it beyond the shadow of a doubt. In the week of the fire Cutty Sark received no less than six solid hours of mainstream television and radio coverage in the UK alone.But before I go any further I thought I should pause briefly and qualify my claim that Cutty Sark is the most famous ship in the world. -

Being a Beautiful Scotland Judge.Pdf
Adrian Miles Judging for Beautiful Scotland Good afternoon everyone Thank you for your words of introduction It was my privilege to visit Inverbervie on our Judge’s tour at the end of July as one of nine communities represented in this year’s ‘Large Village’ category. So in a couple of minutes I’ll be telling you about my visit there from a Judge’s perspective. The slides I show will give you just a tiny sample of what we saw and noted. But first - It’s been interesting for me to consider how we, as judges, are viewed as the great day approaches. 1 The Judges are coming! And this is courtesy of Coupar Angus Pride of Place We already have a good idea of what to expect on a visit, as each group provides a portfolio, and this is a great way to evidence your activities during the rest of the year. We also look at any social media sites the groups have to assess how well news and activities are communicated And I have a couple of examples from Bloom group sites, giving you an idea of the group’s rallying cries for last minute preparations. 2 “One of our final jobs is cleaning the bus stop at the top of The Avenue along with the one outside the Post Office and we need your help! We need a couple of folk willing to give them a clean for us” “One of our final jobs is cleaning the bus stop at the top of The Avenue along with the one outside the Post Office and we need your help! We need a couple of folk willing to give them a clean for us”. -

Tesi Chiara Bonaventura
CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by Padua@thesis UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente Tesi di laurea in Scienze e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione “Caffè, balsamo del cuore e dello spirito” Storia, cultura e scienza della bevanda più famosa al mondo Relatore: Prof. Danilo Gasparini Laureanda: Chiara Bonaventura Matricola n. 1000905 ANNO ACCADEMICO 2013-2014 La citazione del titolo è stata ripresa dalla citazione di Giuseppe Verdi (1813-1901). 2 Alla mia splendida Famiglia 3 INDICE Indice ………………………………………………………………………...………………4 Riassunto ……………………………………………………………………..……………6 Abstract ……………………………………………………………………..…………...…7 Introduzione ……………………………………………………………….……………...8 1. LE ORIGINI DEL CAFFÈ …………………..…………………………………10 2. DIFFUSIONE NEI NUOVI MONDI ……………………..…………….….…16 2.1 La scoperta portoghese …………………………….……………………16 2.2 Il regno olandese ……………………………………………………..……18 2.3 Supremazia francese ………………………………………………..……21 2.4 Gli intraprendenti portoghesi ………………………………..…..………25 2.5 Suolo, clima, condizione operaia ……………………………..……….26 2.6 Il prezzo ecologico ………………………………………….……...………27 2.7 Verso la libertà ……………………………………………..…………….…30 2.8 Il prezzo umano ………………………………………………………….…33 2.9 Forme alternative di mercato ……………………………..……….……33 2.10 Una singolare penitenza – Colombia …………………..…..………35 2.11 Centro America ……………………………………………….……..……35 2.12 Sfruttamento degli Indios …………………………….………..……….36 3. I CAFFÈ……………………………………………………………………………39 3.1 Vino -

Dags Att Se Över Lancia Integrale-Bilarna Inför Den Kommande Racingsäsongen Tycker Tor
Dags att se över Lancia Integrale-bilarna inför den kommande racingsäsongen tycker Tor. Och från rallyns hemtrakter i Värmland kom Kjell till Lanciagaraget för att hämta delar till Lancia Fulvia Coupén för Midnattssolsrallyt 2014. LANCIA FULVIA 50 år 2013. Söndagen den 28 juli var 130 personer med olika Fulviamodeller samlade i italienska Fobello för 50-årsfirandet. Fulvian som deltog i rallyt Peking-Paris, den öppna modellen F&M Special, var på plats – och klubbmästare Per med. Innehåll i detta nummer bl.a. : Sid. 3, Klubbpresentation Sid. 4-8 Ordföranden reste till Padova Sid. 9-12 Salutorg och kommande träffar Sid. 13 Pers arbetsresa till Fobello i april Sid. 14 Anna-Lena & Per i Valsesia 14-24 aug. Sid. 15-20 Schweiz 40 årsjubiléum 6-8 sept. Sid. 21-23 LCÖ, Saltzburg 12-15 sept. Sid. 24-27 Bilutställning Gran Turismo, Nacka, nov. Sid. 28-32 Hector Carcias studentresa 2012 Sid. 33-34 Hänt i garaget Sid. 35 Autoexperten + Pers Saffransskorpor SVENSKA LANCIAKLUBBEN Syfte Klubbens syfte är att samla intresserade Lanciaägare och personer med genuint intresse av dessa bilar för att under trivsamma former: • Öka medlemmarnas insikt i allt som berör Lanciabilarnas teknik, egenskaper, skötsel och historia samt bistå vid problem. • Informera om och ventilera andra frågor som berör veteranbilshobbyn samt relaterade produkter och teknologi. • På bästa sätt bevaka reservdelsfrågan. Styrelse Lars Filipsson. suppleant Herbert Nilsson. Ordförande o Heders- Grahamsvägen 5, 174 46 Sundbyberg president / ansvarig utgivare La Lancia. Tel. 08-6282443 Jacob Ulfssons väg 7A, 647 32 Mariefred E-mail [email protected] Tel. 0159-108 42 Mob. 070-910 94 05 E-mail [email protected] Lanciamodeller Kontaktpersoner Magnus Nilsson. -

Eccellenze Meccaniche Italiane
ECCELLENZE MECCANICHE ITALIANE. MASERATI. Fondatori. Storia passata, presente. Uomini della Maserati dopo i Maserati. Auto del gruppo. Piloti. Carrozzieri. Modellini Storia della MASERATI. 0 – 0. FONDATORI : fratelli MASERATI. ALFIERI MASERATI : pilota automobilistico ed imprenditore italiano, fondatore della casa automobilistica MASERATI. Nasce a Voghera il 23/09/1887, è il quarto di sette fratelli, il primo Carlo trasmette la la passione per la meccanica ALFIERI, all'età di 12 anni già lavorava in una fabbrica di biciclette, nel 1902 riesce a farsi assumere a Milano dalla ISOTTA FRASCHINI, grazie all'aiuto del fratello Carlo. Alfieri grazie alle sue capacità fa carriera e alle mansioni più umili, riesce ad arrivare fino al reparto corse dell'azienda per poi assistere meccanicamente alla maccina vincente della Targa FLORIO del 1908, la ISOTTA lo manda come tecnico nella filiale argentina di Buenos Aires, poi spostarlo a Londra, e in Francia, infine nel 1914 decide, affiancato dai suoi fratelli. Ettore ed Ernesto, di fondare la MASERAT ALFIERI OFFICINE, pur rimanendo legato al marchio ISOTTA-FRASCHINI, di cui ne cura le vetture da competizione in seguito cura anche i propulsori DIATTO. Intanto però, in Italia scoppia la guerra e la sua attività viene bloccata. Alfieri Maserati, in questo periodo, progetta una candela di accensione per motori, con la quale nasce a Milano la Fabbrica CANDELE MASERATI infine progetta un prototipo con base telaio ISOTTA- FRASCHINI, ottenendo numerose vittorie, seguirà la collaborazione con la DIATTO, infine tra il 1925/26, mesce la mitica MASERATI TIPO 26, rivelandosi poi, un'automobile vincente. Il 1929 sarà l'anno della creazione di una 2 vettura la V43000, con oltre 300 CV, la quale raggiungerà i 246 Km/ h, oltre ad altre mitiche vittorie automobilistiche. -

Grace Notes Newsletter of the Memphis Scottish Society, Inc
GRACE NOTES Newsletter of the Memphis Scottish Society, Inc. Vol. 36 No. 9 • September 2020 President’s Letter The pandemic curse of 2020 is still with us. Mary Ann is plan- ning on “Short Subjects” for the next meeting with several 5-10 minute presentations for the September Zoom meeting. Remember that the annual dues are due, $25 for family and $20 for an individual. Please mail them directly to the treasurer, Deb- bie Sellmansberger, at 14670 Hwy 193, Williston, TN 38076. You Memphis can also renew through the memphisscots.com website. Click on Scottish the large “+” in the top right corner and the rightmost box is for Join/Renew. The number of renewals will indicate whether the Society, Inc. Memphis Scottish Society survives COVID-19. Board There is the issue of officers elections coming up. Four of the current board members will be term limited out of office for next President year. Normally there is the nomination and election by the mem- John Schultz bership of one of the three members of the nominating commit- 901-754-2419 tee. I would like to have someone volunteer for that position to be [email protected] “elected” at the October meeting. The other members are some- one I, as president, appoint and the past president. With Melissa’s Vice President passing, as the president before her, I will be the third member. Mary Ann Lucas 901-725-1879 John Schultz [email protected] Treasurer Debbie Sellmansberger 901-465-4739 [email protected] Secretary Sammy Rich 901-496-2193 [email protected] Members at Large Shari Moore 901-598-1802 [email protected] Kathy Schultz 901-754-2419 [email protected] September Meeting Program: Holly Staggs presented by Mary Ann Lucas via Zoom 901-215-4839 [email protected] “Scottish Short Subjects” See page 2 for further information Tennessee Tartan. -

Country-Of-Origin Effect on Coffee Purchase by Italian Consumers
UNIVERSITY OF LJUBLJANA FACULTY OF ECONOMICS MASTER’S THESIS COUNTRY-OF-ORIGIN EFFECT ON COFFEE PURCHASE BY ITALIAN CONSUMERS Ljubljana, March 2016 COK ALENKA AUTHORSHIP STATEMENT The undersigned Alenka COK, a student at the University of Ljubljana, Faculty of Economics, (hereafter: FELU), declare that I am the author of the master’s thesis entitled CONSUMER BEHAVIOUR IN THE ITALIAN COFFEE MARKET: COO EFFECT ON CONSUMER PURCHASE INTENTIONS, written under supervision of full professor Tanja Dmitrović, PhD. In accordance with the Copyright and Related Rights Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, Nr. 21/1995 with changes and amendments) I allow the text of my master’s thesis to be published on the FELU website. I further declare that: the text of my master’s thesis to be based on the results of my own research; the text of my master’s thesis to be language-edited and technically in adherence with the FELU’s Technical Guidelines for Written Works which means that I o cited and / or quoted works and opinions of other authors in my master’s thesis in accordance with the FELU’s Technical Guidelines for Written Works and o obtained (and referred to in my master’s thesis) all the necessary permits to use the works of other authors which are entirely (in written or graphical form) used in my text; to be aware of the fact that plagiarism (in written or graphical form) is a criminal offence and can be prosecuted in accordance with the Criminal Code (Official Gazette of the Republic of Slovenia, Nr. -

LANCIA Storie Di Innovazione Tecnologica Nelle Automobili Storie Di Innovazione Tecnologica Nelle Automobili
LORENZO MORELLO LANCIA Storie di innovazione tecnologica nelle automobili Storie di innovazione tecnologica nelle automobili LORENZO Morello LANCIA Storie di innovazione tecnologica nelle automobili Editing, progettazione grafica e impaginazione: Fregi e Majuscole, Torino © 2014 Lorenzo Morello Stampato nell’anno 2014 a cura di Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. Logo di prima copertina: courtesy di Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. PRESENTAZIONE volontari del progetto STAF (Storia della Tecnologia delle Automobili FIAT), istituito nel 2009 al fine di selezionare i disegni tecnici più rilevanti per documentare l’e- I voluzione tecnica delle automobili FIAT, sono venuti a contatto anche con i disegni Lancia, contenuti in una sezione dedicata dell’Archivio Storico FIAT: il materiale vi era stato trasferito quando, nel 1984, la Direzione tecnica di FIAT Auto, il settore aziendale incaricato di progettare le automobili dei marchi FIAT, Lancia e Autobianchi, era stata riunita in un unico fabbricato, all’interno del comprensorio di Mirafiori. Fu nell’oc- casione del ritrovamento di questo nucleo di disegni che i partecipanti al progetto si proposero di applicare il metodo impiegato nel predisporre il materiale raccolto nel libro FIAT, storie di innovazione tecnologica nelle automobili, anche per preparare un libro analogo dedicato alle automobili Lancia. Questo secondo libro, attraverso l’esame dei disegni tecnici, del materiale d’archivio e delle fotografie di automobili sopravvissute, illustra l’evoluzione delle vetture Lancia e i loro contenuti innovativi, spesso caratterizzati da elementi di assoluta originalità. Il reperimento del materiale si è mostrato, tuttavia, più arduo rispetto al lavoro sulle vetture FIAT, almeno per le automobili più anziane, poiché l’archivio dei disegni Lancia era organizzato senza impiegare una struttura logica di supporto, per distinguere agevolmente i diversi gruppi funzionali dai particolari di puro dettaglio. -

Paine, Ships of the World Bibliography
Bibliography The bibliography includes publication data for every work cited in the source notes of the articles. It should be noted that while there are more than a thousand titles listed, this bibliography can by no means be considered exhaustive. Taken together, the literature on the Titanic, Bounty, and Columbus’s Niña, Pinta, and Santa María comprises hundreds of books and articles. Even a comprehensive listing of nautical bibliographies is impossible here, though four have been especially helpful in researching this book: Bridges, R.C., and P. E. H. Hair. Compassing the Vaste Globe of the Earth: Studies in the History of the Hakluyt Society 1846–1896. London: Hakluyt Society, 1996. Includes a list of the more than 300 titles that have appeared under the society’s imprint. Labaree, Benjamin W. A Supplement (1971–1986) to Robert G. Albion’s Naval & Maritime History: An Annotated Bibliography. 4th edition. Mystic, Conn.: Mystic Seaport Museum, 1988. Law, Derek G. The Royal Navy in World War Two: An Annotated bibliography. London: Greenhill Books, 1988. National Maritime Museum (Greenwich, England). Catalogue of the Library, Vol. 1, Voyages and Travel. London: Her Majesty’s Stationery Office, 1968. There are many interesting avenues of research in maritime history on the Internet. Two have been particularly useful: Maritime History Virtual Archives, owned and administered by Lar Bruzelius. URL: http://pc-78– 120.udac.se:8001/WWW/Nautica/Nautica.html Rail, Sea and Air InfoPages and FAQ Archive (Military and TC FAQs), owned and administered by Andrew Toppan. URL: http://www.membrane.com/~elmer/ mirror: http://www.announce.com/~elmer/.