ANNO XVI – N. 62 – Settembre 2012 Direttore Dott
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

{PDF EPUB} Five Lost Classics Tao Huang-Lao and Yin-Yang in Han China by Robin D.S
Read Ebook {PDF EPUB} Five Lost Classics Tao Huang-lao and Yin-yang in Han China by Robin D.S. Yates Learn - Explore | Bibliographical notes for the Ma Wang Dui texts. Mawang Dui 馬王堆 - the Horse King Mound - is an archaeological site located in Changsha, China. It is the site of three tombs belonging to the first Marquis of Dai, his wife, and a male who is believed to be their son. The site was excavated from 1972 to 1974. Most of the artifacts from Mawangdui are displayed at the Hunan Provincial Museum. This discovery was monumental, one of the most significant of the 20th century and has changed our view of the history of medicine and Daoism in China. The tomb contained various medical texts, including depictions of qigong (dao yin) exercises. For our purposes we will mainly focus on these philosophical and medical texts, but the tombs contained political and historical texts as well. the texts. These text were “written to advise ruling Han dynasty authorities on how to attune themselves to the cosmos at a time of rapidly changing political and social climate.” From the sleeve of Yates' Five Lost Classics : “In 1973, among the many unique documents discovered in the richly furnished tomb of a Han-dynasty aristocrat, were five books written on silk, primary texts of Huang-lao Daoism and Yin-yang philosophy that had been lost to mankind for more than 2,000 years. A discovery as important in China as the unearthing of the Dead Sea Scrolls was in the West, the Mawangdui texts created a sensation when they were first published, even leading to the foundation of a new religion on Taiwan… The recovery of the five lost classics sheds new light on a critical transitional period of Chinese political and intellectual history. -

Parte I €“ Dilema éTico Y Virtud
Virtud y consecuencia en la literatura histórica y filosófica pre-Han y Han: el dilema ético en la filosofía y sociedad china César Guarde Paz ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora. ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. -

An Ancient Mosque in Ningbo, China “Historical and Architectural Study”
JOURNAL OF ISLAMIC ARCHITECTURE P-ISSN: 2086-2636 E-ISSN: 2356-4644 Journal Home Page: http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/JIA AN ANCIENT MOSQUE IN NINGBO, CHINA “HISTORICAL AND ARCHITECTURAL STUDY” |Received December 13th 2016 | Accepted April 4th 2017| Available online June 15th 2017| | DOI http://dx.doi.org/10.18860/jia.v4i3.3851 | Hamada M. Hagras ABSTRACT Faculty of Archaeology, Fayoum University, Fayoum, Egypt With the rise of Tang dynasty (618–907), Ningbo was an important [email protected] commercial city on the Chinese eastern coast. Arab merchants had an important role in trade relations between China and the West. Ningbo mosque was initially built in 1003 during Northern Song period by Muslims traders who had migrated from Arab lands to settle in China. Through ongoing research of representative Muslim architecture, such as Chinese Mosques, this paper seeks to shed light on the artistic features of this mosque. Many of the key characteristics of this distinctive ethnic heritage are based on commonly held religious beliefs and on the relationship between culture and religion. This paper aims to study the characteristics of Chinese mosques architecture, through studying one of the most important planning patterns of the traditional courtyards plan Known as Siheyuan, and it will also make a practical study on Ningbo Yuehu Mosque. The result of this study shows that the Ningbo Yuehu mosque is like Chinese mosques which follows essentially the norms of Chinese planning, layout design, and wooden structures. KEYWORDS: Ningbo, Mosque, Plan, Courtyard, Inscriptions INTRODUCTION (626‐649) received an embassy from the last Sassanid rulers Yazdegerd III (631‐651) asking for help against WHY THE SELECTED NINGBO MOSQUE? the invading Arab armies of his country, however, the emperor avoid to help him to ward off problems that Although many Chinese cities contain more may result from it [8][9]. -

Buddhist Growth in China
Piya Tan SD 40b.1 How Buddhism Became Chinese How Buddhism Became Chinese 1 A reflection on the (Ahita) Thera Sutta (A 5.88) by Piya Tan ©2008 (2nd rev), 2009 (3rd rev) Even famous teachers can have wrong views and mislead others. (A 5.88) The (Ahitāya) Thera Sutta (A 5.88) is a vital warning that grounding in right view is imperative especially when we are presenting or representing the Buddha Dharma. The more people respect us, or listen to us, or turn to us for spiritual help, and the more we have the means of mass-propagating our Buddhist views, the more carefully we have to ascertain rightness and moral consequences of our efforts. The point is that status, learning, seniority, fame, wealth, and resources, advantageous as they may be in Buddhist work, are not sufficient standards for truth. While it is true that whatever we express are merely our own opinions, we must have the moral re- sponsibility at least to ensure that such opinions or facts reflect the true Dharma. Much as we have the freedom to publicize the teachings of a particular teacher or group, we must accept the fact that this may not be the only view of the true Dharma. The final test of what we propagate must be Dharma-based. The true teachings always stand above the teacher.1 After the Buddha‘s time, especially as Buddhism grows beyond India, such standards are not always possible, for various reasons. At first, Buddhism appears to change the culture, but in due course it is the culture that changes Buddhism, often turning it into a system vastly different, even contrary to the Dhar- ma of the Buddha. -

Uyghurs Is an Original and Significant Contribution to the Study of the Ethnic Relations Within the People’S Republic of China
bovin on “The Uyghurs is an original and significant contribution to the study of The ethnic relations within the People’s Republic of China. Very few foreign scholars have been able to study Xinjiang in such detail. Gardner Boving- G don’s thoughtful discussion and comprehensive coverage make this must d reading for anyone interested in contemporary China.” Peter C. Perdue,,Yale University, author of China Marches West: The Qing Conquest of Central Eurasia The UYGHURS P raiSe For Strangers in Their Own Land THe UYGHURS UYGHURS “The Uyghurs is an-depth case study of the failure of the Chinese gov- For more than half a century, ernment to integrate the Uyghurs, one of China’s fifty-six nationalities, many Uyghurs, members of a Mus- into the so-called great family of the nation. The book offers a unique (CONTINUED FROM FRONT FLAP) lim minority in northwestern China, perspective to understand the difficult and on-going process of Chinese have sought to achieve greater au- insight into the practices of nation nation-state building efforts. It is a must read for anyone who is interested tonomy or outright independence. building and nation challenging, in China’s nationality issues and the rise of ethnic nationalism in the post– Yet the Chinese government has not only in relation to Xinjiang but Cold War world.” consistently resisted these efforts, also in reference to other regions of SuiSheng Zhao, University of Denver, author of A Nation- countering with repression and a conflict. His work highlights the in- State by Construction: Dynamics of Modern Chinese Nationalism sophisticated strategy of state- fluence of international institutions sanctioned propaganda that em- on growing regional autonomy and “Gardner bovingdon brings to this project fluency in both Uyghur and phasizes interethnic harmony and underscores the role of representa- Chinese languages, a deep knowledge of Han and Uyghur society and the Chinese nationalism. -

Doctoral Thesis
MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH „1 DECEMBRIE 1918” UNIVERSITY IN ALBA IULIA FACULTY OF ORTHODOX THEOLOGY DOCTORAL SCHOOL OF THEOLOGY DOCTORAL THESIS The Religions of China (Confucianism, Daoism, Chan and Tibetan Mahayana Buddhism) and Christianity. A Historical Case Study for an Orthodox approach to the Theology of Religions and Comparative Theology: the „Empathic Exclusivism” Model ~ Summary ~ Scientific Coordinator: FR. AND UNIV. PROF. DR. EMIL JURCAN Author: ANDREI EMIL DIRLAU Alba Iulia 2016 Content PART I ARCHAIC CHINESE RELIGION: FROM MONOTHEISM TO DIFFUSED RELIGION INTRODUCTION: CONFUCIANISM – A DIFFUSED MONOTHEISM CHAPTER 1: THE ARCHAIC CHINESE MONOTHEISM. THE RICCI–LEGGE–GILES–CHRISTENSEN HERMENEUTICAL LINE 1.1. The archaic period 1.2. The books of the Chinese Classical Canon 1.3. The Religious Dimension of Confucianism 1.3.1. Confucianism is a religion, not merely an ethical-philosofical secular humanism 1.3.2. The religious paradigm of ancient China 1.4. The virtue of Legendary Sovereigns. Ideographic Epiphanies 1.5. Monotheism and the network of Rú-ist concepts 1.5.1. The fundamental religious concepts 1.5.1.1. Tian 1.5.1.2. Shang Di 1.5.1.3. Dao; Tian Dao 1.5.1.4. De 1.5.1.5. Tian Xia 1.5.2. Ren and the other Confucianist concepts 1.6. The descending dynamics of the fall from Dao: spiritual entropy and moral atrophy 1.7. After Babel 1.8. The last „good kings” and the first dynasties CHAPTER 2: RÚ-ISM AND A DISGUISED TEOCRACY 2.1. A periodization of the Confucianist schools 2.2. The Heaven’s Mandate 2.3. -

新成立/ 註冊及已更改名稱的公司名單list of Newly Incorporated
This is the text version of a report with Reference Number "RNC063" and entitled "List of Newly Incorporated /Registered Companies and Companies which have changed Names". The report was created on 01-02-2016 and covers a total of 2985 related records from 25-01-2016 to 31-01-2016. 這是報告編號為「RNC063」,名稱為「新成立 / 註冊及已更改名稱的公司名單」的純文字版報告。這份報告在 2016 年 2 月 1 日建立,包含從 2016 年 1 月 25 日到 2016 年 1 月 31 日到共 2985 個相關紀錄。 Each record in this report is presented in a single row with 6 data fields. Each data field is separated by a "Tab". The order of the 6 data fields are "Sequence Number", "Current Company Name in English", "Current Company Name in Chinese", "C.R. Number", "Date of Incorporation / Registration (D-M-Y)" and "Date of Change of Name (D-M-Y)". 每個紀錄會在報告內被設置成一行,每行細分為 6 個資料。 每個資料會被一個「Tab 符號」分開,6 個資料的次序為「順序編號」、「現用英文公司名稱」、「現用中文公司名稱」、「公司註冊編號」、「成立/註 冊日期(日-月-年)」、「更改名稱日期(日-月-年)」。 Below are the details of records in this report. 以下是這份報告的紀錄詳情。 1. 21Vianet Global Limited 2175966 26-01-2016 2. 3 Point Limited 三禾有限公司 2334566 25-01-2016 3. 33 Blanc Group Limited 2334707 25-01-2016 4. 3B Enterprises Limited 2335606 27-01-2016 5. 4iCreative Limited 2336607 29-01-2016 6. 5A INTERNATIONAL LIMITED 2335580 27-01-2016 7. 90 Day Korean Limited 2336804 29-01-2016 8. A & I Pharmacare Co., Limited 2336361 29-01-2016 9. A LEE Logistics Limited 阿里物流有限公司 2335622 27-01-2016 10. A Roentgen 3T Medical Imaging Limited 2335595 27-01-2016 11. -

Purpose and Variation in Religious Records of the Tang
tang religious records nathan woolley The Many Boats to Yangzhou: Purpose and Variation in Religious Records of the Tang n Tang China during the seventh century, the official Dou Dexuan I 竇德玄 (598–666) was once travelling on government business to Yangzhou when he met an otherworldly being who warned Dou of his impending death. Fortunately for Dou, this fate was avoided and he went on become one of the highest officials in the empire. Four texts agree on this core narrative but differ in their descrip- tions and details. The four texts — an item from an otherwise lost Dao- ist collection, a work describing the lineage of Shangqing Daoism, an anecdote attributed to a Buddhist collection of evidential miracles, and an entry in the compilation of a late-Tang Daoist master — display contrasting priorities in how they depict religious experience and prac- tice. They all date to within a period of around two centuries, but their interrelations remain unclear. The contrasts, however, provide a win- dow for examining the purposes that lay behind the creation of certain types of religious text, as well as contemporary perceptions of religious culture. Although not sharply divergent in terms of format, there are in fact differences among them that point to fundamental processes in the production of narrative and religious texts in China. Through the history of Chinese writing and texts, a single nar- rative may occur in different guises. It may simply be that a writer imbued an existing narrative with a changed focus and thereby pro- duced a different rendering. Alternatively, a tale could be updated to fit new social circumstances and expectations, or new developments in genre and performance. -
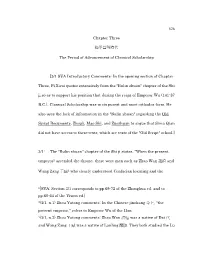
Chapter Three
526 Chapter Three 經學昌明時代 The Period of Advancement of Classical Scholarship [3/1 SVA Introductory Comments: In the opening section of Chapter Three, Pi Xirui quotes extensively from the "Rulin zhuan" chapter of the Shi ji so as to support his position that during the reign of Emperor Wu (141-87 B.C.), Classical Scholarship was in its purest and most orthodox form. He also uses the lack of information in the "Rulin zhuan" regarding the Old Script Documents, Zhouli, Mao Shi, and Zuozhuan to argue that Sima Qian did not have access to these texts, which are texts of the "Old Script" school.] 3/11 The "Rulin zhuan" chapter of the Shi ji states, "When the present emperor2 ascended the throne, there were men such as Zhao Wan 趙綰 and Wang Zang 王臧3 who clearly understood Confucian learning and the 1[SVA: Section 3/1 corresponds to pp.69-72 of the Zhonghua ed. and to pp.60-64 of the Yiwen ed.] 2(3/1, n.1) Zhou Yutong comments: In the Chinese jinshang 今上, "the present emperor," refers to Emperor Wu of the Han. 3(3/1, n.2) Zhou Yutong comments: Zhao Wan 趙綰 was a native of Dai 代 and Wang Zang 王臧 was a native of Lanling 蘭陵. They both studied the Lu 527 emperor himself was also inclined toward it.4 He thereupon issued an order recruiting scholar-officials in the recommendation categories of Straightforward and Upright, Worthy and Excellent, and Learned.5 After this, as for giving instruction in the Songs, in Lu it was Master Shen Pei 申 培公, in Qi it was Master Yuan Gu 轅固生, and in Yan, it was Grand Tutor Han Ying 韓(嬰)太傅. -

Resurgence of Indigenous Religion in China Fan Lizhu and Chen
Resurgence of Indigenous Religion in China Fan Lizhu and Chen Na1 Many scholars have observed in recent years that religion and spirituality are resurgent around the world. Contrary to the predictions of sociologists and others that modern society will eventually become completely secularized, it appears that human beings are engaged in a wide range of religious and/or spiritual experiences, disciplines, beliefs, practices, etc. that were virtually unimaginable two decades ago. In this chapter we seek to provide evidence that traditional (also known as primal, traditional, folk, indigenous, etc.) religions are also involved in this revitalization, not just Christianity, Islam, Buddhism, and other religions. We will focus on the People’s Republic of China as an extended case study of the widespread return to religion and spirituality around the world. Some of our discussion will be based on findings from our own research in China in both urban and rural areas. During the last thirty years many people in mainland China have rediscovered and revitalized their earlier religious and ritual practices. Kenneth Dean estimates that one to two million village temples have been rebuilt or restored across China, and ritual traditions long thought lost are now being re-invented and celebrated in many of these temples.1 This very rough figure of well over a million village temples does not include the tens of thousands of large-scale Buddhist monasteries and temples, Daoist monasteries and temples, Islamic mosques, and Christian churches (Catholic or Protestant) that have been rebuilt or restored over the past three decades. Recent anthropological 1 Fan Lizhu, Professor of Sociology, Fudan University. -

Selections from Mencius, Books I and II: Mencius's Travels Persuading
MENCIUS Translation, Commentary, and Notes Robert Eno May 2016 Version 1.0 © 2016 Robert Eno This online translation is made freely available for use in not for profit educational settings and for personal use. For other purposes, apart from fair use, copyright is not waived. Open access to this translation, without charge, is provided at: http://hdl.handle.net/2022/23423 Also available as open access translations of the Four Books The Analects of Confucius: An Online Teaching Translation http://hdl.handle.net/2022/23420 Mencius: An Online Teaching Translation http://hdl.handle.net/2022/23421 The Great Learning and The Doctrine of the Mean: An Online Teaching Translation http://hdl.handle.net/2022/23422 The Great Learning and The Doctrine of the Mean: Translation, Notes, and Commentary http://hdl.handle.net/2022/23424 Cover illustration Mengzi zhushu jiejing 孟子註疏解經, passage 2A.6, Ming period woodblock edition CONTENTS Prefatory Note …………………………………………………………………………. ii Introduction …………………………………………………………………………….. 1 TEXT Book 1A ………………………………………………………………………………… 17 Book 1B ………………………………………………………………………………… 29 Book 2A ………………………………………………………………………………… 41 Book 2B ………………………………………………………………………………… 53 Book 3A ………………………………………………………………………………… 63 Book 3B ………………………………………………………………………………… 73 Book 4A ………………………………………………………………………………… 82 Book 4B ………………………………………………………………………………… 92 Book 5A ………………………………………………………………………………... 102 Book 5B ………………………………………………………………………………... 112 Book 6A ……………………………………………………………………………….. 121 Book 6B ……………………………………………………………………………….. 131 Book -

Tai Chi Chuan Y La Salud : Estudio Médico-Educativo
Practicum Tai Chi Chuan y la salud: Estudio médico-educativo. Francesc Planas Mateu Consultor asignatura: Ander Permanyer Ugartemendia Asesor de contenidos: Manuel López Zafra Profesora responsable: Anna Busquets Alemany Tutor: José Francisco Cru Talaverón Estudios de Asia Oriental Universitat Oberta de Catalunya Lloret de Mar, 04 de Junio de 2015 1.- Agradecimientos: Quisiéramos expresar nuestro agradecimiento al consultor de esta asignatura, el Sr. Ander Permanyer Ugartemendia, y a nuestro asesor de contenidos relacionados con esta asignatura, el Sr. Manuel López Zafra, sin cuyas expertas explicaciones, consejos y ánimos jamás hubiéramos podido acabar de forma satisfactoria este Practicum. También agradecer a la U.O.C. en general por todos los recursos de los que hemos podido disponer a través de su biblioteca. Por otro lado también quisiéramos agradecer de forma personal a todas ésas personas anónimas que desinteresadamente han perdido horas de su trabajo para podernos atender y contestar a todas nuestras preguntas. Nos referimos a los médicos y a los profesores de Tai Chi que han respondido a nuestras entrevistas. Realmente han sido pocos y por esto lo valoramos mucho más. En el mundo en que vivimos donde las prisas y el trabajo es lo primero, encontrar a gente que quiera sentarse y hablar con un desconocido es casi un milagro. 1 2 - Índice general. 1 – Nota de agradecimientos……..……………………………….….……….……………….. Pág. 1 2 – Índice general…………………………………………………….…….……….………….……. Pág. 2 3 – Índice de ilustraciones……………………………………….….………...……………..….. Pág. 3 4 – Antecedentes: TdR. 4-1. Objetivos e hipótesis…………………………………………….….………………. Pág. 4 4-2. Enfoque metodológico………………………………………….….……………….. Pág. 5 4-3. Sinopsis del TdR………………………………………………..………..…….……… Pág. 7 4-4. Conclusiones……………………………………………………..………..….………… Pág. 13 5 – Introducción.