C. Venturini, 2011 - Si Forma Si Deforma Si Modella
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Second Report Submitted by Italy Pursuant to Article 25, Paragraph 1 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities
Strasbourg, 14 May 2004 ACFC/SR/II(2004)006 SECOND REPORT SUBMITTED BY ITALY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES (received on 14 May 2004) MINISTRY OF THE INTERIOR DEPARTMENT FOR CIVIL LIBERTIES AND IMMIGRATION CENTRAL DIRECTORATE FOR CIVIL RIGHTS, CITIZENSHIP AND MINORITIES HISTORICAL AND NEW MINORITIES UNIT FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES II IMPLEMENTATION REPORT - Rome, February 2004 – 2 Table of contents Foreword p.4 Introduction – Part I p.6 Sections referring to the specific requests p.8 - Part II p.9 - Questionnaire - Part III p.10 Projects originating from Law No. 482/99 p.12 Monitoring p.14 Appropriately identified territorial areas p.16 List of conferences and seminars p.18 The communities of Roma, Sinti and Travellers p.20 Publications and promotional activities p.28 European Charter for Regional or Minority Languages p.30 Regional laws p.32 Initiatives in the education sector p.34 Law No. 38/2001 on the Slovenian minority p.40 Judicial procedures and minorities p.42 Database p.44 Appendix I p.49 - Appropriately identified territorial areas p.49 3 FOREWORD 4 Foreword Data and information set out in this second Report testify to the considerable effort made by Italy as regards the protection of minorities. The text is supplemented with fuller and greater details in the Appendix. The Report has been prepared by the Ministry of the Interior – Department for Civil Liberties and Immigration - Central Directorate for Civil Rights, Citizenship and Minorities – Historical and new minorities Unit When the Report was drawn up it was also considered appropriate to seek the opinion of CONFEMILI (National Federative Committee of Linguistic Minorities in Italy). -

Comune Di Comeglians Provincia Di Udine
DUP 2020-2022 Comune di Comeglians Provincia di Udine DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2020 – 2022 punto 8.4 Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio – All. n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e smi Approvato con atto G.C. n. 51 del 25.07.2019 Aggiornato con atto G.C. n. del 21.11.2019 1 DUP 2020-2022 SOMMARIO PARTE PRIMA ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE 1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL’ENTE 1.1 Risultanze della popolazione 1.2 Risultanze del territorio 1.3 Risultanze della situazione socio economica dell’Ente 2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E SOCIETA’ PARTEICPATE 2.1 Servizi gestiti in forma diretta 2.2 Servizi gestiti in forma associata 2.3 Servizi affidati a organismi partecipati 2.4 Servizi affidati ad altri soggetti 2.5 Altre modalità di gestione di servizi pubblici 2.6 Società partecipate e consorzi 3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 3.1 Situazione di cassa dell’Ente 3.2 Livello di indebitamento 3.3 Debiti fuori bilancio riconosciuti 3.4 Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui 3.5 Ripiano ulteriori disavanzi 4. GESTIONE RISORSE UMANE 5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 2 DUP 2020-2022 PARTE SECONDA INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO a) Entrate: Tributi e tariffe dei servizi pubblici Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità -

Forni Avoltri - Ovaro - Prato Carnico - Rigolato
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale dell’Alto Friuli 33028 Tolmezzo, Via Matteotti, 7 - Tel. 0433 40865 – Fax 0433 2702 e-mail: [email protected] - pec: [email protected] - web: altofriuli.aterfvg.it Commissione per l’accertamento dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 21, comma 6, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 BANDO DI CONCORSO N. 4 / 2019 del 19 giugno 2019 per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata siti nel Comune o nei Comuni di COMEGLIANS - FORNI AVOLTRI - OVARO - PRATO CARNICO - RIGOLATO GRADUATORIA DEFINITIVA L’assegnazione degli alloggi agli aventi diritto avverrà in base alla presente graduatoria, tenuto conto delle caratteristiche degli stessi alloggi e della composizione del nucleo familiare destinatario dell’assegnazione. La presente graduatoria è resa pubblica mediante affissione, per trenta giorni consecutivi, nella sede dell’ATER, in luogo aperto al pubblico, all’albo pretorio e nelle sedi di decentramento comunale del Comune o dei Comuni nei cui territori hanno sede gli alloggi oggetto del bando, nei siti web istituzionali della Regione, dell’ATER e dei Comuni medesimi. I termini minimi di pubblicazione previsti ai fini di legittimità sono esclusivamente quelli risultanti dal sito internet dell’ATER. A parità di punteggio, è stata considerata prioritaria la domanda presentata dal richiedente residente da più tempo in Regione e, in subordine, la domanda presentata dal richiedente già present e in graduatorie precedenti dello stesso Comune o comprensorio di Comuni, senza soluzione di continuità; al perdurare della parità, le domande sono state inserite in graduatoria previo sorteggio. -

Orari E Percorsi Della Linea Bus
Orari e mappe della linea bus 124 124 Comeglians Scuole Visualizza In Una Pagina Web La linea bus 124 (Comeglians Scuole) ha 7 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Comeglians Scuole: 07:48 (2) Comeglians Via Roma: 06:45 - 18:33 (3) Comeglians Via Roma: 08:11 (4) Comeglians Via Roma (Aggiuntiva): 08:33 - 16:10 (5) Pesariis Bivio Lavardet: 08:15 - 18:50 (6) Pesariis Bivio Lavardet (Aggiuntiva): 08:15 - 15:45 (7) Pesariis Stabilimento Solari: 07:28 - 16:45 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus 124 più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus 124 Direzione: Comeglians Scuole Orari della linea bus 124 14 fermate Orari di partenza verso Comeglians Scuole: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 07:48 martedì 07:48 Pesariis Strada Statale 465 (Stabilimento Solari) mercoledì 07:48 Pesariis Strada Statale 465 (Bivio Lavaret) giovedì 07:48 Pesariis Strada Statale 465 (Bivio, Provenienza venerdì 07:48 Comeglians) sabato 07:50 Pesariis SS 465 (Direzione Comeglians), Località Sant'Antoni domenica Non in servizio Osais Strada Statale 465 (Direzione Comeglians) Pieris SS 465 (Fronte 69, Municipio Direzione Comeglians) Informazioni sulla linea bus 124 Direzione: Comeglians Scuole Prato Carnico SS 465 (Civ. 88, Dir.Comeglians), Fermate: 14 Loc.Muliton Durata del tragitto: 23 min La linea in sintesi: Pesariis Strada Statale 465 Prato Carnico SS 465 (Civ. 91, Casa Popolo (Stabilimento Solari), Pesariis Strada Statale 465 Dir.Comeglians) (Bivio Lavaret), Pesariis Strada Statale 465 (Bivio, Provenienza Comeglians), Pesariis SS 465 (Direzione Comeglians), Località Sant'Antoni, Osais Strada Prato Carnico SS 465 (Centro, Direzione Statale 465 (Direzione Comeglians), Pieris SS 465 Comeglians) (Fronte 69, Municipio Direzione Comeglians), Prato Carnico SS 465 (Civ. -

Elaborati Di Variante
Variante al PRGC del Comune di COMEGLIANS (UD) Sommario SOMMARIO ....................................................................................................................................... 1 1. PREMESSA ............................................................................................................................... 2 1.1. PREMESSA ........................................................................................................................... 2 1.2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO ............................................................................................... 3 2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO ..................................................................................... 4 3. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE ............................................................................ 6 3.1. DESCRIZIONE DEL SITO INTERESSATO DALLA VARIANTE ..................................................... 6 3.2. LA VARIANTE IN RAPPORTO AI BENI CULTURALI E DEMANIALI . ............................................. 8 3.3. LA VARIANTE IN RAPPORTO ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO . ................................................ 8 3.4. LA VARIANTE ALLA ZONIZZAZIONE ..................................................................................... 15 3.5. LA VARIANTE ALLE NORME DI ATTUAZIONE ....................................................................... 15 3.6. LA VARIANTE IN RAPPORTO AL T .U.E. D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327 ............................... 16 3.7. ELENCO IMMOBILI INTERESSATI DALLA VARIANTE -

Friuli Venezia Giulia
REGIONE: FRIULI-VENEZIA GIULIA Concentrazione di radon indoor misurata in abitazioni nell’ambito di indagini di misura: sintesi dei dati presenti nell’Archivio Nazionale Radon (ANR) per i Comuni con almeno 5 abitazioni misurate. COMUNE NUMERO MEDIA MINIMO MASSIMO ABITAZIONI ARITMETICA (Bq m–3) (Bq m–3) MISURATE (Bq m–3) AIELLO DEL FRIULI 8 102 39 181 AMARO 8 172 34 437 AMPEZZO 11 229 40 767 ANDREIS 10 266 38 705 ARBA 13 268 71 816 ARTA TERME 15 76 32 245 ATTIMIS 14 87 30 237 AVIANO 38 293 40 1409 AZZANO DECIMO 18 75 36 163 BAGNARIA ARSA 10 93 35 184 BARCIS 11 197 57 458 BASILIANO 60 163 35 747 BERTIOLO 9 183 56 737 BICINICCO 7 297 66 766 BORDANO 9 96 34 364 BRUGNERA 20 77 30 195 BUDOIA 9 91 36 201 BUJA 19 58 29 195 BUTTRIO 7 162 29 283 CAMINO AL TAGLIAMENTO 8 85 35 250 CAMPOFORMIDO 9 160 41 323 CANEVA 26 107 23 368 CAPRIVA DEL FRIULI 5 79 30 193 CARLINO 6 90 54 153 CASARSA DELLA DELIZIA 8 122 47 219 CASSACCO 6 122 32 255 CASTELNOVO DEL FRIULI 8 142 23 682 CASTIONS DI STRADA 8 200 39 513 CAVAZZO CARNICO 11 169 54 502 CERVIGNANO DEL FRIULI 8 67 43 109 CHIONS 11 63 30 110 CHIUSAFORTE 15 133 24 259 CIMOLAIS 5 235 127 340 CIVIDALE DEL FRIULI 24 82 18 556 CLAUT 26 248 55 831 CLAUZETTO 9 161 32 362 CODROIPO 27 225 27 982 1 di 5 COMUNE NUMERO MEDIA MINIMO MASSIMO ABITAZIONI ARITMETICA (Bq m–3) (Bq m–3) MISURATE (Bq m–3) COLLOREDO DI MONTE ALBANO 11 92 23 324 COMEGLIANS 8 136 28 275 CORDENONS 20 174 59 383 CORMONS 13 129 28 475 CORNO DI ROSAZZO 7 130 39 351 COSEANO 12 208 64 745 DIGNANO 12 163 65 347 DOBERDÒ DEL LAGO 12 259 54 1542 DOGNA 8 345 -

Udmm000vp6 Provincia Di Udine Udmm001zq2 Distretto
UDMM000VP6 PROVINCIA DI UDINE UDMM000XP4 DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO) UDMM001ZQ2 DISTRETTO 001 UDCT70200L CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA TOLMEZZO - (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) CON SEDE AMMINISTRATIVA IN TOLMEZZO : UDIS014006 DISTRETTI DI COMPETENZA : 001 CON SEDI CARCERARIE : UDMM70201X - TOLMEZZO UDMMA267Q3 COMUNE DI AMPEZZO UDMM82302V M. DAVANZO - AMPEZZO (AS. IST. COM. UDIC82300R/TOT. T. PROL. ) VIA DELLA MAINA N. 29 AMPEZZO UDIC82300R ISTITUTO COMPRENSIVO VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO AMPEZZO - VIA DELLA MAINA N. 29 (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) CON SEZIONI ASSOCIATE : UDAA82300L - AMPEZZO, UDAA82301N - FORNI DI SOPRA, UDAA82302P - FORNI DI SOTTO, UDAA82303Q - SAURIS, UDAA82304R - SOCCHIEVE, UDAA82305T - ENEMONZO, UDAA82306V - LAUCO, UDEE82301V - AMPEZZO, UDEE82302X - FORNI DI SOPRA, UDEE823031 - FORNI DI SOTTO, UDEE823042 - SAURIS, UDEE823053 - SOCCHIEVE, UDEE823064 - VILLA SANTINA, UDEE823075 - ENEMONZO, UDEE823086 - LAUCO, UDMM82301T - FORNI DI SOPRA, UDMM82302V - AMPEZZO, UDMM82303X - VILLA SANTINA UDMMA447Q0 COMUNE DI ARTA TERME UDMM814024 VIA ROMA - ARTA TERME (ASSOC. ALL'IST. COMPR. UDIC814002) VIA ROMA 14 ARTA TERME (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) UDMMC918S1 COMUNE DI COMEGLIANS UDMM80901G M. GORTANI - COMEGLIANS (AS. IST. COM. UDIC80900E/TOT. T. PROL. ) VIA ROMA 49/A COMEGLIANS (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) UDIC80900E ISTITUTO COMPRENSIVO M. GORTANI - COMEGLIANS COMEGLIANS - VIA ROMA 49/A (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) CON SEZIONI ASSOCIATE : UDAA80900A - COMEGLIANS, UDAA80901B - COMEGLIANS, UDAA80902C - FORNI AVOLTRI, UDAA80903D - OVARO, UDAA80904E - PRATO CARNICO, UDEE80901L - FORNI AVOLTRI, UDEE80902N - OVARO, UDEE80903P - PRATO CARNICO, UDEE80906T - COMEGLIANS, UDMM80901G - COMEGLIANS, UDMM80902L - FORNI AVOLTRI, UDMM80903N - OVARO UDMMD718T2 COMUNE DI FORNI AVOLTRI UDMM80902L RICCARDO ROMANIN (ASSOC. -

Aree in Deroga Art. 87.3.C Del Trattato
Austria Forni Avoltri DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI INTERNAZIONALI, Paluzza COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI Ligosullo Provincia di Belluno Rigolato Cercivento Ravascletto Paularo Treppo Comeglians Carnico Prato Carnico Pontebba Sutrio Malborghetto-Valbruna Ovaro Arta Terme Sauris Tarvisio Zuglio Moggio Udinese Dogna Raveo Lauco Forni di Sopra Ampezzo Tolmezzo Enemonzo Villa Santina Forni di Sotto Chiusaforte Socchieve Amaro Resiutta Verzegnis Preone Cavazzo Carnico Venzone Resia Cimolais Bordano Tramonti di Sopra Aree ammesse alla deroga dell'articolo 87§3 c) del Claut Tramonti di Sotto Trasaghis Trattato per gli aiuti di Stato a finalità regionale Lusevera Erto e Casso Gemona del Friuli Vito d'Asio nel periodo 2007-2013 ai sensi della decisione della Montenars Taipana Commissione europea C(2007)5618 del 28/11/2007 Clauzetto Osoppo Artegna Frisanco Meduno Forgaria nel Friuli Magnano Tarcento Andreis in Riviera Nimis Buia Travesio Castelnovo Barcis Cavasso del Friuli Nuovo Treppo Majano Grande Attimis Fanna Ragogna Pulfero Pinzano al Cassacco Savogna Tagliamento Drenchia Sequals Colloredo di M. Albano Tricesimo Faedis Grimacco San Daniele Regione Veneto Vajont Maniago Arba del Friuli Reana del Roiale Torreano Montereale Valcellina Povoletto San Pietro al Natisone Rive d'Arcano Moruzzo Pagnacco Stregna San Leonardo Spilimbergo Fagagna Tavagnacco LEGENDA Aviano Dignano Vivaro San Vito Moimacco Cividale del Friuli Coseano di Fagagna Martignacco Budoia Trieste: Circoscrizioni di Altipiano Est, Servola-Chiarbola-Valmaura- Remanzacco Prepotto Udine Flaibano Borgo San Sergio, area portuale, demanio marittimo del Polcenigo San Giorgio della Rich. Pasian di Prato San Quirino compartimento di Trieste – per la parte eccedente a quella dell’area Mereto di Tomba Premariacco portuale di Trieste . Pradamano Roveredo San Martino al Tagliam. -
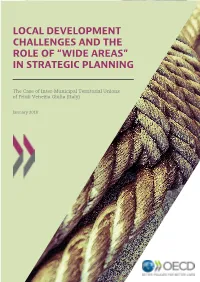
Local Development Challenges and the Role of “Wide Areas” in Strategic Planning
LOCAL DEVELOPMENT CHALLENGES AND THE ROLE OF “WIDE AREAS” IN STRATEGIC PLANNING The Case of Inter-Municipal Territorial Unions of Friuli Venezia Giulia (Italy) January 2018 2 │ OECD Working Papers should not be reported as representing the official views of the OECD or of its member countries. The opinions expressed and arguments employed are those of the authors. Working Papers describe preliminary results or research in progress by the author(s) and are published to stimulate discussion on a broad range of issues on which the OECD works. Comments on Working Papers are welcomed, and may be sent to CFE Directorate, OECD, 2 rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France This document and any map included herein are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area. Cover image: Designed by welcomia / Freepik © OECD 2018 You can copy, download or print OECD content for your own use, and you can include excerpts from OECD publications, databases and multimedia products in your own documents, presentations, blogs, websites and teaching materials, provided that suitable acknowledgment of OECD as source and copyright owner is given. All requests for public or commercial use and translation rights should be submitted to [email protected]. Requests for permission to photocopy portions of this material for public or commercial use shall be addressed directly to the Copyright Clearance Center (CCC) at [email protected] or the Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) [email protected]. -

3 Cod. Istat Comune / Comun Prov. Italiano / Talian Friulano
cod. Istat comune / comun prov. italiano / talian friulano comune / furlan comun friulano locale / furlan locâl 031001 CAPRIVA DEL FRIULI GO BUDIGNACCO BUDIGNAC = 031001 CAPRIVA DEL FRIULI GO CAPRIVA DEL FRIULI CAPRIVE CAPRIVA 031001 CAPRIVA DEL FRIULI GO RUSSIZ INFERIORE RUSSIZ DISOT = 031001 CAPRIVA DEL FRIULI GO RUSSIZ SUPERIORE RUSSIZ DISORE RUSSIZ DISORA 031001 CAPRIVA DEL FRIULI GO SPESSA SPESSE SPESSA 3 cod. Istat comune / comun prov. italiano / talian friulano comune / furlan comun friulano locale / furlan locâl 031002 CORMONS GO ANGORIS ANGORIS = 031002 CORMONS GO BOATINA LA BOATINE = 031002 CORMONS GO BORGNANO BORGNAN = 031002 CORMONS GO BRAZZANO BREÇAN BREZAN 031002 CORMONS GO CORMONS CORMONS = 031002 CORMONS GO GIASSICO INSIC = 031002 CORMONS GO MONTICELLO MONTISEL = 031002 CORMONS GO POVIA POVIE = 031002 CORMONS GO RONCADA LA RONCJADE = 031002 CORMONS GO SAN QUIRINO SAN QUARIN = 031002 CORMONS GO SAN ROCCO SAN ROC = 031002 CORMONS GO SUBIDA LA SUBIDE = Comune delimitato anche per la lingua slovena. Comun delimitât ancje pe lenghe slovene. 4 cod. Istat comune / comun prov. italiano / talian friulano comune / furlan comun friulano locale / furlan locâl 031004 DOLEGNA DEL COLLIO GO DOLEGNA DEL COLLIO DOLEGNE DAL CUEI DOLEGNA DAL CUEI 031004 DOLEGNA DEL COLLIO GO LONZANO LONZAN = 031004 DOLEGNA DEL COLLIO GO MERNICCO MERNIC = 031004 DOLEGNA DEL COLLIO GO RESTOCINA RESTOZINE RESTOZINA 031004 DOLEGNA DEL COLLIO GO RUTTARS ROTÂRS = 031004 DOLEGNA DEL COLLIO GO SCRIÒ SCRIÙ = 031004 DOLEGNA DEL COLLIO GO TRUSSIO TRUS = 031004 DOLEGNA DEL COLLIO GO VENCÒ VENCÒ = Comune delimitato anche per la lingua slovena. Comun delimitât ancje pe lenghe slovene. 5 cod. Istat comune / comun prov. italiano / talian friulano comune / furlan comun friulano locale / furlan locâl 031005 FARRA D’ISONZO GO FARRA D’ISONZO FARE FARA 031005 FARRA D’ISONZO GO MAINIZZA MAINIZE MAINIZA 031005 FARRA D’ISONZO GO VILLANOVA DI FARRA VILEGNOVE VILAGNOVA 6 cod. -

Tappa Data Itinerario Bus Linea Con Cambio Bus Orari
CON CAMBIO TAPPA DATA ITINERARIO BUS LINEA BUS ORARI NOTE PER IL RIENTRO DIRET. 12.30 -13.30- 01-IMPONZO-ILLEGIO 03-giu-18 ILLEGIO-TOLMEZZO NO x TOLMEZZO 14.25-17.45 13.15-14.14- 15.15-17.30- TOLMEZZO-IMPONZO x IMPONZO 18.15 12.15-13.05- 02-ILLEGIO-S.M.OLTREBUT 10-giu-18 TOLMEZZO-ILLEGIO SI 14.20-17.30 tratto S.Maria Oltrebut-Tolmezzo: a piedi 13.16-14.22*- 03-TOLMEZZO-CESCLANS 17-giu-18 CESCLANS-TOLMEZZO SÌ 18.28 * scendere al bivio con la strada provinciale 04-CESCLANS-VILLA di VILLA di VERZEGNIS- 12.24-14.29- VERZEGNIS 24-giu-18 TOLMEZZO NO x TOLMEZZO 17.29-19.40 TOLMEZZO-CESCLANS x CESCLANS 13.-18.10 05 -VILLA di VERZEGNIS- INVILLINO 01-lug-18 INVILLINO-TOLMEZZO NO x TOLMEZZO 12.34-13.40- x VILLA di 13.15-14.15- VERZEGNIS 17.15 13.29-15.42*- 06-INVILLINO-ENEMONZO 08-lug-18 ENEMONZO-INVILLINO SÌ 17.46 *con cambio a Villa Santina 07-ENEMONZO-SOCCHIEVE 15-lug-18 SOCCHIEVE-ENEMONZO SI 08-SOCCHIEVE-FORNI di FORNI di SOTTO- 12.46 -15.06- SOTTO 22-lug-18 SOCCHIEVE SÌ 17.04-18.40 09-FORNI di SOTTO - FORNI FORNI di SOPRA-FORNI di 14.50-16.48- di SOPRA 29-lug-18 SOTTO SÌ 18.35 X AMPEZZO- 10-FORNI di SOPRA-SAURIS SAURIS SOTTO-FORNI di FORNI di di SOTTO 05-ago-18 SOPRA NO SOPRA 16:48 cambio ad Ampezzo (17.20) 11-SAURIS di SOTTO - RIF. Rif. T. -

Cart. 3 - PROVINCIA DI UDINE - Comuni E Codici Istat N
Cart. 3 - PROVINCIA DI UDINE - Comuni e codici Istat n. 137 Comuni 30040 30071 30094 30050 30088 30022 30125 30073 30081 30029 30076 30112 30067 30054 30107 30005 30059 30136 30117 30089 30047 30033 30041 30121 30003 30035 30042 30110 30133 30025 30002 30084 30132 30093 30021 30131 30092 30012 30124 30051 30043 30061 30113 30066 30006 30137 30116 30065 30013 30052 30053 30126 30007 30086 30108 30087 30019 30034 30028 30127 30099 30090 30036 30045 30122 30095 30063 30078 30103 30068 30102 30111 30032 30037 30118 30060 30031 30106 30057 30091 30026 30039 30072 30129 30085 30058 30080 30083 30109 30009 30016 30079 30030 30055 30074 30048 30027 30101 30062 30010 30104 30015 30011 30128 30024 30114 30070 30105 30044 30135 30096 30020 30130 30001 30115 30075 30077 30008 30119 30017 30098 30097 30023 30123 30064 30134 30100 30069 30018 30120 30038 30082 30004 30046 30056 30049 PROVINCIA DI UDINE Comuni e codici Istat n. 137 Comuni Aiello del Friuli 30001 Lauco 30047 Resiutta 30093 Amaro 30002 Lestizza 30048 Rigolato 30094 Ampezzo 30003 Lignano Sabbiadoro 30049 Rive d'Arcano 30095 Aquileia 30004 Ligosullo 30050 Rivignano 30096 Arta Terme 30005 Lusevera 30051 Ronchis 30097 Artegna 30006 Magnano in Riviera 30052 Ruda 30098 Attimis 30007 Majano 30053 S. Daniele del Friuli 30099 Bagnaria Arsa 30008 Malborghetto-Valbruna 30054 San Giorgio di Nogaro 30100 Basiliano 30009 Manzano 30055 San Giovanni al Natisone 30101 Bertiolo 30010 Marano Lagunare 30056 San Leonardo 30102 Bicinicco 30011 Martignacco 30057 San Pietro al Natisone 30103 Bordano 30012 Mereto