Numero 4 – Giugno 2004
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Donald Duck: Timeless Tales Volume 1 Online
nLtTp (Free) Donald Duck: Timeless Tales Volume 1 Online [nLtTp.ebook] Donald Duck: Timeless Tales Volume 1 Pdf Free Romano Scarpa, Al Taliaferro, Daan Jippes audiobook | *ebooks | Download PDF | ePub | DOC #877705 in Books Scarpa Romano 2016-05-31 2016-05-31Original language:EnglishPDF # 1 10.38 x .97 x 7.63l, .0 #File Name: 1631405721256 pagesDonald Duck Timeless Tales Volume 1 | File size: 54.Mb Romano Scarpa, Al Taliaferro, Daan Jippes : Donald Duck: Timeless Tales Volume 1 before purchasing it in order to gage whether or not it would be worth my time, and all praised Donald Duck: Timeless Tales Volume 1: 7 of 7 people found the following review helpful. Nice book, great stories.By Dutch DelightWho does not like Donald Duck? Great collection of European and American artists. The book is hard cover, nicely made. needs to package it better though. You can't just stuff inside a cardboard sleeve and mail and not expect some damage. Wrap it in paper first to prevent scuffs.1 of 1 people found the following review helpful. Five StarsBy Mark NYAlways loved this type of comics.1 of 1 people found the following review helpful. Five StarsBy GrantLove it Wak! IDW's first six issues of Donald Duck are gathered in this classy collectorsrsquo; volume... including great works by Romano Scarpa, Giorgio Cavazzano, Daan Jippesmdash;and the first-ever US publication of "The Diabolical Duck Avenger," Donald's classic 1960s debut as a super-anti-hero! With special extras for true Disney Comics aficionados, this Donald compendium provides hours of history and excitement. -

Disney Nella Nostra Sim- Po’
Anteprima » Panini Comics L'ANGOLO DI VALENTINA DA NAPOLI A TORINO SULLE ALI… DEL TOPO! • di Valentina De Poli Nelle presentazioni istituzionali dedicate al Topo - lettori… E siamo anche accolti benissimo! Così, per proprio in questi giorni in coincidenza con il re- ricambiare, non vediamo l’ora che arrivino quelle styling e la nuova campagna dedicata al giornale, occasioni in cui possiamo essere noi a invitare gli partita l’11 aprile, ne stiamo organizzando un bel appassionati dei fumetti Disney nella nostra sim- po’... - arriva sempre il momento in cui racconto bolica casa. Di solito succede in occasione delle con fierezza di come il nostro magazine sia da de- fiere. I prossimi appuntamenti saranno a Napoli cenni un compagno di svago privilegiato scelto per il Comicon, dal 28 aprile, e poi subito dopo dalle famiglie italiane. Posso garantire che è tut- al Salone del Libro di Torino dal 10 maggio. Ma to vero, a giudicare anche dai racconti raccolti e tra una tappa e l’altra sul territorio avremo tempo registrati durante i focus group in giro per l’Italia, anche di dedicarci al centro Italia visitando i ne- realizzati nei mesi scorsi per testare il gradimento gozi vincitori dell’iniziativa “Disney Point 2017” del giornale, dove è stato bello ascoltare bambini (ricordate Anteprima #310?): perché le fumetterie e adulti sostenere che “Topolino non manca mai a sono la nostra seconda casa e sarà bello accoglier- casa nostra, ce lo passiamo di mano in mano!”. È vi anche lì! Ne parleremo sui prossimi numeri… come se ogni settimana un pezzettino di noi, tra Straquack! Valentina UN GIORNO TUTTO QUESTO… redazione e autori, entrasse nelle case dei nostri SARÀ A FUMETTI! PIPPO IN: 3X2 3259 Tito Faraci/Silvia Ziche UN GIORNO TUTTO QUESTO… DALLA PARTE SBAGLIATA SARÀ A FUMETTI! Tito Faraci/Paolo Mottura PIPPO IN: 3X2 Tito Faraci/Silvia Ziche TOPOLINO E L’ESPERIMENTO DEL DOTTOR PI UN GIORNO, Francesco Artibani/Alessandro Perina DALLA PARTE SBAGLIATA Tito Faraci/Paolo Mottura TUTTO QUESTO.. -

Journal of Religion & Society
Journal of Religion & Society Volume 6 (2004) ISSN 1522-5658 David, Mickey Mouse, and the Evolution of an Icon1 Lowell K. Handy, American Theological Library Association Abstract The transformation of an entertaining roguish figure to an institutional icon is investigated with respect to the figures of Mickey Mouse and the biblical King David. Using the three-stage evolution proposed by R. Brockway, the figures of Mickey and David are shown to pass through an initial entertaining phase, a period of model behavior, and a stage as icon. The biblical context for these shifts is basically irretrievable so the extensive materials available for changes in the Mouse provide sufficient information on personnel and social forces to both illuminate our lack of understanding for changes in David while providing some comparative material for similar development. Introduction [1] One can perceive a progression in the development of the figure of David from the rather unsavory character one encounters in the Samuel narratives, through the religious, righteous king of Chronicles, to the messianic abstraction of the Jewish and Christian traditions.2 The movement is a shift from “trickster,” to “Bourgeoisie do-gooder,” to “corporate image” proposed for the evolution of Mickey Mouse by Robert Brockway.3 There are, in fact, several interesting parallels between the portrayals of Mickey Mouse and David, but simply a look at the context that produced the changes in each character may help to understand the visions of David in three surviving biblical textual traditions in light of the adaptability of the Mouse for which there is a great deal more contextual data to investigate. -

The Illusion of Life: Disney Animation Interactive Edition
The Illusion of Life: Disney Animation Interactive Edition By Michelle L. Walsh Submitted to the Faculty of the Information Technology Program in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Bachelor of Science in Information Technology University of Cincinnati College of Applied Science June 2006 The Illusion of Life: Disney Animation Interactive Edition by Michelle L. Walsh Submitted to the Faculty of the Information Technology Program in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Bachelor of Science in Information Technology © Copyright 2006 Michelle Walsh The author grants to the Information Technology Program permission to reproduce and distribute copies of this document in whole or in part. ___________________________________________________ __________________ Michelle L. Walsh Date ___________________________________________________ __________________ Sam Geonetta, Faculty Advisor Date ___________________________________________________ __________________ Patrick C. Kumpf, Ed.D. Interim Department Head Date Acknowledgements A great many people helped me with support and guidance over the course of this project. I would like to give special thanks to Sam Geonetta and Russ McMahon for working with me to complete this project via distance learning due to an unexpected job transfer at the beginning of my final year before completing my Bachelor’s degree. Additionally, the encouragement of my family, friends and coworkers was instrumental in keeping my motivation levels high. Specific thanks to my uncle, Keith -

Tutto Roma No Scarpa
PRESENTAZIONE TUTTO ROMA NO SCARPA Sera e Gazzetta dello Sport: la prima integrale lare in meno in una vignetta, se infastidisce mai realizzata su un autore italiano. Il segui- lo svolgimento della storia. Scarpa è la figu- to ideale di quelle intitolate ai due predeces- ra di riferimento di un movimento al quale ap- sori americani. partengono sceneggiatori e disegnatori: i con- temporanei Guido Martina e Giovan Battista I volumi che vi accompagneranno durante Carpi, Carlo Chendi e Luciano Bottaro, quin- questo 2014, ciascuno di 360 pagine, com- di Giorgio Pezzin e Bruno Concina, Sergio prendono, in ordine cronologico, tutta la pro- Asteriti e Pier Lorenzo e Massimo De Vita, duzione di Scarpa. Nella migliore edizione poi Giorgio Cavazzano con la sua rivoluzio- possibile e, dov’era il caso, restaurata. E non ne moderna, e i più giovani Francesco Artiba- solo le opere tratte da Topolino, Albi d’Oro, ni, Silvia Ziche, Corrado Mastantuono, Fabio Almanacco Topolino, Classici di Walt Disney, Celoni, Casty, e mi perdonino tutti quelli – albi e volumi speciali, Zio Paperone, Maestri anch’essi grandi – rimasti sulla tastiera del pc. Disney e riviste estere: sono state inserite an- arl Barks. Floyd Gottfredson. E Ro- Una parata dei personaggi creati da Scarpa, che le storie ancora inedite in Italia e alcune I quali forse sorrideranno ripensando a un’al- mano Scarpa. Non sembri sacrilego disegnati nel 1986 per i primi venti anni del addirittura mai pubblicate. In più, numerosi tra frase del grande Maestro: “Mi sento con- l’accostamento ai due storici autori Salone Internazionale dei Comics di Lucca. -

Paperinik, Ou Comment Les Italiens Sont Parvenus À Mettre Des Pantalons À Donald Duck
Paperinik, ou comment les Italiens sont parvenus à mettre des pantalons à Donald Duck Gianni Haver et Michaël Meyer Parmi la production des bandes dessinées Disney, un personnage peu connu dans le contexte francophone est pourtant un véritable mythe en Italie. Il est à la fois un héros apprécié pour les histoires dans lesquelles il apparaît et un ambassadeur de l’école Disney italienne. Il s’agit de Paperinik, le double super-héroïque de Donald Duck. Du point de vue de l’étude de la bande des- sinée, il constitue une figure très pertinente pour interroger la circulation des modèles visuels et narratifs de la culture de masse américaine, et leurs réap- propriations par le Vieux Continent. Pour faire apparaître les échanges et les hybridations qui sont à l’ori- gine du personnage de Paperinik, il est nécessaire d’effectuer un itinéraire qui tient compte à la fois de l’arrivée des productions Disney en Italie et de la diffusion des récits de super-héros américains. L’intégration de ces produc- tions dans le paysage culturel italien est démontrée par une appropriation rapide qui donne lieu à une production locale, aussi bien de récits Disney que d’aventures super-héroïques. Dans le cadre du personnage de Paperinik, ces influences vont se combiner avec des motifs issus de productions autochtones, en particulier les bandes dessinées mettant en scène des héros criminels. BD-US : les comics vus par Europe Disney en l’Italie Les personnages de Disney naissent aux États-Unis dans le cinéma d’anima- tion des années 1920, avant de connaître un rapide succès sous la forme de comic strips dès janvier 1930, puis de comic books. -

Dei Fumetti Disney Di Realizzazione Statunitense (1945-1960)
FRANCESCO SESTITO DA BALATRONE A GOLASECCA: SONDAGGI SULLE MODALITÀ DI TRADUZIONE IN ITALIANO di antroponimi e toponimi ‘minori’ DEI FUMETTI DISNEY DI REALIZZAZIONE STATUNITENSE (1945-1960) Abstract: Abstract: Research concerning onomastics in Disney comics in Italian has produced important results, but, while the names of main characters and places have been thoroughly dealt with, the onomastics of the minor realities of the Dis- ney universe, which was created in the USA and reached Italy in translation, are not equally well known. In this paper I analyze several stories written in the years 1945-1960 and Italian versions from different periods. The translation techniques vary somewhat: some retain the original English forms, some Italianize the original names, some create new anthroponyms or toponyms in a fairly free way. Keywords: Disney comics, minor characters, anthroponyms, toponyms, translations Il mondo del fumetto Disney comprende una sterminata produzione di storie – stimabili a più di 35.000 – realizzate in diversi paesi dal 1930 a oggi, offrendo numerosissimi spunti sui nomi propri, dei personaggi e dei luoghi, rappresentati nelle storie stesse.1 Gli studi sull’onomastica di- sneyana sono ormai numerosi benché tutti relativamente recenti:2 basti 1 Il sito Inducks (catalogo di opere e personaggi: https://inducks.org) censisce esattamente (no- vembre 2018) 35.081 storie ufficialmente pubblicate. A questo strumento in rete, ormai impre- scindibile, così come all’enciclopedia in rete Paperpedia (http://it.paperpedia.wikia.com), -

L'inferno a Fumetti Di Guido Martina E Angelo Bioletto
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI Corso di Laurea Triennale in Lettere Una parodia della Commedia: l’Inferno a fumetti di Guido Martina e Angelo Bioletto Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Giuliana NUVOLI Elaborato Finale di: Martina ANGELILLO Matr. n. 828315 Anno Accademico 2015/2016 Indice Introduzione………………………………………………………………….........3 I. Cronistoria di Topolino……………………………………………………….6 §1. Topolino in Italia……………………………………………………..13 §2. Le Grandi Parodie Disney…………………………………………...19 II. L’Inferno di Topolino di Guido Martina e Angelo Bioletto………………...22 §1. Topolino vian-Dante………………………………………………....25 III. Come nasce un fumetto …………………………………………………….45 §1. Le vignette e i disegni de L’Inferno di Topolino…………………........47 §2. I balloons e le didascalie de L’Inferno di Topolino…………...…......57 §3. Dal verso di Dante al verso di Martina………………………………63 Bibliografia…………………………………………………………………........68 Sitografia…………………………………………………………………………70 2 Introduzione L’inferno di Topolino è la riscrittura in chiave parodica della cantica infernale di Dante Alighieri. Il fumetto è frutto della collaborazione di due menti geniali: Guido Martina e Angelo Bioletto; i due, che operano fuori dal coro, contribuiscono alla creazione di qualcosa di assolutamente innovativo. La riscrittura parodica della Commedia è un potente motore che genera storie; si tratta di mutuare uno schema narrativo che funziona, lasciare in controluce l’originale, e infine modificare quanto basta affinché l’opera risulti adeguata al nuovo contesto. Guido Martina e Angelo Bioletto scrivono un’opera intergenerazionale: sarebbe infatti riduttivo relegare L’Inferno di Topolino ad un prodotto per l’infanzia. Scrive Faeti: «I “riscrittori” sminuzzano, triturano e soprattutto (almeno apparentemente) addolciscono, con il miele dell’ironia, i bocconi indubitabilmente salutari per lo stomaco adulto e poco appetibili per le bocche infantili»1. -

Disney Comics from Italy♦ © Francesco Stajano 1997-1999
Disney comics from Italy♦ © Francesco Stajano 1997-1999 http://i.am/filologo.disneyano/ A Roberto, amico e cugino So what exactly shall we look at? First of all, the Introduction fascinating “prehistory” (early Thirties) where a few pioneering publishers and creators established a Disney Most of us die-hard Disney fans are in love with those presence in Italy. Then a look at some of the authors, seen comics since our earliest childhood; indeed, many of us through their creations. Because comics are such an learnt to read from the words in Donald’s and Mickey’s obviously visual medium, the graphical artists tend to get balloons. Few of us, though, knew anything about the the lion’s share of the critics’ attention; to compensate for creators of these wonderful comics: they were all this, I have decided to concentrate on the people who calligraphically signed by that “Walt Disney” guy in the actually invent the stories, the script writers (though even first page so we confidently believed that, somewhere in thus I’ve had to miss out many good ones). This seems to America, a man by that name invented and drew each and be a more significant contribution to Disney comics every one of those different stories every week. As we studies since, after all, it will be much easier for you to grew up, the quantity (too many) and quality (too read a lot about the graphical artists somewhere else. And different) of the stories made us realise that this man of course, by discussing stories I will also necessarily could not be doing all this by himself; but still, we touch on the work of the artists anyway. -
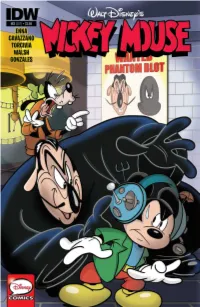
Mickey Mouse #2 Preview
STORY 1 The Sound-Blot Plot from Italian Topolino 2784 (2009) WRITER Bruno Enna ARTIST Giorgio Cavazzano INKER Sandro Zemolin STORY 2 COLORIST Disney Italia with Tom B. Long LETTERER Tom B. Long The W’angler TRANSLATION David Gerstein from British Mickey Mouse Annual 4 (1933) DIALOGUE Joe Torcivia WRITER, ARTIST AND LETTERER Wilfred Haughton COLORIST Digikore Studios EDITOR Sarah Gaydos IFC DESIGNER Paul Hornschemeier ARCHIVAL EDITOR David Gerstein REGULAR COVER Dave Alvarez STORY 3 SUB COVER Amy Mebberson What’s Cookin’? RI COVER James Silvani from Mickey Mouse Sunday comic strip (1950) WRITER Bill Walsh ARTIST AND LETTERER Manuel Gonzales COLORIST Digikore Studios Special thanks to Curt Baker, Julie Dorris, Manny Mederos, Beatrice Osman, Roberto Santillo, Camilla Vedove, Stefano Ambrosio, Carlotta Quattrocolo, and Thomas Jensen Ted Adams, CEO & Publisher Facebook: facebook.com/idwpublishing Greg Goldstein, President & COO Robbie Robbins, EVP/Sr. Graphic Artist Twitter: @idwpublishing Chris Ryall, Chief Creative Officer/Editor-in-Chief YouTube: youtube.com/idwpublishing Matthew Ruzicka, CPA, Chief Financial Officer Alan Payne, VP of Sales Tumblr: tumblr.idwpublishing.com www.IDWPUBLISHING.com Dirk Wood, VP of Marketing Instagram: instagram.com/idwpublishing IDW founded by Ted Adams, Alex Garner, Kris Oprisko, and Robbie Robbins Lorelei Bunjes, VP of Digital Services MICKEY MOUSE #2 (Legacy #311), JULY 2015. FIRST PRINTING. All contents, unless otherwise specified, copyright © 2015 Disney Enterprises, Inc. All rights reserved. IDW Publishing, a division of Idea and Design Works, LLC. Editorial offices: 2765 Truxtun Road, San Diego, CA 92106. The IDW logo is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. Any similarities to persons living or dead are purely coincidental. -

La Divina Parodia. Un'analisi Socioculturale Di Dante
Dante e l’arte 5, 2018 105-134 La Divina parodia. Un’analisi socioculturale di Dante. La Divina Commedia a fumetti di Marcello Toninelli1 Mario Tirino Università di Salerno [email protected] Lorenzo Di Paola Università di Salerno [email protected] Riassunto La forza dell’immaginario nato dalla Divina Commedia ha attraversato secoli e media dando vita a una vasta ed eterogenea selva di prodotti figli dell’eredità dantesca. Il fumetto italiano si è confrontato più volte con il poema “sacro”, ma l’unica trasposizione integrale dell’opera è Dante. La Divina Commedia a fumetti di Marcello Toninelli. Questa traduzione fumetti- stica lascia emergere con ironia il corpo a corpo con la fonte; dinamiche e meccanismi della narrazione poetica vengono parodiati e trasferiti nel linguaggio dei comics, dando vita a una macchina narrativa per immagini in cui, tra innovazione e imitazione, è anche possibile ritrovare l’eco della lunga e fortunata tradizione figurativa del poema. Parole chiave: Dante; Toninelli; Commedia; parodia; intermedialità. Abstract The power of the imaginary, fueled by Dante’s Divina Commedia, has crossed centuries and the media, giving rise to a vast and heterogeneous collection of products of Dante’s legacy. The authors of Italian comics have been confronted several times with the “sacred” poem, but the only complete transposition of the work is Dante. La Divina Commedia a fumetti by Marcello Toninelli. This comic book translation has an ironic relationship with the source; dynamics and mechanisms of poetic narration are parodied and transferred into the language of comics. Toninelli creates a narrative machine for images in which, between innovation and imitation, it is also possible to re-discover the echo of the long and successful figurative tradition of the poem. -
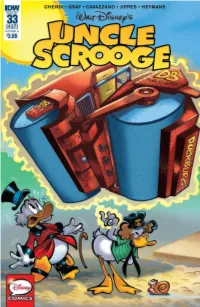
Preview Book
STORY 1 Scare of the Sky Satellite from Italian Topolino 1354, 1981 (First USA Publication) WRITER Carlo Chendi ARTIST Giorgio Cavazzano COLORIST Digikore Studios LETTERER Nicole and Travis Seitler TRANSLATION AND DIALOGUE Jonathan H. Gray STORY 2 EDITOR Joe Hughes Sometimes a Nickel Spent is a Dollar Saved from Czech Ka er Donald 5/2013 (First USA Publication) PUBLISHER Ted Adams č ARCHIVAL EDITOR David Gerstein WRITER AND ARTIST Daan Jippes COLORIST Digikore Studios IFC DESIGNER Paul Hornschemeier LETTERER Nicole and Travis Seitler COVER DESIGNER Tom B. Long COVER A Jonathan H. Gray STORY 3 COVER A colored by Massimo Rocca News From the Shoes COVER B Giorgio Cavazzano from Dutch Donald Duck Weekblad 4/2008 COVER B colored by Max Monteduro (First USA Publication) RI COVER Massimo Fecchi RI COVER colored by Fabio Lo Monaco WRITER Evert Geradts ARTIST Bas Heymans COLORIST Digikore Studios LETTERER Nicole and Travis Seitler TRANSLATION AND DIALOGUE Maura McManus Special thanks to Eugene Paraszczuk, Julie Dorris, Carlotta Quattrocolo, Manny Mederos, Chris Troise, Roberto Santillo, Camilla Vedove, and Stefano Ambrosio. For international rights, contact [email protected] Ted Adams, CEO & Publisher • Greg Goldstein, President & COO • Robbie Robbins, EVP/Sr. Graphic Artist • Chris Ryall, Chief Creative Officer • David Hedgecock, Editor-in-Chief • Laurie Windrow, Senior Vice President of Sales & Marketing • Matthew Ruzicka, CPA, Chief Financial Officer • Lorelei Bunjes, VP of Digital Services • Jerry Bennington, VP of New Product Development Facebook: facebook.com/idwpublishing • Twitter: @idwpublishing • YouTube: youtube.com/idwpublishing www.IDWPUBLISHING.com Tumblr: tumblr.idwpublishing.com • Instagram: instagram.com/idwpublishing UNCLE SCROOGE #33 (Legacy #437), DECEMBER 2017.