Relazione Di Massimo Sgaravato (625014
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Annual Report 2000-2001
europe activity 8 Oct. 2000 - 23 Oct. 2001 ilga report www.ilga-europe.org europe activity ilga report THANKS & ACKNOWLEDGEMENTS We would like to thank everybody who HIVOS (the Netherlands), Homosexuelle supported the work of the Board over the Selbsthilfe e. V. (Germany), and the City of last twelve months. Without the commit- Rotterdam for generously funding specific ment and donations of many people and projects and activities of ILGA-Europe; the financial and other support of many (member) organisations this work would ◗ Homosexuelle Initiative (HOSI) Wien not have been possible. We cannot mention (Austria), UNISON, the public sector them all here but special thanks have to go union in the United Kingdom, and Fede- to the following: ratie Werkgroepen Homoseksualiteit (Bel- gium) for substantial financial contribu- ◗ Steffen Jensen who, as outgoing treasurer, tions to our work; The European Region of the continued to take care of ILGA-Europe’s International Lesbian and Gay finances and accounts until the end of the ◗ the European Commission for granting us Association calendar year 2000. Together with other core funding and its anti-discrimination activists of the Danish national gay and unit for the good co-operation; Avenue de Tervueren/ lesbian association LBL he also continued Tervurenlaan 94/1 to publish the Euro-Letter on behalf of ◗ MEPs Michael Cashman, Joke Swiebel, B-1040 Brussels ILGA-Europe, and on top of that Patsy Sörensen, Lousewies van der Laan, phone +32 2 732 54 88 remained in charge of our web-site; and Baroness -

Official Journal C 174 E Volume 44 of the European Communities 19 June 2001
ISSN 0378-6986 Official Journal C 174 E Volume 44 of the European Communities 19 June 2001 English edition Information and Notices Notice No Contents Page I (Information) EUROPEAN PARLIAMENT WRITTEN QUESTIONS WITH ANSWER (2001/C 174 E/001) P-2575/99 by Alexandros Alavanos to the Commission Subject: Lack of infrastructures and facilities at Patras Port (Supplementary Answer) ................. 1 (2001/C 174 E/002) E-2783/99 by Alexandros Alavanos to the Commission Subject: Shortcomings of public works in Greece (Supplementary Answer) ....................... 2 (2001/C 174 E/003) E-0951/00 by Bart Staes to the Commission Subject: The Objective 2 region of Hainaut (Supplementary Answer) .......................... 3 (2001/C 174 E/004) E-2666/00 by Elly Plooij-van Gorsel to the Commission Subject: Safety of nuclear power stations in the applicant countries ........................... 5 (2001/C 174 E/005) E-2682/00 by Matti Wuori to the Commission Subject: Nuclear safety Temelin power station ..................................... 6 (2001/C 174 E/006) E-2736/00 by Charles Tannock to the Commission Subject: Consistency in the application of the precautionary principle ......................... 7 (2001/C 174 E/007) E-2743/00 by Monica Frassoni to the Commission Subject: Sewage plant in Sarroch, Sardinia (Supplementary Answer) ........................... 8 (2001/C 174 E/008) E-2776/00 by Avril Doyle to the Council Subject: Torture in Turkish prisons ............................................. 9 (2001/C 174 E/009) E-2795/00 by Lord Inglewood to the Commission Subject: Top rate of tax on personal incomes in each country of the European Union ................ 10 (2001/C 174 E/010) E-2796/00 by Lord Inglewood to the Commission Subject: Top rate of personal inheritance tax in each country of the European Union ............... -

Summer 2001 Lesbian/Gay Law Project Partners Will Have to Relevant Web-Sites: Notes, Usa/Legal/Lgln
europe news Vol. 1, issue 2, August 2001 ilga letter www.ilga-europe.org Belgrade Gay Pride Activists under attack Photo: Associated Press First row: Claudia Roth; second row, left: Lousewies van der Laan, David Geer and Hein Verkerk; right: Mette Vadstrup, Michael Cashman and Joke Swiebel LGBT “embassy” opened On 27 June 2001, the new ILGA- many friends and supporters Verkerk und David Geer. And attend our opening party. Since Europe office in Brussels, rent- from the Platform of European Griffith Vaughan Williams, who her groundbreaking 1994 EP ed and in use already since Social NGOs and its member made the journey from London report “on equal rights for February, was finally opened organisations, but also from just for these two occasions. homosexuals and lesbians in officially. Around 80 people fol- Human Rights Watch. And of Other ILGA veterans such as the EC” she has become some- lowed the invitation, and at the course many lesbian and gay Hartmut Schönknecht and Ernst thing like an “icon” for the peak of the party, our 70 square activists showed up. We were Strohmeyer travelled extra from European LGBT movement. She metres at Tervurenlaan 94 got glad to welcome former ILGA Germany and Austria to take gave a short speech emphasis- quite packed. Members of the secretary-general Inge Wallaert, part in these events. Hilde ing the great achievement that European Parliament – Joke Tom Hoemig, administrator of Vossen, chair of the Dutch the opening of this “embassy of Swiebel, Lousewies van der the ILGA World office, Bernard Bisexual Network that had just LGBT people in Brussels” is Laan and Michael Cashman, Lonnoy from EGALITE, all the organised the first European after all the years of struggle who also made a short speech – representatives from the move- bisexuals conference in Rotter- and lobbying. -
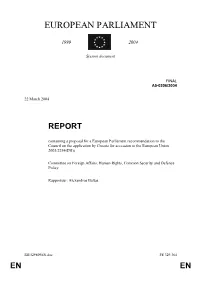
A5-0206/2004
EUROPEAN PARLIAMENT GGG G G G G 1999 G G 2004 G G G Session document FINAL A5-0206/2004 22 March 2004 REPORT containing a proposal for a European Parliament recommendation to the Council on the application by Croatia for accession to the European Union 2003/2254(INI)) Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy Rapporteur: Alexandros Baltas RR\529809EN.doc PE 329.364 EN EN PE 329.364 2/15 RR\529809EN.doc EN CONTENTS Page PROCEDURAL PAGE.............................................................................................................. 4 PROPOSAL FOR A EUROPEAN PARLIAMENT RECOMMENDATION TO THE COUNCIL .................................................................................................................................. 5 EXPLANATORY STATEMENT............................................................................................ 11 PROPOSAL FOR A RECOMMENDATION B5-0476/2003 ................................................. 14 RR\529809EN.doc 3/15 PE 329.364 EN PROCEDURAL PAGE At the sitting of 17 November 2003 the President of Parliament announced that he had referred the proposal for a recommendation on the application of Croatia for accession to the EU (B5-0476/2003), tabled by Alexandros Baltas on behalf of the PSE Group pursuant to Rule 49(1) of the Rules of Procedure, to the Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy as the committee responsible. At its meeting of 26 November 2003 the committee decided to draw up a report on the subject -

PDF Za Prenos
Slavistična knjižica 5 (vezna stran) 1 (prva stran knjige) Zoltan Jan: CANKAR, KOSOVEL, ZLOBEC IN LJUBKA ŠORLI PRI ITALIJANIH ter BIBLIOGRAFSKI DODATEK signeta ZALOŽBA ROKUS & SLAVISTIČNO DRUŠTVO SLOVENIJE Ljubljana, 2001 2 (naslovna stran; 2. stran knjige) Zoltan Jan: Cankar, Kosovel, Zlobec in Ljubka Šorli pri Italijanih. Bibliografski dodatek: slovenska književnost pri Italijanih po drugi svetovni vojni. Slavistična knjižnica 5 CIP - Kataloški zapis o publikaciji 3 Moji mani, ki me je znala spodbujati, da sem končal gimnazijo. 4 V S E B I N A Ivan Cankar ……………………………........................……………................................... Srečko Kosovel…………………………….....…………..................................................... Ciril Zlobec…………………………………….……........................................................... Ljubka Šorli………………………………………………………………………………… BIBLIOGRAFSKI DODATEK: SLOVENSKA KNJIŽEVNOST PRI ITALIJANIH PO DRUGI SVETOVNI VOJNI …….. Knjižni prevodi del posameznih slovenskih avtorjev………………………………………... Slovensko ljudsko slovstvo v italijanščini…………………………………………………… Antologije slovenskega leposlovja v italijanščini………………………………………….... Publicistika in literarna zgodovina o slovenski literaturi in kulturi v italijanščini…………. Strokovna literatura o slovensko-italijanskih literarnih stikih...…………………………….. IMENSKO KAZALO……………………………………………………………………… O AVTORJU ………………………………………………………………...……………… IZ RECENZIJE …………………………………………………………………………...… V SLAVISTIČNI KNJIŽNICI JE IZŠLO ………………………………………………...… 5 IVAN CANKAR PRI ITALIJANIH 6 Ivan Cankar je slovenski -

Downloaded from Brill.Com10/02/2021 08:16:04PM Via Free Access
review of central and east european law 43 (2018) 255-273 brill.com/rela Kosovo’s Quest for Council of Europe Membership Kushtrim Istrefi 1 University of Amsterdam, The Netherlands <[email protected]> Abstract In 2014, Kosovo became a member of two Council of Europe (CoE) partial agreements: on the Development Bank and on the European Commission for Democracy through Law (the Venice Commission). More recently, the Government of Kosovo expressed an interest in joining the CoE. This article examines, in the context of Kosovo’s contested statehood, the conditions and procedure for Kosovo’s possible admission to the CoE and describes, in the form of an early warning, the key legal and policy issues that could arise in this process. Insofar as membership criteria are concerned, the article examines Kosovo’s ability to exercise jurisdiction over its territory. In this regard, the case of Azemi v. Serbia before the European Court of Human Rights (ECtHR or the Strasbourg Court) and the eu-facilitated agreements between Belgrade and Pristina are considered. In addition, the article argues that that the direct applicability of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (echr) and the ECtHR’s case law in Kosovo are evidence of Kosovo’s commitment to fulfilling one of the essential membership criteria. Regarding Kosovo’s prospects for admission, the article submits that the recognition of Kosovo by more than two-thirds of the Council’s member states is an indicator that, in principle, Kosovo could ensure the votes necessary for admission. However, it also highlights the specific challenges Kosovo may encounter in its membership path due to complex admission procedures within the CoE Committee of Ministers and the composition of the members of the CoE Parliamentary Assembly (pace). -

Slo V Eni in Italia
SOMMARIO ISSN 1826-6371 pag. pag. 1 SLOVENIA – ITALIA Narodni dom, tutti gli ingranaggi della diplomazia sono in movimento Continua l’impegno all’avvicinarsi del centenario del 13 luglio 2 NARODNI DOM Una fondazione tra Skgz e Sso per riavere la casa di cultura sottratta 3 TRIESTE – TRST La giunta Dipiazza istituisce la Giornata di liberazione dall’occupazione jugoslava Sarà celebrata ogni 12 giugno 4 LA REAZIONE Una contropartita per il Narodni dom 5 ITALIA – SLOVENIA Confini socchiusi: liberi per chi entra, non per chi esce Da Lubiana a Trieste senza «ostacoli». Dal Friuli-Venezia Giulia ingresso consentito solo ad alcune condizioni Bollettino di informazione/Informacijski bilten Slovencev v Italiji Bollettino di informazione/Informacijski Slovencev bilten Sloveni in Italia Sloveni 9 ITALIA – SLOVENIA Fucile puntato contro due italiani al confine con la Slovenia La Farnesina ha chiesto lumi a Lubiana. Anno XXII N° 5 (261) In serata la replica del ministero della Difesa: 31 maggio 2020 «Nessuna pattuglia dell’esercito in quei luoghi». 10 SLAVIA – BENEČIJA Dalla legge di tutela per gli sloveni 2,4 milioni per l’economia delle valli Via libera della commissione consultiva a interventi a sostegno di turismo, imprenditoria e lavori pubblici 13 SCUOLA – ŠOLA Riduzione di tre cattedre, sull’Istituto Žiga Zois incombe la minaccia Quindicinale di informazione Direttore responsabile Giorgio Banchig Traduzioni di Veronica Galli, Luciano Lister e Larissa Borghese Direzione, redazione, amministrazione: 14 GRIMACCO – GARMAK Borgo San Domenico, n. 78 - C. P. 85 - 33043 Inviano una lettera di denuncia, Cividale del Friuli (UD) - Tel e fax 0432 701455 ma la firma del presidente del circolo sloveno è falsa internet: www.slov.it - e-mail: [email protected] Stampa in proprio - Registrazione Tribunale di Udine n. -

Download/Html/?Bookhl=&Book=Prokopo- Vich Sochineniya 1961> (02.04.15)
BIBLIOTECA DI STUDI SLAVISTICI Sara Laura Dickinson, Salmon Melancholic Identities, Toska and Reflective Melancholic Identities, Nostalgia Case Studies from Russian and Russian-Jewish Culture edited by Sara Dickinson, Laura Salmon Toska and Reflective Nostalgia FIRENZE PRESUNIVERSITYS BIBLIOTECA DI STUDI SLAVISTICI – 28 – COMITATO SCIENTIFICO Jan Ivar Bjørnflaten (Oslo), Andrzej Borowski (Kraków), Pierre Gonneau (Paris), Aleksandr Moldovan (Moskva), Svetlina Nikolova (Sofija), Serhii Plokhy (Cambridge, Mass.), Hans Rothe (Bonn), Stefan Simonek (Wien), Peter Thiergen (Bamberg) COMITATO DI REDAZIONE Alberto Alberti, Maria Cristina Bragone, Giovanna Brogi Bercoff, Maria Chiara Ferro, Marcello Garzaniti, Nicoletta Marcialis, Donatella Possamai, Francesca Romoli, Giovanna Siedina, Bianca Sulpasso, Andrea Trovesi Melancholic Identities, Toska and Reflective Nostalgia Case Studies from Russian and Russian-Jewish Culture edited by Sara Dickinson Laura Salmon Firenze University Press 2015 Melancholic Identities, Toska and Reflective Nostalgia : case Studies from Russian and Russian-Jewish Culture / edited by Sara Dickinson, Laura Salmon.– Firenze : Firenze University Press, 2015. (Biblioteca di Studi slavistici ; 28) http://digital.casalini.it/9788866558224 ISBN 978-88-6655-822-4 (online) ISBN 978-88-6655-821-7 (print) La collana Biblioteca di Studi Slavistici è curata dalla redazione di Studi Slavistici, rivista di pro- prietà dell’Associazione Italiana degli Slavisti (<http://fupress.com/riviste/studi-slavistici/17>). Editing e progetto grafico: Alberto Alberti. Questo volume viene pubblicato nell’ambito di un progetto di Ateneo finanziato dall’Università di Genova. In copertina: Disillusione, Piero Cividalli, Tel Aviv. Certificazione scientifica delle Opere Tutti i volumi pubblicati sono soggetti a un processo di referaggio esterno di cui sono responsabili il Consiglio editoriale della FUP e i Consigli scientifici delle singole collane. -

PDF Za Prenos
Slavistična knjižica 4 (vezna stran) (prva stran knjige) 2 Zoltan Jan: POZNAVANJE SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI V ITALIJI PO LETU 1945 signeta ZALOŽBA ROKUS & SLAVISTIČNO DRUŠTVO SLOVENIJE Ljubljana, 2000 (hrbet naslovne strani; 2. stran knjige) 3 Zoltan Jan: Poznavanje slovenske književnosti v Italiji po letu 1945 Slavistična knjižnica 4 CIP - Kataloški zapis o publikaciji 4 Nadki V S E B I N A 5 1. UVODNA OPREDELITEV RAZISKAVE............................................................ 2. HISTORIAT – DOSEDANJE OBRAVNAVE..................................................... 2.1. Publicistika in članki v dnevnem tisku............................................................... Značilnosti poročil v dnevnem tisku in njihov obseg; skupne poteze v ocenah antologije Luigija Salvinija; polemike Jolke Milič; kvaliteta prevajanja v italijanščino; dopolnitve literarne zgodovine v publicistiki; vprašljivost slovenskih kritičnih izdaj; odkrivanje plagijatov v italijanski književnosti; mesto poročanja o prodiranju slovenske književnosti v Italijo pri nekaterih slovenskih posrednikih. 2.2. V Italiji nastale študije o slovenski literaturi.................................................... Delo Artura Cronie, Giovannija Maverja, Bruna Meriggija, Bartolomea Calvija, Enrica Damianija, Umberta Urbanija; slovenistika v italijanskih slavističnih revijah; razvoj raziskovanja slovenske literarne zgodovine v Italiji; v Italiji delujoči raziskovalci slovenske literarne zgodovine; poročila o razvoju slovenistike v Italiji. 2.3. Dosedanje obravnave odmevov slovenske -

European Parliament
EUROPEAN PARLIAMENT ««« « « « « 1999 « « 2004 ««« Session document FINAL A5-0260/2001 Part 1 18 July 2001 REPORT on Slovenia’s application for membership of the European Union and the state of negotiations (COM(2000) 712 – C5-0612/2000 – 1997/2181(COS)) Part 1: Motion for a resolution and explanatory statement Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy Rapporteur: Demetrio Volcic RR\446089EN.doc PE 302.016 EN EN PE 302.016 2/88 RR\446089EN.doc EN CONTENTS Page PROCEDURAL PAGE ..............................................................................................................4 MOTION FOR A RESOLUTION .............................................................................................6 EXPLANATORY STATEMENT..............................................................................................8 Published separately: Opinions on Slovenia............................................................................... Part 2 – A5-0260/2001 Global opinions........................................................................................ Part 3 – A5-0251/2001 A5-0252/2001 A5-0253/2001 A5-0254/2001 A5-0255/2001 A5-0256/2001 A5-0257/2001 A5-0258/2001 A5-0259/2001 A5-0260/2001 A5-0261/2001 A5-0262/2001 RR\446089EN.doc 3/88 PE 302.016 EN PROCEDURAL PAGE By letter of 13 November 2000 the Commission forwarded to Parliament its 2000 Regular Report on Slovenia’s progress towards accession (COM(2000) 712 – 1997/2181(COS)). At the sitting of 15 March 2001 the President of Parliament announced that she had referred the Regular Report to the Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy as the committee responsible and all the committees interested in delivering an opinion and she confirmed the referral at the sitting of 14 June 2001 (C5-0612/2000). The Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy had appointed Demetrio Volcic rapporteur at its meeting of 23 September 1999 and confirmed that appointment at its meeting of 7 November 2000. -

Karpo Godina
INVITO / VABILO GODINA KARPO 21 /11 NOVA GORICA 22 /11 GORIZIA /GORICA FILMSKI AVTOR /AUTORE cinematografico 23 /11 LJUBLJANA 22–24 /11 izola /Isola 26 /11 TRIESTE /TRST 27 /11 Divača 28 /11 UDINE /VIDEM Centro audiovisivi | Medkulturne storitve Avdiovizualni center | Servizi interculturali NOVA GORICA SREDA /MERCOLEDÌ 21 /11 LJUBLJANA PETEK /VENERDÌ 23 /11 Kulturni dom, Bevkov trg 4 Slovenska kinoteka, Miklošičeva 28 11.00 ZGODBA GOSPODA P. F., 2002, 88' 21.00 OKTOLOG, 2012, 32' soorganizator /in collaborazione con: Kulturni dom Nova Gorica KARPOPOTNIK, Matjaž Ivanšin, 2012, 50' prisotna bosta /alla presenza di Karpo Godina, Matjaž Ivanišin GORIZIA /GORICA četrtek /gioveDì 22/11 soorganizator /in collaborazione con: Slovenska Kinoteka Palazzo del cinema /Hiša filma, Piazza Vittoria /Travnik 41 IZOLA /isola četrtek /gioveDì 22 /11 MASTERCLASS KARPO GODINA: sodelujejo /interventi di: Jože Dolmark, Sergio Germani, Ivan Nedoh, Sandro Scandolara, Simone Venturini. Art Kino Odeon, Ulica Prekomorskih brigad 4 09.15 GRATINIRANI MOZAK PUPILIJE FERKEVERK, 1970, 15' 18.00 UMETNI RAJ, 1990, 102' O LJUBAVNIM VEŠTINAMA ILI FILM SA 14441 KVADRATOM, 1972, 10' soorganizator /in collaborazione con: Festival Kino Otok – Isola Cinema I MISS SONIA HENIE, 1972, 14' BROOKLYN ACADEMY OF MUSIC, 2007, 5' IZOLA /isola PETEK /VENERDÌ 23 /11 14.30 SPLAV MEDUZE, 1980, 100' Art Kino Odeon, Ulica Prekomorskih brigad 4 OKTOLOG, 2012, 32' 18.00 RdečI boogIe ALI KAJ TI JE DEKLICA, 1982, 84' soorganizatorji /in collaborazione con: Palazzo del Cinema/Hiša filma, DAMS Cinema - 20.00 SONCE, VSESPLOŠNO SONCE, 1967, 14' Università degli Studi di Udine, Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici, PIKNIK V NEDELJO, 1967, 12' Slovenska kinoteka, Slovenski filmski center. -

Csconferenza PRAGA
PASSEPARTOUT 2008 Pensiero & Parole Risveglio di primavera: Praga ‘68 Domenica 15 giugno, ore 17.30, Palazzo del Collegio Domenica 15 giugno, alle ore 17.30, si tiene l’incontro Risveglio di primavera: Praga ’68, nell’ambito di Passepartout, il festival di letteratura organizzato dalla Biblioteca Astense, dal 9 al 15 giugno. Il giornalista e scrittore Bruno Gambarotta incontra Demetrio Volcic ed Enzo Bettiza per un dibattito sui fatti di Praga nel 1968. I protagonisti Bruno Gambarotta Scrittore, regista e direttore di programmi Rai, è nato ad Asti nel 1937. Le sue doti di intrattenitore e comico sono venute alla luce grazie a Adriano Celentano e al suo Fantastico del 1987. È autore e attore di cabaret, collabora a diversi giornali, tra cui L'Unità, La Stampa, La Repubblica. Tiene una rubrica fissa su Torino Sette. È autore di vari romanzi, di genere giallo-ironico, come Colpito in fronte da nemica palla e Tutte le scuse sono buone per morire. Negli ultimi anni ha pubblicato alcune opere dedicate a Torino e al Piemonte: Città Torino. Dal tramonto all’alba, con Filiberto Rotta (2001), Mangiare & bere in Piemonte 2001. Ristoranti & vini (2001) e Omaggio a Torino (2004). Demetrio Volcic Nasce a Lubiana nel 1931. Laureato in Economia all'Università degli Studi di Trieste, è stato, nello stesso ateneo, docente di dottrine politiche. Dipendente Rai dal 1956, diviene inviato speciale da Trieste nel 1964, passando, nel 1968, a corrispondente estero, incarico che lo ha portato fuori dall'Italia praticamente fino al 1993. E’ stato corrispondente da Praga, Vienna, Bonn: ma il suo volto per gli italiani è il volto dell'Unione Sovietica.