Il Palazzo Carmagnola
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
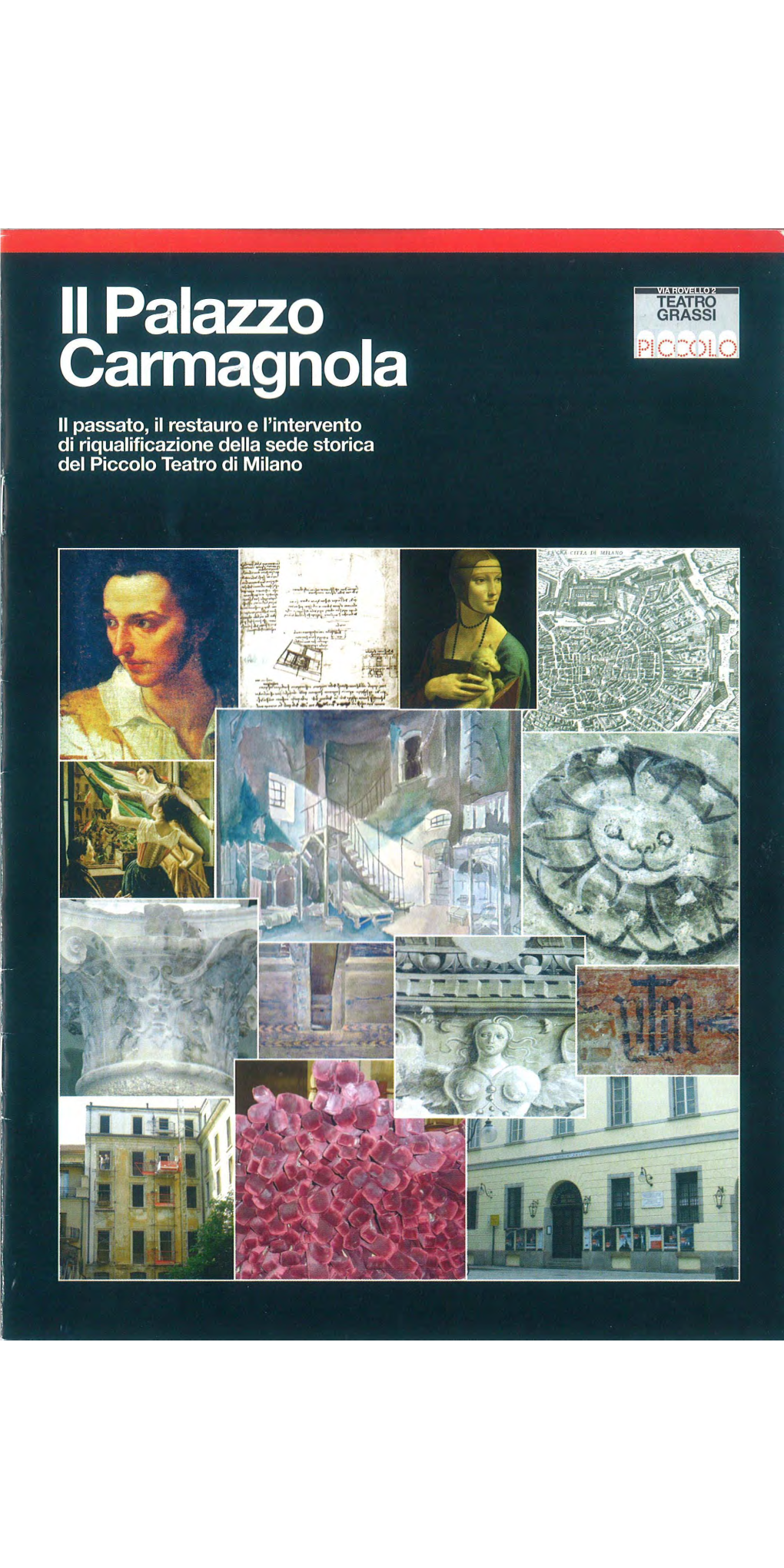
Load more
Recommended publications
-

Scarica La Versione In
La Filosofia di VIAGGINBICI Camminare è bello ma pedalare E’ salute: rinforza il corpo, lo è molto di più! contribuisce a donarci buonumore (sviluppa endorfine) e non inquina. La bicicletta cambia il punto di vi sta, lo eleva, ci fa vedere le cose La bicicletta cambia lo stile di da una prospettiva diversa, ci vita. Ci impone un ritmo più lento, dona quel senso di nobiltà imposto ma non troppo. Ci fa sentire dal busto eretto e dal mento in parte di ciò che ci circonda, ci alto. fa assaporare tutto ciò che ci appare davanti. La carezza del E’ libertà di fermarsi, di andare vento ci toglie persino quel velo avanti, di gustare il percorso alla di tristezza che ogni tanto diventa giu sta velocità. una seconda pelle. E’ potenza: misura le nostre forze, E’ il luogo, il momento in cui ci fa sentire motori di noi stessi. scrollatoci lo stress di dosso E’ democrazia: tutti possono nascono le idee. Girare in bicicletta averla e tutti la sanno usare. E’ è passare dal televisore tascabile una nave terrestre come dice al cinemascope per dirla con Claude Marthaler, che unisce gli Didier Tronchet girando il proprio uomini, le distanze, le generazioni, film, fatto di stupende carrellate. le classi sociali, le capacità fisiche, servendo per il trasporto, il Ludovica Casellati commercio, lo sport, l’espressione Direttore Responsabile artistica, il pellegrinaggio, il viaggio. E’ senso dell’equilibrio, la prima cosa che da bambini impariamo montandoci sopra. 4 Ludovica Casellati Direttore Responsabile E-book Milano in Bici Ideazione e Progettazione Ludovica Casellati Coordinamento Redazionale Marialuisa Bonivento Progetto Database Giordano Roverato Autori e Fotografi Marialuisa Bonivento percorso: Gianfranco Rocculi percorso: Giordano Roverato percorso: Alessandro Avalli percorso: Maps Editor Luca Marin Progetto Grafico Alberto Fardin Concessionaria Pubblicità Green Life srl e Clear Channel Copyright Green Life srl Ogni diritto sul presente lavoro è riservato ai sensi della normativa vigente. -

Italie Du Nord
Italie du Nord Y VOIR L’essentiel M VIVRE LE MEILLEUR AUTRICHE SUISSE ITALIE E EUROP DU NORD ITALIE FRANCE AUTRICHE ASIE ITALIE AFRIQUE MILAN Lausanne ET LES GRANDS LACS SUISSE LAC p.46 MONTE LÉMAN DISGRAZIA 3 678 M Sion DE TURIN Sondrio AU VAL D’AOSTE Locarno p.268 LAC DE CÔME MONTE ★ Chamonix TUNNEL ROSA LAC MAJEUR DU MONT- 4 634 M BLANC ★ Aosta/ LAGO Varese Como Aoste LAGO MONT D’ORTA Bergamo BLANC D’ISEO 4 810 M MILAN ★ COL DU MONT- Novara CENIS Vercelli TUNNEL DU FRÉJUS TURIN Pavia Cremona ★ Piacenza Alessandria Sestriere Briançon Asti ★ Alba PARME Gap COL DE LARCHE GÊNES Cuneo ★ Barcelonnette Savona T E N Portofino CINQUE TERRE E N O R ★ P D I V I L I E La Spezia COL I E R D GOLFO V A A DE N TENDE A DI GENOVA T R E Imperia E FRANCE I V I GÊNES ET LA CÔTE San Remo R p.230 MONACO N Nice E R L I G U R I E N N E 50 km M DE VENISE AUX DOLOMITES AUTRICHE p.110 N AUTRICHE E Lienz L P PICCO A E E R H DELLA CIMA Ö T Z A L I C CROCE K ARNIS E T DIECI C H E Villach A L P I R 3 132 M 3 026 M A LP E A L P I C N CIMA A R N ICH Cortina E VERTANA Bolzano/ d’Ampezzo 3 544 M Bozen SLOVÉNIE M. CEVEDALE/ ZUFFALLSPITZE 3 765 M Belluno Udine Trento Pordenone Gorizia Trieste Treviso GOLFO LAGO DI TRIESTE DI Vicenza Brescia GARDA VÉRONE ★ ★ ★ VENISE CROATIE LAGUNA PADOUE VENETA M MANTOUE Chioggia E R ★ Rovigo A Sabbioneta PO D R I A ★ Ferrare T I PARME Modena Q Reggio U nell’Emilia E ★ Ravenne BOLOGNE Forlì Rimini Pesaro Massa Pistoia Lucca SAN Firenze MARINO Pisa L’ÉMILIE-ROMAGNE Ancona p.182 Livorno Arezzo Macerata SOMMAIRE SOMMAIRE 6 Reportage 47 Milan -

Broletto - Complesso
SIRBeC scheda ARL - LMD80-00058 Broletto - complesso Milano (MI) Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00058/ Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00058/ SIRBeC scheda ARL - LMD80-00058 CODICI Unità operativa: LMD80 Numero scheda: 58 Codice scheda: LMD80-00058 Visibilità scheda: 3 Utilizzo scheda per diffusione: 03 NUMERO INTERNO Numero interno: GPDP vuoto Tipo scheda: A Livello ricerca: P CODICE UNIVOCO Codice regione: 03 Numero catalogo generale: 00101847 Ente schedatore: R03 Ente competente: S26 RELAZIONI RELAZIONI CON ALTRI BENI Tipo relazione: relazione urbanistico ambientale Tipo scheda: A Codice bene: 03 Codice IDK della scheda correlata: q2010-00044 OGGETTO OGGETTO Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi Definizione tipologica: palazzo Qualificazione: comunale Denominazione: Broletto - complesso ALTRA DENOMINAZIONE Pagina 2/11 SIRBeC scheda ARL - LMD80-00058 Genere denominazione: idiomatica Denominazione: Broletto Nuovo LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA Stato: Italia Regione: Lombardia Provincia: MI Nome provincia: Milano Codice ISTAT comune: 015146 Comune: Milano CAP: 20121 Indirizzo: Piazza Mercanti ACCESSIBILITA' DEL BENE Accessibilità: SI Specifiche: Ingresso libero da Via Orefici, da Via mercanti, da Piazza Duomo o da Piazza Cordusio DEFINIZIONE CULTURALE AUTORE [1 / 3] Ruolo: costruzione: Palazzo Giureconsulti Autore/Nome scelto: Seregni, Vincenzo -

Il Futuro Ha Un Cuore Antico Un Viaggio Sulle Orme Dei Padri Del Design
PROGRAMMA FOCUS OTTOBRE 2016 GLI SCALI FERROVIARI GENNAIO 2017 IN 5 ITINERARI INEDITI ® ANNO VI - N. 3 PROGETTO SPECIALE 2016 IL FUTURO HA UN CUORE ANTICO UN VIAGGIO SULLE ORME DEI PADRI DEL DESIGN Città nascosta Milano è sostenuta da Programma ottobre 2016 - gennaio 2017.indd 1 19/09/16 17:12 CHI SIAMO: Un'associazione culturale senza scopo di lucro, fondata da Manuela Alessandra Filippi nel 2010, che negli anni si è distinta per il capillare lavoro di ricerca, promozione e divulgazione del patrimonio culturale milanese e lombardo. Dal 2010 abbiamo prodotto oltre 100 itinerari inediti, realizzato più di 1000 eventi e coinvolto nelle nostre visite guidate oltre 15.000 partecipanti. Nel gennaio 2011 abbiamo promosso in esclusiva il progetto La cultura si mangia! Un panino con... ®, pause pranzo che hanno rivoluzionato il modo di concepire e divulgare la cultura. Un panino con... ormai un must have per tutti! Nel 2012 abbiamo ricevuto il premio Dama d’Argento “per l’originalità dell’obiettivo dell’Associazione, tesa a scoprire e a far conoscere i tesori nascosti di Milano e per il progetto La cultura si mangia!, con cui si favorisce un approccio disinvolto ma attento alle mille anime della nostra città”. Dal 2012 collaboriamo con l’ADSI-Associazione Dimore Storiche Italiane, Sezione Lombardia, nell’annuale manifestazione Cortili Aperti, che ogni anno registra oltre 60mila partecipanti. In esclusiva per loro cura le visite guidate ai cortili. Nel 2015, per la piattaforma di Expo in Città – EXPO 2015 abbiamo ideato il progetto #ExploreMilan. Cultural trails to discover an unusual Milan: sei itinerari proposti in diverse lingue, ispirati alle sei opere d’arte selezionate dall’Assessorato alla Cultura in rappresentanza del patrimonio culturale milanese e italiano, a loro volta abbinate a sei tematiche differenti per ogni mese di Expo 2015. -

Leonardo Da Vinci the Flights of the Mind
CHARLES NICHOLL Leonardo da Vinci The Flights of the Mind I ., ALLEN LANE an imprint of PENGUIN BOOKS Contents Author's Note Xlll Introduction: The Cooling of the Soup I j PART ONE Childhood: 1452-1466 Birth 17 The da Vinci 21 Caterina 26 'My first memory ... ' 30 At the Mill "- 37 Speaking with Animals 42 The 'Madonna of the Snow' 47 Education 53 PART TWO Apprenticeship: 1466-1477 The City 61 Renaissance Men 68 Andrea's Bottega 72 Learning the Trade 77 Spectaculars 90 On the Lantern 94 First Paintings 98 The Dragon I04 Ginevra I07 The Saltarelli Affair Iq 'Companions in Pistoia' 124 IX CONTENTS PART THREE Independence: 1477-1482 Leonardo's Studio 13 1 The Hanged Man 13 8 Zoroastro 141 The Technologist 145 'Poets in a Hurry' 151 The Musician 155 St Jerome and the Lion 160 The Gardens of the Medici 165 The Adoration 168 Leaving 176 J PART FOUR New Horizons: 1482-1490 Milan 185 Expatriates and Artists 193 The Virgin of the Rocks 196 Ways of Escape 201 The First Notebooks 209 Tall Tales, Small Puzzles 216 Architectural Projects 222 The Moor's Mistress 226 The Milanese Studio 23 2 The Anatomist 240 The Sforza Horse 24 8 At the Carte Vecchia 251 PART FIVE At Court: 1490-1499 Theatricals 257 'Of shadow and light' 264 Little Devil 269 Hunting Bears 276 Casting the Horse 280 x CONTENTS , 'Caterina came ... 28 5 Echoes of War 288 The Making of the Last Supper 29 2 The 'Academy' 30 3 Leonardo's Garden 31 2 'Sell what you cannot take . -

Viewers Would Have Interpreted the Ornate Patterns of the Fresco As Moreschi, Or Moorish Designs
Florida State University Libraries Electronic Theses, Treatises and Dissertations The Graduate School 2011 Architectural Trees and Moorish Knots in Leonardo's Sala Delle Asse Thane Young Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact [email protected] FLORIDA STATE UNIVERSITY THE COLLEGE OF VISUAL ARTS, THEATRE AND DANCE ARCHITECTURAL TREES AND MOORISH KNOTS IN LEONARDO’S SALA DELLE ASSE By: Thane Young A Thesis submitted to the Department of Art History in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts Degree Awarded: Spring Semester, 2011 The members of the committee approve the thesis of Thane Young defended on April 4, 2011. __________________________________________________ Jack Freiberg Professor Directing Thesis __________________________________________________ Stephanie Leitch Committee Member __________________________________________________ Robert Neuman Committee Member Approved: _____________________________________________________ Dr. Adam Jolles, Chair, Department of Art History _____________________________________________________ Dr. Sally McRorie, College of Visual Arts, Theatre & Dance The Graduate School has verified and approved the above-named committee members. ii AKNOWEGEMENTS I would like to thank my advisor Dr. Jack Freiberg for his continuous support, encouragement, and guidance in writing this thesis. I am also indebted to my thesis committee: Professors Jack Freiberg, Stephanie Leitch, and Robert Neuman for their commentary, readings, and expertise. They have all dedicated so much time, and I wish to thank them sincerely. I also would like to extend my thanks to the Penelope Mason Travel Grant committee members who allotted travel funding for this thesis research. I also thank Dr. David Allan Brown, Curator of Italian Renaissance Painting at the Metropolitan Museum of Art in Washington D.C., for taking some time to offer advise and encouragement in conducting research on this topic. -

Stadtgeographische Prozesse Und Strukturen in Mailand
Stadtgeographische Prozesse und Strukturen in Mailand Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades einer Magistra der Naturwissenschaften an der Karl-Franzens-Universität Graz vorgelegt von Barbara ZISSLER am Institut für Geographie und Raumforschung Begutachter: Ao. Univ. Prof. Dr. Čede, Peter Graz, 2018 Eidesstattliche Erklärung Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die den Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen inländischen oder ausländischen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht. Die vorliegende Fassung entspricht der eingereichten, elektronischen Version. Datum: Unterschrift: 2 I Zusammenfassung Stadtgeographische Prozesse und Strukturen in Mailand Mailand lässt einen, je nach persönlichem Interesse, an die letzten Modetrends, präsentiert auf Catwalks im grellen Scheinwerferlicht, an Börsenkurse und ständig gestresste ManagerInnen, an die Pilgerreise zum Mailänder Dom oder an das Fußballteam, denken. Im Gegensatz zu anderen italienischen Städten, wird kaum jemand Mailand primär mit dem Reichtum an persistenter Bausubstanz in Verbindung setzten. Viel eher sind es die architektonisch hoch gelobten Neubauprojekte, über die man immer wieder in den Medien liest. Ein Teil der vorliegenden Arbeit befasst sich mit den vernachlässigten Gebäudeformen im Stadtzentrum Mailands, welche vor 1900 entstanden sind. Neben dem physischen Aspekt der Bebauung, spielt die Bevölkerung die zentrale Rolle im urbanen Gefüge. In einem anderen Kapitel wird über die historische, demographische Entwicklung der Stadt ein Bogen, hin zur aktuellen Situation in der Stadtgemeinde und den einzelnen Stadtbezirken, gespannt. Mailand stellt, seit der Industriellen Revolution, den wirtschaftlichen Motor Italiens dar, wie viele, europäische Metropolen hat es mit den, seit damals einhergehenden Veränderungen zu kämpfen. -

THE SALA DELLE ASSE in the SFORZA CASTLE in MILAN By
THE SALA DELLE ASSE IN THE SFORZA CASTLE IN MILAN by Patrizia Costa B.S. Industrial Administration and Italian, Carnegie Mellon University, 1989 M.A. History of Art, University of Pittsburgh, 1993 Submitted to the Graduate Faculty of Arts and Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Pittsburgh 2006 This dissertation was presented By Patrizia Costa It was defended on February 10, 2006 and approved by Ann Sutherland Harris, Professor of Italian Baroque Art Henry Clay Frick Department of the History of Art and Architecture David Wilkins, Professor Emeritus of Italian Renaissance Art Henry Clay Frick Department of the History of Art and Architecture H. Anne Weis, Associate Professor of Ancient Greek and Roman Art Henry Clay Frick Department of the History of Art and Architecture Kathleen Wren Christian, Assistant Professor of Italian Renaissance Art Henry Clay Frick Department of the History of Art and Architecture Francesca Savoia, Associate Professor of Italian Languages and Literature Department of French and Italian Languages and Literature Dennis Looney, Associate Professor of Italian Languages and Literatures Department of French and Italian Languages and Literature ii Copyright © by Patrizia Costa 2006 iii This dissertation is dedicated to my children Edoardo and Gianmarco studio sapientia crescit iv THE SALA DELLE ASSE IN THE SFORZA CASTLE IN MILAN Patrizia Costa, PhD University of Pittsburgh, 2006 This dissertation deals with two periods in the history of a room in the Sforza Castle known as the Sala delle Asse: the fifteenth‐century, when Ludovico Sforza (1452‐ 1508) commissioned Leonardo da Vinci (1452‐1519) to paint it and the late‐nineteenth‐ to‐early‐twentieth century when the Sala was re‐discovered and subjected to a major restoration by the Italian architectural historian Luca Beltrami (1854‐1933). -

Anthropological Legacies and Human Futures
Anthropological legacies and human futures 14th EASA Biennial Conference. Department of Human Science for Education ‘Riccardo Massa’ Department of Sociology and Social Research at University of Milano-Bicocca 20-23 July, 2016 Timetable Friday 22 July 08:30-19:00 Reception desk open 09:00-10:45 Panel session 5 10:45-11:15 Coffee/tea 11:15-13:00 Alexander Street’s multimedia resources workshop 11:15-13:00 Panel sesion 6 13:00-14:30 Lunch 13:15-14:30 #PrecAnthro: toward a transnational Anthropological Union Wednesday 20 July 14:30-16:30 Plenary B 12:00-18:30 Reception desk open 16:30-17:00 Coffee/tea and Berghahn reception 14:30-16:15 Panel session 1 17:00-18:45 Member's forum 16:15-16:45 Coffee/tea 18:45-19:00 BAGS drinks reception 16:45-18:30 Panel session 2 19:00-20:30 Network meetings 18:30-19:00 Break 19:00-20:30 The voice of the people II 19:00-20:30 Keynote and opening 19:00-20:30 Writing ERC Grant Proposals 20:30-21:30 Welcome drinks reception 19:00-20:30 The teaching of Anthropology in European secondary schools 19:30-20:30 Lab 14 Thursday 21 July 08:30-19:00 Reception desk open Saturday 23 July 09:00-10:45 Panel session 3 08:30-17:00 Reception desk open 10:45-11:15 Coffee/tea 09:00-10:45 Panel session 7 11:15-13:00 Panel session 4 10:45-11:15 Coffee/tea 13:00-14:30 Lunch 11:15-13:00 Panel session 8 13:15-14:30 'Meet the Editor' with 13:00-14:30 Lunch Anthropological Theory 14:30-16:30 Plenary C (ESCF) 13:15-14:30 Network convenors meeting (closed) 16:30-17:00 Coffee/tea and Pluto Press book launch 14:30-16:30 Plenary A 17:00-18:45 -

Per Un Profilo Intellettuale Di Franco Russoli (1923-1977)
Corso di Dottorato di ricerca in Storia delle Arti ciclo XXIX a.a. 2016/2017 Per un profilo intellettuale di Franco Russoli (1923-1977) L-ART/02; L-ART/03; L-ART/04 Coordinatore del Dottorato Ch. Prof.ssa Martina Frank (Università Ca’ Foscari, Venezia) Supervisori Ch. Prof.ssa Francesca Castellani (Università IUAV, Venezia) Ch. Prof. Emanuele Pellegrini (IMT – Alti studi, Lucca) Ch. Dott.ssa Caterina Bon Valsassina (Mibact) Dottorando Erica Bernardi 956128 Indice Introduzione – Franco Russoli “in and out” Cap. 1 - Franco Russoli da giovane 1.1 Pisa 1944-1950 1.2 Saggio sulla macchia (1944/45), uno sguardo a Longhi 1.3 I maestri: Matteo Marangoni, Carlo Ludovico Ragghianti 1.4 Scultura pisana del Trecento al carcere di San Matteo (1946-1947) 1.5 La mostra sulla pittura italiana contemporanea: l’incontro con Morandi, Casorati, Manzù e Salvadori (1947) 1.6 La ricostruzione di Pisa (1946-1950) 1.7 Tra Pisa e Milano passando per Parigi (1950) Cap. 2 - Un fatto politico: Picasso a Milano (1953) 2.1 Storicizzare un artista vivente 2.2 A caccia di opere 2.3 Guernica libre 2.4 Raccontare Picasso Cap. 3 - Il museo “militante” 3.1 Franco Russoli moderno museologo (1950-1977) 3.2 La casa museo come banco di prova (1950-1954) 3.3 Verso la direzione di Brera (1954-1957) 3.4 Il riordino dell’Accademia Carrara di Bergamo (1957-1962) 3.5 La crisi della cultura a Milano (1962-1969) 3.6 Un museo moderno di arte moderna per Milano (1969-1972) 3.7 L’utopia della grande Brera (1972-1974) 3.8 Museo Vivo (1973-1977) 3.9 Dalla chiusura di Brera al suo processo (1974-1977) 3.10 Il canto del cigno: “Processo per il museo” (1977) Cap. -

The High Renaissance COMMONWEALTH of AUSTRALIA Copyright Regulations 1969
ABPL 702835 Post-Renaissance Architecture the High Renaissance COMMONWEALTH OF AUSTRALIA Copyright Regulations 1969 Warning This material has been reproduced and communicated to you by or on behalf of the University of Melbourne pursuant to Part VB of the Copyright Act 1968 (the Act). The material in this communication may be subject to copyright under the Act. Any further copying or communication of this material by you may be the subject of copyright protection under the Act. do not remove this notice the adv ent of the High Renaissance c 1500-1530 conclusion of the exploratory phase of Brunelleschi & Alberti establishment of a consistent classical langgguage many more architects involved, notably DtBDonato Braman te focus shifts from Florence to Milan to Rome Palazzo Medici (so-called Banco Mediceo), Milan, c 1455-60, probably by Michelozzo Il Filarete, treatise on architecture, Biblioteca Nazionale, Florence Castello Sforzesco [Sforza-Visconti castle], Milan, c 1450-1499 : corner tower, probably by Bramante, c 1492-6 Argus fresco in the Sala di Tesoro, by Bramante, c 1490s Fine Arts, 172/ M637/ 3sv; 75-168; Bruschi, Bramante, p 53 Donato Bramante Donato (or Donnino) de Angelo di Antonio ?1444-1514 born near Urbino a painter, then an architect practised in Milan, then Rome developed a more urbane classical style fresco of Democritus and Heraclitus , formerly in the painted room, Casa Panigarola, Milan, by Bramante, c 1490 Fine Arts, 372/ B195/ 1490/ 7dh 'Ru ine d temp le ', by Braman te, engraved by Bernardo Prevedari, 1481; reconstructed -

Contributo a Una Bibliografia Dei Palazzi Privati Di Milano Dal Xiv Secolo All’Età Neoclassica
Edizioni presenti nella Biblioteca Centrale/ www.comune.milano.it/sbm CONTRIBUTO A UNA BIBLIOGRAFIA DEI PALAZZI PRIVATI DI MILANO DAL XIV SECOLO ALL’ETÀ NEOCLASSICA Il contributo consta di due sezioni: una bibliografia generale e una bibliografia relativa ai singoli palazzi. Si è preferito disporre la bibliografia generale in ordine alfabetico, invece che secondo il più usuale ordinamento cronologico, per facilitare la ricerca delle fonti per autore. L'ordinamento cronologico è stato invece mantenuto all'interno delle schede bibliografiche concernenti i singoli palazzi. Il riferimento geografico della ricerca è all’intera area dell’attuale comune di Milano. Per quel che concerne gli edifici all’interno della cerchia delle mura spagnole si è rispettata l’antica suddivisione amministrativa in sestieri, corrispondenti alle sei porte munite. All’interno di ognuno dei sestieri, i singoli palazzi sono riportati secondo un ordine “di prossimità”, seguendo un itinerario ideale. Per quel che riguarda invece l’area extra muraria è stata ripresa la suddivisione, dove possibile, secondo gli antichi borghi ordinati alfabeticamente. I contributi che, per l'ampiezza della trattazione o per l'importanza delle notizie riportate, costituiscono la base di riferimento per le ricerche sono riportati in extenso nelle singole schede bibliografiche dei palazzi. Le opere che invece non hanno come argomento monografico l’edificio stesso, sono citate sommariamente col cognome dell’autore principale e la data di edizione, rimandando alla bibliografia generale, dove è stata anche contrassegnata da una lettera s in grassetto la presenza del titolo nelle raccolte della Biblioteca comunale centrale. L’indicazione dei fondi archivistici, riportata nelle schede bibliografiche dei singoli palazzi, deriva da altre bibliografie e non ha pertanto alcuna pretesa di completezza.