Italy - Rural Development Programme (Regional) - Liguria
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

IL TERRITORIO La Via Marenca
IL TERRITORIO La Via Marenca Rezzo si trova nel cuore della Valle Arroscia. Questa valle e quelle confinanti, le Valli Argentina, Impero, Maro e Prelà, sono attraversate dalla Via Marenca, una direttrice con numerose diramazioni che, seguendo i crinali, raggiunge la costa. Questa porzione di territorio incastonata fra Piemonte e Liguria è molto varia dal punto di vista climatico: si passa dal clima alpino delle vette a quello spiccatamente mediterraneo della costa. Grazie all’effetto mitigante del mare, tuttavia, anche l’entroterra presenta un tipo di vegetazione mediterranea, e non è raro trovare, anche sulle vette più alte, lavanda e timo, e ad altitudini vicine ai 1000 metri lecci e altre tipiche forme vegetali della macchia. Il monte Saccarello (2200 m.) è la cima più alta dell’intera Liguria e offre al visitatore spettacoli naturali estremamente suggestivi: la cima, circondata da pascoli alpini, si colora di un rosso intenso in primavera, quando sbocciano i rododendri. Lungo i versanti, discendendo verso il mare, si susseguono boschi di larici e pini silvestri, faggi (di cui il bosco di Rezzo è, appunto, uno degli esempi più suggestivi), roverelle, carpini, pini marittimi, olmi e castagni. Per effetto della varietà climatica e ambientale, la fauna è altrettanto ricca: camosci, cinghiali, volpi, faine, donnole, tassi, ricci, ghiri e talpe, gufi reali, qualche esemplare di picchio nero, ormai poco diffuso, salamandre e, nelle vicinanze di corsi d’acqua, grotte e anfratti, geotritoni. Avvicinandosi alla costa, il paesaggio naturale muta e i boschi lasciano il posto alle coltivazioni di alberi da frutto, vigneti e in particolare oliveti. Nel tratto finale, in prossimità del mare, le coltivazioni dell’olivo sono alternate a vere e proprie macchie cromatiche di vegetazione mediterranea, nelle quali spiccano la ginestra, il lentisco, il mirto, l’oleastro e il pino d’Aleppo. -

Sui Sentieri Di Sanremo & Ospedaletti
Marco PUKLI SUI SENTIERI DI SANREMO & OSPEDALETTI GUIDA ESCURSIONISTICA Itinerari scelti Riviera dei Fiori: Alpi Liguri Catena del Saccarello Costiera Ceppo Bignone Copyright © Marco Pukli 2015 - Tutti i diritti e i doveri riservati. Versione 1.3.0 2 Introduzione Questo libretto propone una serie di itinerari escursionistici nell’entroterra di Sanremo e di Ospedaletti. Alcuni di questi percorsi sono molto conosciuti dagli appassionati, altri un po’ meno. Spero che ognuno possa trovarvi uno spunto, un’idea, per organizzare una bella gita, tenendo conto che, oltre a quelli descritti, nella zona sono ancora molti i percorsi da scoprire, e resta tanto spazio libero per la fantasia di ognuno. Lo scopo principale, forse l’unico scopo di questo lavoro, corrisponde a un’illusione: tentare di trasferire sulla carta, di comunicare, qualche emozione nata proprio grazie alle passeggiate nella natura del nostro entroterra. Ovviamente non ci sono riuscito, poiché le emozioni sono una faccenda troppo impalpabile, intima, del tutto personale; ognuno può tentare di farsi capire, ma in fondo ognuno può sentire le proprie emozioni solamente vivendosele direttamente sulla propria pelle. La natura dell’entroterra ligure è un mondo, un ambiente, che vale la pena di conoscere, che per certi versi è necessario conoscere. Perché camminare su questi sentieri, oggi, oltre a consentirci di vivere esperienze sportive nella natura, di svago, di piacere personale, rappresenta un legame con una cultura alla quale apparteniamo, e che ci appartiene. Ma c’è di più. Camminare in montagna a volte offre l’opportunità di vivere esperienze che altrimenti sarebbero inaccessibili. Può capitare di vivere degli strani momenti, per esempio di farsi sorprendere da un odore particolare, da un profumo, che può essere di muschio, o forse di erba bagnata, che risveglia in noi una sensazione indefinibile, un’intuizione di un qualcosa che pensavamo perduto, o di cui forse non eravamo nemmeno mai stati coscienti. -

Curriculum Vitae
Curriculum Vitae Informazioni personali Nome/ Cognome Agr. Dott. Fabiano Sartirana Indirizzo Via Don Minzoni 14,18100 Imperia Telefono Partita IVA: 01578670083 Email [email protected] PEC: [email protected] Cittadinanza Italiana Società: Ce.S.Bi.N. srl - www.cesbin.it (socio) Data di nascita Sesso Maschile Albo professionale - Albo professionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati – Collegio Provinciale di Imperia Iscritto n°185 - Consigliere Provinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Imperia (2015-2019 e 2019-2023) - Membro della Consulta Nazionale degli Ambientologi e dei Naturalisti presso il Collegio Nazionale degli Agrotecnici (Rappresentante del Collegio di Imperia) - Presidente della Federazione degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati della Regione Liguria (dal 2020) - Associazione Italiana delle Guide Ambientali Escursionistiche – Iscritto n°LI165 Settore Dal 2012 svolgo la libera professione ed ho lavorato come dipendente (tempo determinato) professionale nei seguenti settori: 1. Naturalista ed Ornitologo (redazione di studi di incidenza, monitoraggi avifaunistici, indagini faunistiche, coordinamento di attività di monitoraggio naturalistico, predisposizione di piani di gestione di siti Natura 2000 e di aree protette, stesura di testi scientifici e divulgativi e attività di docenza specialistica) -> pag. 2 2. Agrotecnico laureato e Progettista (progettazione, attività di coordinamento e di rendicontazione 3. di Progetti INTERREG-ALCOTRA, PSR e FSR regionali, attività ispettiva per controlli AGEA 4. sulle misure PSR e PAC, istruttorie per ispettorato agrario per misure PSR, progettazione 5. e mappatura di percorsi escursionistici e stesura di testi descrittivi per depliant, pannelli e cartine) -> pag. 25 6. Guida ambientale ed escursionistica e Educatore ambientale 7. (attività di accompagnamento di gruppi e scolaresche e attività di educazione ambientale 8. -

La Popolazione Residente Al Censimento in Un
POPOLAZIONE PER LOCALITA’ ABITATA NEI COMUNI LIGURI AL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 2001 Per una migliore comprensione dei dati si riportano le definizioni dei termini statistici indicati nelle tabelle. La Popolazione residente al Censimento in un comune è costituita dalle persone aventi dimora abituale nel comune anche se alla data del Censimento erano assenti, perché temporaneamente presenti in altro comune italiano o all’estero. Per località abitata si intende un’area più o meno vasta di territorio, conosciuta di norma con un nome proprio, sulla quale sono situate una o più case raggruppate o sparse. Si distinguono tre tipi di località abitate: - il centro abitato: formato da un aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, caratterizzato dall’esistenza di servizi o esercizi pubblici, costituenti la condizione per una forma autonoma di vita sociale; - il nucleo abitato: costituito da un gruppo di case contigue o vicine, con interposte strade, piazze, aie e simili, purchè l’intervallo tra casa e casa non superi i trenta metri, con almeno cinque famiglie e senza servizi o esercizi pubblici; - le case sparse: si tratta di case disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato. Tabelle: 1. Popolazione per località abitata nei comuni della provincia di IMPERIA – Censimento Generale della Popolazione 2001 2. Popolazione per località abitata nei comuni della provincia di SAVONA – Censimento Generale della Popolazione 2001 3. Popolazione per -
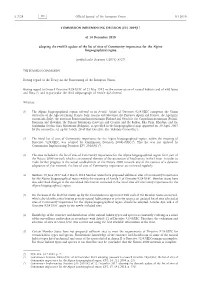
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2019/17 of 14
L 7/28 EN Official Journal of the European Union 9.1.2019 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2019/17 of 14 December 2018 adopting the twelfth update of the list of sites of Community importance for the Alpine biogeographical region (notified under document C(2018) 8527) THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (1), and in particular the third subparagraph of Article 4(2) thereof, Whereas: (1) The Alpine biogeographical region referred to in Article 1(c)(iii) of Directive 92/43/EEC comprises the Union territories of the Alps (Germany, France, Italy, Austria and Slovenia), the Pyrenees (Spain and France), the Apennine mountains (Italy), the northern Fennoscandian mountains (Finland and Sweden), the Carpathian mountains (Poland, Romania and Slovakia), the Dinaric Mountains (Slovenia and Croatia) and the Balkan, Rila, Pirin, Rhodope and the Sashtinska Sredna Gora Mountains (Bulgaria), as specified in the biogeographical map approved on 20 April 2005 by the committee set up by Article 20 of that Directive (the ‘Habitats Committee’). (2) The initial list of sites of Community importance for the Alpine biogeographical region, within the meaning of Directive 92/43/EEC, was adopted by Commission Decision 2004/69/EC (2). That list was last updated by Commission Implementing Decision (EU) 2018/42 (3). (3) The sites included in the list of sites of Community importance for the Alpine biogeographical region form part of the Natura 2000 network which is an essential element of the protection of biodiversity in the Union. -

Regione Liguria
REGIONE LIGURIA Daniela Minetti Settore Parchi e Biodiversità Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro Regione Liguria Regione Liguria: salvaguardia e tutela attiva Contesto . Elevata biodiversità: 3 regioni bioclimatiche Alpina, Mediterranea regionale e Continentale + il Mare . 125 Siti di Interesse Comunitario (ZSC), 26 dei quali in ambito marino e 7 Zone di Protezione Speciale (ZPS) per la tutela degli uccelli selvatici. Politiche e strumenti in atto: Formulario standard; Libioss; Carta degli habitat, Misure di conservazione; Piani di gestione, Vinca Contesto regionale o Foreste, terreni agricoli e praterie rappresentano rispettivamente il 64,9%, il 12,4% e il 2,1% del totale territorio della Regione Liguria (relazione annuale di attuazione PSR 2016). o Le foreste liguri continuano a crescere: dal 2005 al 2013, l'area forestale regionale è passata da circa 22.700 ettari a quasi 400.000 ettari. Questo fenomeno è di solito a scapito di collina e pascoli montani e aree agricole, anch'essi in contrazione a causa del continuo abbandono di attività rurali (Rapporto sullo stato delle foreste in Liguria nel periodo 2011-2013). Avere così tante foreste in crescita un tesoro eccezionale, ma, allo stesso tempo, costituisce una potenziale minaccia per la Rete Natura 2000 Contesto regionale BOSCO E ALTRE TERRE BOSCATE Fonte Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi di carbonio (INFC) - Anno 2005 Distretto territoriale Bosco Altre terre boscate Superficie forestale Superficie Indice di Posizione per estensione totale territoriale boscosità assoluta della superficie boscata Liguria 339.107 36.027 375.134 542.024 69,21 13 Trentino 375.402 32.129 407.531 620.690 65,66 11 Sardegna 583.472 629.778 1.213.250 2.408.989 50,36 1 Alto Adige 336.689 35.485 372.174 739.997 50,29 14 Toscana 1.015.728 135.811 1.151.539 2.299.018 50,09 2 Umbria 371.574 18.681 390.255 845.604 46,15 12 Friuli V.G. -

GITE G.E.S. Dal 1965 Al 2016 S/A = Sci / Alpinistica - CIA = Ciaspole N° DESCRIZIONE LOCALITA' DATA N
GITE G.E.S. dal 1965 al 2016 S/A = Sci / Alpinistica - CIA = Ciaspole N° DESCRIZIONE LOCALITA' DATA n. Pers. Tipo G.G. 1 ACQUEDOTTO STORICO di GENOVA 08/02/2015 21 2 ACQUEDOTTO STORICO di GENOVA 1° Parte 25/09/2011 14 3 ACQUEDOTTO STORICO di GENOVA 2° Parte 20/11/2011 29 4 ALASSIO - MADONNA DELLA GUARDIA 04/02/2001 20 5 ALASSIO - MONTE BIGNONE - ALBENGA 30/11/2003 17 6 ALASSIO - POGGIO BREA - ALASSIO 23/01/2005 42 7 ALBENGA - ALASSIO 12/01/2003 28 8 ALBENGA - ALASSIO 17/01/2010 28 9 ALBENGA - ALASSIO (Via Martiri della Libertà) 24/03/1991 12 10 ALBENGA - ALASSIO (Via Martiri della Libertà) 14/01/1996 27 11 ALBISOLA SUPERIORE - BRIC GENOVA (Anello) 10/11/2013 23 12 ALPICELLA - MONTE BEIGUA - MONTE PRIAFIA 30/03/2008 44 13 ALTARE - QUILIANO 19/11/2006 17 14 ALTIPIANO delle MANIE - GROTTA dell'ARMA 21/03/1976 12 15 ALTOPIANO del FINALESE (CALVISIO-San Cipriano-Bric Reseghe) 22/12/1985 24 16 ALTOPIANO DELLE CONCHE (ORCO - SAN LORENZINO) 05/12/1982 35 17 ALTOPIANO DELLE MANIE (Polentata Sociale) 09/11/1983 48 18 ALTURE di BOGLIASCO - NERVI (M.Bado-M.Becco-M.Cardona) 08/04/1984 31 19 AMEGLIA - MONTE MARCELLO - LERICI 26/03/2006 39 20 ANDORA - CAPO MELE BIRDWATCHING 21/03/1999 17 21 ANELLO BARBARESCO (LANGHE) 13/10/2013 28 22 ANELLO DI GIUTTE (MONTE PENNELLO) 14/10/2001 13 23 ANELLO RIO FERRAIA 12/08/2012 10 24 ANELLO SAN PIETRO D'ORBA (Alla ricerca dell'ORO) 30/05/2004 44 25 ANELLO VARIGOTTI 14/04/2013 25 26 ANTICO SENTIERO DEL FIENO SANMARTINO 03/02/2013 37 27 ARENZANO - PASSO DELLA GAVA 13/05/2007 23 28 ARMA STRAPATENTE (ORCO FEGLINO) 02/12/2001 17 29 ARMA STRAPATENTE (ORCO FEGLINO) 25/01/2009 42 30 ARTESINA (Pulman Frabosa S.na) 29/11/1968 33 31 ARTESINA (Pulman) 08/02/1970 30 S/A 32 ARTESINA (Pulman) 22/03/1970 17 S/A 33 ARTESINA-Cima DURAND-Colla BAUSANO-ARTESINA 21/02/2016 13 CIA 34 BADIA DI TIGLIETO 07/11/2004 42 35 BAGNASCO (F.S. -

Decisión De Ejecución (UE) 2019/17 De La Comisión, De 14 De Diciembre
L 7/28 ES Diario Oficial de la Unión Europea 9.1.2019 DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/17 DE LA COMISIÓN de 14 de diciembre de 2018 por la que se adopta la duodécima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica alpina [notificada con el número C(2018) 8527] LA COMISIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Vista la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (1), y en particular su artículo 4, apartado 2, párrafo tercero, Considerando lo siguiente: (1) La región biogeográfica alpina a que se refiere el artículo 1, letra c), inciso iii), de la Directiva 92/43/CEE incluye los territorios, en la Unión, de los Alpes (Alemania, Francia, Italia, Austria y Eslovenia), los Pirineos (España y Francia), los Apeninos (Italia), las montañas fenoescandinavas septentrionales (Finlandia y Suecia), los Cárpatos (Polonia, Rumanía y Eslovaquia), los Alpes Dináricos (Croacia y Eslovenia) y los montes Balcanes, Rila, Pirin, Ródope y Sashtinska Sredna Gora (Bulgaria), según se especifica en el mapa biogeográfico aprobado el 20 de abril de 2005 por el Comité creado en virtud del artículo 20 de la citada Directiva (el «Comité de Hábitats»). (2) La lista inicial de lugares de importancia comunitaria para la región biogeográfica alpina, a tenor de la Directiva 92/ 43/CEE, se adoptó mediante la Decisión 2004/69/CE de la Comisión (2). La última actualización de esa lista se realizó mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2018/42 de la Comisión (3). -

COMMISSION DECISION of 12 December 2008 Adopting, Pursuant
13.2.2009 EN Official Journal of the European Union L 43/21 COMMISSION DECISION of 12 December 2008 adopting, pursuant to Council Directive 92/43/EEC, a second updated list of sites of Community importance for the Alpine biogeographical region (notified under document number C(2008) 7973) (2009/91/EC) THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, region is necessary in order to include additional sites that have been proposed since 2006 by the Member States as Having regard to the Treaty establishing the European Commu- sites of Community importance for the Alpine biogeo- nity, graphical region within the meaning of Article 1 of Directive 92/43/EEC. The obligations resulting from Articles 4(4) and 6(1) of Directive 92/43/EEC are applicable Having regard to Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 as soon as possible and within six years at most from the on the conservation of natural habitats and of wild fauna and adoption of the second updated list of sites of Community flora (1) and in particular the third subparagraph of Article 4(2) importance for the Alpine biogeographical region. thereof, Whereas: (6) On the other hand, the second update of the list of sites of (1) The Alpine biogeographical region referred to in Arti- Community importance for the Alpine biogeographical cle 1(c)(iii) of Directive 92/43/EEC comprises the Commu- region is necessary in order to reflect any changes in site nity territory of the Alps (Austria, Italy, Germany, France related information submitted by the Member States and Slovenia), the Pyrenees (France and Spain), the following the adoption of the initial and the first updated Apennine mountains (Italy), the northern Fennoscandian Community lists. -

PTERIDOPHYTA Aspleniaceae Dennstaedtiaceae Dryopteridaceae
CHECK-LIST DELLA FLORA SPONTANEA NOTEVOLE NEL PARCO DELLE ALPI LIGURI Questo è un elenco, in ordine alfabetico per famiglia, delle principali specie vegetali autoctone osservabili all’interno del territorio del Parco delle Alpi Liguri. La scelta delle specie, in un complesso più ampio, è avvenuta tenuto conto dei seguenti criteri: 1) particolare valenza estetica/culturale; 2) rarità nell’ambito del Parco e/o regionale, nazionale; 3) endemismo o subendemismo; 4) protezione a livello regionale e/o comunitario; 5) pianta dominante e/o caratteristica all’interno di almeno uno dei principali habitat censiti nel Parco. Autore del censimento: Dottore Forestale Marco Alberti PTERIDOPHYTA Aspleniaceae Asplenium ceterach L. subsp ceterach (Cedracca comune). Fessure, muri, detriti. In tutto il territorio del Parco. Asplenium fontanum (l.) Bernh. (Asplenio delle fonti). Rupi calcaree umide e ombrose. In tutto il territorio del Parco. Asplenium ruta-muraria L. subsp. dolomiticum Lovis et Reichst. (Asplenio ruta di muro). Fessure, rupi, detriti. Monte Pietravecchia, Monte Toraggio. Asplenium ruta-muraria L. subsp. ruta-muraria (Asplenio ruta di muro). Fessure, rupi, detriti. In tutto il territorio del Parco. Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey (Asplenio tricomane). Rocce, muri, detriti. In tutto il territorio del Parco. Asplenium viride Hudson (Asplenio verde). Rupi, muri, detriti. In tutto il territorio del Parco. Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum (L.) Kuhl subsp. aquilinum (Felce aquilina). Boschi radi, brughiere, incolti. In tutto il territorio del Parco. Dryopteridaceae Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray (Felce dilatata). Boschi umidi e ombrosi, ruscelli. In tutto il territorio del Parco. Dryopteris expansa (C.Presl.) Fraser-Jenk. et Jermy (Felce espansa). Fessure, boschi, pietraie, praterie. -

GEOGRAPHICAL OUTLINE the Via Marenca
GEOGRAPHICAL OUTLINE The Via Marenca Rezzo lies in the heart of the Valle Arroscia. This valley and the neighbouring valleys like Argentina, Impero, Maro and Prelà, are crossed by the Via Marenca, a mountain path that, following the ridges of the mountains, leads to the coast. These territories go through a great variety of climatic zones: the peaks have a mountain climate, whereas the coast is characterised by a Mediterranean climate. Thanks to the tempering action of the sea, though, the inland is characterised by the typical Mediterranean vegetation. Even on the highest peaks is not unusual to find holm-oaks and bushes of lavender and thyme as well as other typical plants of maquis that thrive even at altitudes of about 1000 metres. One of the most wonderful and charming sight opens before the eyes of the hiker who reaches the Monte Saccarello (2200 m.), the highest Ligurian peak. It is completely surrounded by alpine grazing lands and during the spring expanses of rhododendrons in bloom paint it blazing red. Descending from its peak in direction of the sea, mountain slopes covered with larches, Scotch firs and beeches (of which the beech wood of Rezzo is indeed one of the most fascinating epitomes), downy oaks, hornbeams, cluster pines, elms and chestnuts follow one another. Owing to this variety of landscapes and climatic zones, the fauna is rich in species as well: chamois, wild boars, foxes, beech martens, weasels, badgers, hedgehogs, dormice, moles, eagle owls, great black woodpeckers, now little spread, salamanders and, especially close to streams, caves and anfractuosities, newts. -

BS ALPI LIGURI Ultima Versione
1 BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2011 Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri 2 A cura di In collaborazione con 3 INDICE IDENTITÀ.............................................................................................................................................................................5 La CARTA D’IDENTITÀ del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri ................................................................................6 La STORIA del Parco..........................................................................................................................................................12 La MISSIONE del Parco Regionale delle Alpi Liguri ........................................................................................................... 13 La RETE DELLE RELAZIONI: gli interlocutori del Parco ...................................................................................................... 15 ORGANIZZAZIONE E RISORSE...........................................................................................................................................17 L’ENTE PARCO: per una gestione integrata del territorio.................................................................................................18 GLI ORGANI DELL’ENTE PARCO REGIONALE DELLE ALPI LIGURI.......................................................................................18 POLITICHE ORGANIZZATIVE: LE PRIORITÀ STRATEGICHE .................................................................................................22