Il Caso Corvetto
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

L'immaginario Devoto Tra Mafie E Antimafia
L’immaginario devoto tra mafie e antimafia 1. Riti, culti e santi a cura di Tommaso Caliò e Lucia Ceci viella sanctorum SANCTORUM. SCRITTURE, PRATICHE, IMMAGINI 1 collana diretta da Alessandra Bartolomei Romagnoli, Tommaso Caliò, Luigi Canetti, Umberto Longo, Raimondo Michetti, Francesca Sbardella, Elena Zocca L’immaginario devoto tra mafie e antimafia 1. Riti, culti e santi a cura di Tommaso Caliò e Lucia Ceci viella Copyright © 2017 - Viella s.r.l. Tutti i diritti riservati Prima edizione in pdf: aprile 2017 ISBN 978-88-6728-838-0 pdf In copertina: immagine tratta dalla graphic novel di Igort 5 è il numero perfetto (Coconino Press, 2002) per gentile concessione dell’autore. viella libreria editrice via delle Alpi, 32 I-00198 ROMA tel. 06 84 17 758 fax 06 85 35 39 60 www.viella.it Indice TOMMASO CALIÒ, LUCIA CECI Introduzione 9 PIETRO GRASSO Come può un mafioso dichiararsi cristiano? 13 LUIGI CIOTTI Da don Sturzo a papa Francesco. La Chiesa di fronte alla questione mafiosa 17 MANOELA PATTI Compari di san Giovanni. Matrimoni e battesimi nella mafia dell’agro palermitano negli anni Venti 29 GIANLUCA FULVETTI Sicilia inizio anni Sessanta. I frati di Mazzarino, la mafia, la Chiesa 43 ROSSELLA MERLINO «Papi, cupole e mandarini tardivi». Religiosità e identità nelle parole del boss Michele Greco 61 GIORGIO ADAMO Il rapporto tra gerarchie ecclesiastiche e devozione popolare in Calabria. Un resoconto etnografico e qualche considerazione 83 ROSSANA BARCELLONA, TERESA SARDELLA La festa di Sant’Agata tra devozione popolare, strumentalizzazioni criminali, ambiguità istituzionali e impegno civile (2008-2014) 99 6 L’immaginario devoto tra mafie e antimafia DEBORAH PUCCIO-DEN Di sangue e d’inchiostro. -

STRUTTURE Cosa Nostra E 'Ndrangheta a Confronto
STRUTTURE Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto Francesco Gaetano Moiraghi Andrea Zolea WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea La mafia dura da decenni: un motivo ci deve essere. Non si può andare contro i missili con arco e frecce: in queste vicende certe intemperanze si pagano duramente. Con il terrorismo, con il consenso sociale, potevi permettertele: con la mafia non è così. Nella società c’è un consenso distorto. Altro che bubbone in un tessuto sociale sano. Il tessuto non è affatto sano. Noi estirperemo Michele Greco, poi arriverà il secondo, poi il terzo, poi il quarto. Giovanni Falcone 1 www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea PREMESSA Questo lavoro ha lo scopo di offrire uno sguardo d’insieme sulle articolazioni strutturali delle organizzazioni mafiose denominate Cosa nostra e ‘ndrangheta . La prima sezione, curata da Francesco Gaetano Moiraghi, si concentra sull’analisi di Cosa nostra. La seconda sezione, che sposta il focus sulla ‘ndrangheta, è curata da Andrea Zolea. Come si potrà notare, le due sezioni non sono state realizzate secondo uno stesso modello, ma analizzano le due organizzazioni con un approccio differente. Ad esempio, la parte su Cosa nostra avrà un orientamento maggiormente diacronico, diversamente da quella sulla ‘ndrangheta, basata su un approccio sincronico. Il presente testo ha infatti l’obiettivo di offrire due proposte di analisi differenti che riescano a mettere in luce le analogie e le differenze delle strutture delle due organizzazioni mafiose. -

Organized Crime and Electoral Outcomes. Evidence from Sicily at the Turn of the XXI Century
Organized Crime and Electoral Outcomes. Evidence from Sicily at the Turn of the XXI Century Paolo Buonanno,∗ Giovanni Prarolo (corresponding author),y Paolo Vaninz November 4, 2015 Abstract This paper investigates the relationship between Sicilian mafia and politics by fo- cusing on municipality-level results of national political elections. It exploits the fact that in the early 1990s the Italian party system collapsed, new parties emerged and mafia families had to look for new political allies. It presents evidence, based on disaggregated data from the Italian region of Sicily, that between 1994 and 2013 Silvio Berlusconi’s party, Forza Italia, obtained higher vote shares at national elec- tions in municipalities plagued by mafia. The result is robust to the use of different measures of mafia presence, both contemporary and historical, to the inclusion of different sets of controls and to spatial analysis. Instrumenting mafia’s presence by determinants of its early diffusion in the late XIX century suggests that the correla- tion reflects a causal link. Keywords: Elections, Mafia-type Organizations JEL codes: D72, H11 ∗Department of Economics, University of Bergamo, Via dei Caniana 2, 24127 Bergamo, Italy. Phone: +39- 0352052681. Email: [email protected]. yDepartment of Economics, University of Bologna, Piazza Scaravilli 2, 40126 Bologna, Italy. Phone: +39- 0512098873. E-mail: [email protected] zDepartment of Economics, University of Bologna, Piazza Scaravilli 2, 40126 Bologna, Italy. Phone: +39- 0512098120. E-mail: [email protected] 1 1. Introduction The relationship between mafia and politics is a crucial but empirically under-investigated issue. In this paper we explore the connection between mafia presence and party vote shares at national political elections, employing municipality level data from the mafia-plagued Italian region of Sicily. -

Investigating Italy's Past Through Historical Crime Fiction, Films, and Tv
INVESTIGATING ITALY’S PAST THROUGH HISTORICAL CRIME FICTION, FILMS, AND TV SERIES Murder in the Age of Chaos B P ITALIAN AND ITALIAN AMERICAN STUDIES AND ITALIAN ITALIAN Italian and Italian American Studies Series Editor Stanislao G. Pugliese Hofstra University Hempstead , New York, USA Aims of the Series This series brings the latest scholarship in Italian and Italian American history, literature, cinema, and cultural studies to a large audience of spe- cialists, general readers, and students. Featuring works on modern Italy (Renaissance to the present) and Italian American culture and society by established scholars as well as new voices, it has been a longstanding force in shaping the evolving fi elds of Italian and Italian American Studies by re-emphasizing their connection to one another. More information about this series at http://www.springer.com/series/14835 Barbara Pezzotti Investigating Italy’s Past through Historical Crime Fiction, Films, and TV Series Murder in the Age of Chaos Barbara Pezzotti Victoria University of Wellington New Zealand Italian and Italian American Studies ISBN 978-1-137-60310-4 ISBN 978-1-349-94908-3 (eBook) DOI 10.1057/978-1-349-94908-3 Library of Congress Control Number: 2016948747 © The Editor(s) (if applicable) and The Author(s) 2016 This work is subject to copyright. All rights are solely and exclusively licensed by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifi cally the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfi lms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. -

IL DOSSIER X
pagina 4 Giovedì 10 dicembre 2009 x IL DOSSIER x di Marco Lillo quello che volevamo e avevamo il paese le stragi del 1993 quando, mentre mette- stelle nel quale si organizzavano le prime Alla vigilia della deposizione dei capimafia, nelle mani. Mi disse che le persone che ci vano le bombe a Roma, Firenze e Milano, convention di Forza Italia. “B. ci ha dato E NON ARRIVA avevano dato garanzie erano serie, a uccidendo, giravano i posti più belli d’Italia Altri immobili per 50 milioni di euro sono stati niente da dove deve differenza dei socialisti, e mi fece i nomi di aiutati (magari involontariamente) da una confiscati a un altro referente dei Graviano, la sentenza di I° grado ricostruisce arrivare è il caso che Silvio Berlusconi e di Marcello Dell’Utr i”. I serie di personaggi legati aella famiglia quel Giuseppe Cosenza che è stato cliente cominciamo a parlare Graviano hanno già smentito le sue parole dell’ex manager di Publitalia, e attuale sot- dell'attuale presidente del senato, l'avvocato il Paese”: “Sanche noi con i magistrati”. Questa frase davanti ai pm di Firenze. Ora ci provano tosegretario Gianfranco Micciché, o in rap- Renato Schifani. Ai boss hanno sequestrato gli intrecci del braccio attribuita dal pentito Gaspare Spatuzza a quelli di Palermo, incuriositi dallo strano porti con Marcello Dell’Utri (ora senatore e anche un impianto da 5 milioni di euro adi- Filippo e Giuseppe Graviano, i suoi capi, atteggiamento dei due boss che non hanno allora capo di Publitalia). Quando si parla dei bito a torrefazione e zuccherificio. -

Download Clinton Email June Release
UNCLASSIFIED U.S. Department of State Case No. F-2014-20439 Doc No. C05761507 Date: 06/30/2015 RELEASE IN PART B6 From: H <[email protected]> Sent: Tuesday, December 15, 2009 12:25 PM To: '[email protected]' Subject: Fw: H: Memo, idea on Berlusconi attack. Sid Attachments: hrc memo berlusconi 121509.docx Pls print. Original Message From: sbwhoeop To: H Sent: Tue Dec 15 10:43:11 2009 Subject: H: Memo, idea on Berlusconi attack. Sid CONFIDENTIAL December 15, 2009 For: Hillary From: Sid Re: The Berlusconi assault 1. The physical attack on Italian Prime Minister Silvio Berlusconi is a major political event in Italy and Europe. His assailant is a mentally disturbed man without a political agenda who has been in and out of psychiatric care since he was 18 years old. Nonetheless, the assault has significant repercussions. It has generated sympathy for Berlusconi as a victim—he has been obviously injured, lost two teeth and a pint of blood, and doctors will keep him in the hospital for perhaps a week for observation. The attack comes as Berlusconi was beginning to lose political footing, having lost his legal immunity. One court inquiry is turning up evidence of his links to the Mafia while another is examining his role in the bribery case of British lawyer David Mills. Berlusconi's government and party have used the attack as a way to turn the sudden sympathy for him to his advantage, claiming that his opponents have sown a climate of "hate." Through demogogic appeals they are attempting to discredit and rebuff the legal proceedings against him and undermine the investigative press. -

Rapina E Raffiche Tra La Folla
IN ITALIA Due banditi uccisi e uno ferito a Novara dopo un drammatico inseguimento Chiedeva soldi «per i drogati» il falso don Picchi Rapina e raffiche tra la folla «Sono don Mario Picchi, so che c'è un giovane dalle vostre parti bisognoso d'aiuto, se gli date un centinaio di migliaia di lire poi provvedere io stesso a rimborsarvi con un asse Drammatico scontro a fuoco, a Novara, tra banditi circondai il quartiere stabi- gno»- si presentava cosi, per telefono, Loris Chinaglla, Momentl drammatiu anele knc'o, inoltre, una sene di po trentatreenne truffatore di Bolzano, che aveva organizzato e carabinieri, dopo un lungo inseguimento a folle un «giro» davvero niente male, spacciandosi per il celebre velocita, L'auto dei malviventi era stata intercettata durante I inseguimento dell u- sti di blocco all'esterno e al don Picchi (nella foto) che dirige il centro di riabilitazione dopo una rapina. I banditi non si erano fermati nico fuggiasco, avvenuto ini l'interno della città, ma fino al per tossicodipendenti di Roma. Poco dopo la sua telefona ali alt ma avevano subito iniziato una fitta sparato zialmente tra le bancarelle del laido pomenggio di ieri il ban ta, infatti, in casa di chi, di cuore buono, aveva acconsenti ria, I carabinieri hanno allora risposto al fuoco mercato, con scambio di col dito è riuscito a sfuggire a to a elargire le centomila, amvava il giovane «tossicodi pì di pistola tra gli inseguitori e qualsiasi ricerca effettuata an pendente» che nscuoteva. Lo Sherlock Holmes che ha uccidendo due dei rapinatori e ferendone un ter il bandito Un fuggi fuggi ge che con l'impiego di elicotte- avuto sentore di truffa e ha permesso di mettere le mani su zo. -

LE MENTI RAFFINATISSIME Di Paolo Mondani E Giorgio Mottola
1 LE MENTI RAFFINATISSIME Di Paolo Mondani e Giorgio Mottola Collaborazione Norma Ferrara, Alessia Pelagaggi e Roberto Persia Immagini Dario D’India, Alfredo Farina e Alessandro Spinnato Montaggio e grafica Giorgio Vallati GIUSEPPE LOMBARDO - PROCURATORE AGGIUNTO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Licio Gelli era il perno. Perché attraverso la P2 lui controllava i Servizi. GIANMARIO FERRAMONTI - EX POLITICO LEGA NORD Essere lontani da Cosa Nostra se si agisce in Sicilia è molto difficile. CONSOLATO VILLANI - COLLABORATORE DI GIUSTIZIA Dietro le stragi c'erano i servizi segreti deviati GIOACCHINO GENCHI - EX UFFICIALE POLIZIA DI STATO La principale intenzione era quella di non trovare i veri colpevoli. PIETRO RIGGIO - COLLABORATORE DI GIUSTIZIA - 19/10/2020 PROCESSO D'APPELLO TRATTATIVA STATO-MAFIA L'indicatore dei luoghi dove erano avvenute le stragi fosse stato Marcello Dell'Utri. ROBERTO TARTAGLIA – EX PM PROCESSO TRATTATIVA STATO-MAFIA Chi è che insegna a Salvatore Riina il linguaggio che abbina la cieca violenza mafiosa alla raffinata guerra psicologica di disinformazione che c’è dietro l'operazione della Fa- lange Armata? NINO DI MATTEO - MAGISTRATO PROCESSO TRATTATIVA - MEMBRO CSM È successo anche questo, scoprire che un presidente della Repubblica aveva mentito. SILVIO BERLUSCONI - EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Io su indicazione dei miei avvocati intendo avvalermi della facoltà di non rispondere. SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO Buonasera, parleremo del periodo stragista che va dal 1992 al 1994, della presunta trattativa tra Stato e Mafia. Lo faremo con documenti e testimonianze inedite, tra le quali quella di Salvatore Baiardo, l’uomo che ha gestito la latitanza dei fratelli Graviano, una potente famiglia mafiosa, oggi accusata di essere l’autrice della strage di via d’Ame- lio. -

Camorra: È Di Nuovo «Guerra» Ieri a Napoli Massacrati in 4
t f *T V 1>*S •" -^ ** *\7' •*! .,-«, _*. ^ * *«£, -*•- • F**JtX » - * ì • • *- *"* » •«.*•*-•>* - * -- f *•*•; PAG. 2 l'Unità ATTUALITÀ Sabato 3 aprile 1982 Ottaviano, dove finisce lo Stato Dopo l'assassinio di Semerari è finita la singolare «tregua» degli ultimi giorni 200 mila lire Camorra: è di nuovo «guerra» per un metro di terra Ieri a Napoli massacrati in 4 Salgono così a 88 le vittime dall'inizio dell'anno - Nel 1981, alla stessa data, i morti erano 51 - La «sorpresa» La metà per che Cutolo aveva preparato alla Nuova Famiglia per Pasqua e che doveva trasformarsi in un massacro Dalla nostra redazione Con questi quattro omicidi NAPOLI — Puntuale, come la «lista» dei «morti di morte sfondo anch'esso sanguino violenta» a Napoli e in pro un omicidio so del «misterioso» caso Se- vincia, si allunga — quest* merari-Cirillo, è arrivata u- anno - a 88. Lo scorso anno, n'altra strage delle Camorre. quando già si levavano alte Dopo quindici giorni di cal le grida d'allarme, erano (al ma, inspiegabilmente rispet la stessa data) solo 51. La *> \ «iv^KSOSK^^ VNV tata in questi ultimi giorni guerra tra le bande, che ave dell'affare Cirillo, è riesplosa va trovato una strana «pau :| la tempesta. In poco meno di sa» (la stessa registrata du ventiquattro ore altri quat rante i giorni del rapimento tro personaggi di media e Cirillo, a causa della presen piccola «taglia* nelle gerar za di un grosso spiegamento chie della criminalità orga di forze dell'ordine) negli ul nizzata, sono stati ammazza timi quindici giorni, è dun ti —anzi «massacrati» — a que ripresa con la «quotidia colpi di pistola e di lupara. -

Zerohack Zer0pwn Youranonnews Yevgeniy Anikin Yes Men
Zerohack Zer0Pwn YourAnonNews Yevgeniy Anikin Yes Men YamaTough Xtreme x-Leader xenu xen0nymous www.oem.com.mx www.nytimes.com/pages/world/asia/index.html www.informador.com.mx www.futuregov.asia www.cronica.com.mx www.asiapacificsecuritymagazine.com Worm Wolfy Withdrawal* WillyFoReal Wikileaks IRC 88.80.16.13/9999 IRC Channel WikiLeaks WiiSpellWhy whitekidney Wells Fargo weed WallRoad w0rmware Vulnerability Vladislav Khorokhorin Visa Inc. Virus Virgin Islands "Viewpointe Archive Services, LLC" Versability Verizon Venezuela Vegas Vatican City USB US Trust US Bankcorp Uruguay Uran0n unusedcrayon United Kingdom UnicormCr3w unfittoprint unelected.org UndisclosedAnon Ukraine UGNazi ua_musti_1905 U.S. Bankcorp TYLER Turkey trosec113 Trojan Horse Trojan Trivette TriCk Tribalzer0 Transnistria transaction Traitor traffic court Tradecraft Trade Secrets "Total System Services, Inc." Topiary Top Secret Tom Stracener TibitXimer Thumb Drive Thomson Reuters TheWikiBoat thepeoplescause the_infecti0n The Unknowns The UnderTaker The Syrian electronic army The Jokerhack Thailand ThaCosmo th3j35t3r testeux1 TEST Telecomix TehWongZ Teddy Bigglesworth TeaMp0isoN TeamHav0k Team Ghost Shell Team Digi7al tdl4 taxes TARP tango down Tampa Tammy Shapiro Taiwan Tabu T0x1c t0wN T.A.R.P. Syrian Electronic Army syndiv Symantec Corporation Switzerland Swingers Club SWIFT Sweden Swan SwaggSec Swagg Security "SunGard Data Systems, Inc." Stuxnet Stringer Streamroller Stole* Sterlok SteelAnne st0rm SQLi Spyware Spying Spydevilz Spy Camera Sposed Spook Spoofing Splendide -

La Tesi Camorra Non Spiega Tutto Nel Carcere Dove Cutolo Detta Legge
Sabato 3 aprile 1982 ATTUALITÀ l'Unità PAG. 3 Gli scritti inviati al boss Cutolo e alla segretaria Altre due lettere di Semerari Continua così l'oscura regia? La tesi camorra non spiega tutto Gli investigatori battono la pista delle bande criminali e sospettano don Raffaele - Un appunto del professore che, prima di essere assassinatoissinato, rinnega un'intervista — Contraddizioni — I probabili rapporti con Rotondi ASCOLI — Una panoramica del carcere Dal nostro inviato da Semerari come un uomo Cosa effettivamente Se selvaggiamente il professore poi procedere alla sanguino NAPOLI — Il professor Aldo di spiccata intelligenza, di e- merari affermi nelle due sono stati gli uomini dì Um sa esecuzione. Semerari probabilmente co levate capacità, un uomo ca missive non si sa. I carabi berto Ammattirò (clan della Ma non s'era detto che a Così vivono camorristi e terroristi ad Ascoli nosceva bene l'uomo chiave pace di persuadere e di tra nieri sono convinti, comun «Nuova Famiglia») o quelli di prelevare il professore dall' del «giallo-, l'ambiguo Luigi scinare la gente e che non que, che siano state scritte sì Raffaele Cutolo (clan della albergo di via Caracciolo e- Franco Rotondi. Semerari dovrebbe stare in carcere ma da Semerari, ma in assoluto «Nuova Camorra.)? Una rano stati gli uomini dì Am- era in buoni rapporti, al di là dovrebbe ricevere le cure di stato di costrizione. Insom chiave — si osserva — po maturo, il boss che aveva bi dei suoi interessi professio cui ha bisogno. Nell'appunto ma, lettere estorte, quasi det trebbe essere il messaggio al sogno, anche lui, di un refer nali, con il boss Raffaele Cu to medico? E l'assegno di due Nel carcere dove Cutolo Semerari accusa la Trapani tate. -
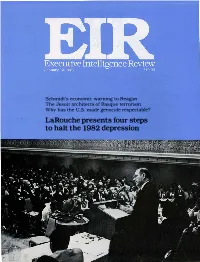
Executive Intelligence Review, Volume 9, Number 2, January 12, 1982
Schmidt's economic warning to Reagan The Jesuit architects of Basque terrorism Why has the U.S. made genocide respectable? LaRouche presents four steps to halt the 1982 depression EIR Executive Intelligence Review Special Reports The special reports listed below, prepared by the EIR staff, are now available. 1. Prospects for Instability in the Arabian Gulf 5. The Significance of the Shakeup at Pemex A comprehensive review of the danger of instabil EIR correctly forecast the political troubles of ity in Saudi Arabia in the coming period. Includes former Pemex director Jorge Diaz Serrano, and analysis of the Saudi military forces, and the in this report provides the full story of the recent fluence of left-wing forces, and pro-Khomeini net shakeup at Pemex.lncludes profile of new Pemex works in the country. $250. director Julio Rodolfo Moctezuma Cid, implica tions of the Pemex shakeup for the upcoming 2. Energy and Economy: Mexico in the Year 2000 presidential race, and consequences for Mexico's A development program for Mexico compiled energy policy. $200. jointly by Mexican and American scientists.Con cludes Mexico can grow at12 percent annually for 6. What is the Trilateral Commission? the next decade, creating a $100 billion capital The most complete analysis of the background, goods export market for the United States. De origins, and goals of this much-talked-about tailed analysis of key economic sectors; ideal for organization. Demonstrates the role of the com planning and marketing purposes. $250. mission in the Carter administration's Global 2000 report on mass population reduction; in the 3.