Tesi Dottorato Letizia Lonzi.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

1 '“Individualism” – a Word Unknown to Our Ancestors'
Notes 1 ‘“Individualism” – a Word Unknown to our Ancestors’ 1 Canons and Decrees of the Council of Trent: Original Text with English Translation, ed. H. J. Schroeder (St. Louis: B. Herder Book Co., 1941), pp. 214–17 and pp. 483–5. 2 Veronese’s trial is published in Philipp Fehl, ‘Veronese and the Inquisition: A Study of the Subject Matter of the So-Called Feast in the House of Levi’, Gazette des Beaux-Arts, ser. VI, 58 (1961): 348–54; English translation in Venice: A Documentary History, ed. David Chambers and Brian Pullan (Toronto: University of Toronto Press, 2001), pp. 232–6. 3 David Rosand, Painting in Sixteenth-Century Venice: Titian, Veronese, Tintoretto (Cambridge: Cambridge University Press, rev. edn 1997), p. 120 is correct to ask that we now call this work The Last Supper – a request that, thus far, has gone unheeded. 4 Jacob Burckhardt, The Civilization of the Renaissance in Italy, trans. S. G. C. Middlemore, 2 vols (New York: Harper & Row, 1958); for the original German, I have used Die Kultur der Renaissance in Italien, ed. Horst Günther (Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag, 1989). 5 Jacob Burckhardt, Der Cicerone: eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens (Leipzig: Alfren Kröner, 1927), pp. 932–5. 6 Burckhardt, Civilization of the Renaissance, vol. 1, p. 143 for both citations. 7 Among the more influential works inviting a rethinking of the history of the self – from antiquity to the twentieth century – see Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of Modern Identity (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989). 8 Douglas Biow, Doctors, Ambassadors, Secretaries: Humanism and Professions in Renaissance Italy (Chicago: University of Chicago Press, 2002), p. -

Tiziano 001-098
53 La “bottega” di Tiziano: sistema solare e buco nero Enrico Maria Dal Pozzolo Bottega? non sempre risolve le cose, che risultano spes- Partiamo da un caso alla ribalta proprio nei so assai più complesse di quanto una storia giorni di questo convegno1. dell’arte di impostazione sostanzialmente po- Il 6 aprile 2006 alla Christie’s di New York è sitivistica (che insegue prove, accumulando stata battuta la cosiddetta Madonna Molloy, dati e indizi che immette in una ricostruzione una Mater dolorosa che ha avuto una vicenda “logica” del problema) tenda a riconoscere, ed critica piuttosto in ombra nella letteratura ti- esistono casi specifici o fenomeni generali in zianesca (fig. 25)2. Ascritta al maestro, tra gli cui la griglia di inquadramento valutativo, per altri, da von Hadeln, Mayer e Suida, è caduta tenere, dovrà divenire necessariamente molto nel limbo a seguito delle espunzioni di Valca- flessibile, se addirittura non dovrà essere ri- nover, Wethey e Pallucchini, nei tre repertori messa in discussione in toto, ammettendo l’e- ragionati tizianeschi che dal 1969 continuano sistenza di coni d’ombra che oscurano il mi- a costituire la base di orientamento per gli stero sia della creazione individuale, sia della specialisti3. In seguito il catalogo di vendita produzione di “scuola”. Insomma, per esser registra solo il parere sospensivo (“Tiziano?”) chiari, bisognerà pur ammettere che il genio di Alessandro Ballarin, che però non conosce- non è sempre immenso e che il minore – va personalmente il pezzo4. oscuri collaboratori compresi – -
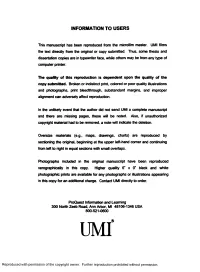
Information to Users
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy subm itted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6’ x 9" black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. ProQuest Information and Learning 300 North Zeeb Road. Ann Arbor, Ml 48106-1346 USA 800-521-0600 Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. NOTE TO USERS Copyrighted materials in this document have not been filmed at the request of the author. They are available for consultation at the author’s university library. -

LOCATING El GRECO in LATE SIXTEENTH-CENTURY
View metadata, citation and similarbroughtCORE papers to you at by core.ac.uk provided by Online Repository of Birkbeck Institutional Theses LOCATING El GRECO IN LATE SIXTEENTH‐CENTURY ROME: ART and LEARNING, RIVALRY and PATRONAGE Ioanna Goniotaki Department of History of Art, School of Arts Birkbeck College, University of London Submitted for the degree of Doctor of Philosophy, July 2017 -1- Signed declaration I declare that the work presented in the thesis is my own Ioanna Goniotaki -2- ABSTRACT Much has been written about the artistic output of Domenicos Theotocopoulos during his time in Spain, but few scholars have examined his works in Venice and even fewer have looked at the years he spent in Rome. This may be in part attributed to the lack of firm documentary evidence regarding his activities there and to the small corpus of works that survive from his Italian period, many of which are furthermore controversial. The present study focuses on Domenicos’ Roman years and questions the traditional notion that he was a spiritual painter who served the principles of the Counter Reformation. To support such a view I have looked critically at the Counter Reformation, which I consider more as an amalgam of diverse and competitive institutions and less as an austere movement that strangled the freedom of artistic expression. I contend, moreover, that Domenicos’ acquaintance with Cardinal Alessandro Farnese’s librarian, Fulvio Orsini, was seminal for the artist, not only because it brought him into closer contact with Rome’s most refined circles, but principally because it helped Domenicos to assume the persona of ‘pictor doctus’, the learned artist, following the example of another of Fulvio’s friends, Pirro Ligorio. -

Titian's Later Mythologies Author(S): W
Titian's Later Mythologies Author(s): W. R. Rearick Source: Artibus et Historiae, Vol. 17, No. 33 (1996), pp. 23-67 Published by: IRSA s.c. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1483551 . Accessed: 18/09/2011 17:13 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. IRSA s.c. is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Artibus et Historiae. http://www.jstor.org W.R. REARICK Titian'sLater Mythologies I Worship of Venus (Madrid,Museo del Prado) in 1518-1519 when the great Assunta (Venice, Frari)was complete and in place. This Seen together, Titian's two major cycles of paintingsof mytho- was followed directlyby the Andrians (Madrid,Museo del Prado), logical subjects stand apart as one of the most significantand sem- and, after an interval, by the Bacchus and Ariadne (London, inal creations of the ItalianRenaissance. And yet, neither his earli- National Gallery) of 1522-1523.4 The sumptuous sensuality and er cycle nor the later series is without lingering problems that dynamic pictorial energy of these pictures dominated Bellini's continue to cloud their image as projected -

Collaborative Painting Between Minds and Hands: Art Criticism, Connoisseurship, and Artistic Sodality in Early Modern Italy
Collaborative Painting Between Minds and Hands: Art Criticism, Connoisseurship, and Artistic Sodality in Early Modern Italy by Colin Alexander Murray A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of Art University of Toronto © Copyright by Colin Murray 2016 Collaborative Painting Between Minds and Hands: Art Criticism, Connoisseurship, and Artistic Sodality in Early Modern Italy Colin Alexander Murray Doctor of Philosophy Department of Art University of Toronto 2016 Abstract The intention of this dissertation is to open up collaborative pictures to meaningful analysis by accessing the perspectives of early modern viewers. The Italian primary sources from the fifteenth to the seventeenth centuries yield a surprising amount of material indicating both common and changing habits of thought when viewers looked at multiple authorial hands working on an artistic project. It will be argued in the course of this dissertation that critics of the seventeenth century were particularly attentive to the practical conditions of collaboration as the embodiment of theory. At the heart of this broad discourse was a trope extolling painters for working with what appeared to be one hand, a figurative and adaptable expression combining the notion of the united corpo and the manifold meanings of the artist’s mano. Hardly insistent on uniformity or anonymity, writers generally believed that collaboration actualized the ideals of a range of social, cultural, theoretical, and cosmological models in which variously formed types of unity were thought to be fostered by the mutual support of the artists’ minds or souls. Further theories arose in response to Giovanni Paolo Lomazzo’s hypothesis in 1590 that the greatest painting would combine the most highly regarded old masters, each contributing their particular talents towards the whole. -

Titian, ,A Singular Friend'
Originalveröffentlichung in: Kunst und Humanismus. Festschrift für Gosbert Schüßler zum 60. Geburtstag, herausgegeben von Wolfgang Augustyn und Eckhard Leuschner, Dietmar Klinger Verlag, Passau 2007, S. 261-301 CHARLES DAVIS Titian, ,A singular friend‘ A beautiful, if somewhat mysterious portrait painted by Tiziano Vecellio has found its ,last‘ home in the new world, in far away San Francisco, in a place, that is, which de- rives its name from a Spanish novel describing a paradisiacal island called California (figs. 1, 2, 3). Titian’s authorship of the portrait, now belonging to the San Francisco Art Museums and presently housed at the Palace of the Legion of Honor, is testified to by the painter’s signature, and it has never been questioned since the portrait first re- ceived public notice, belatedly, in 1844, when it appeared in the collection of the Mar- quis of Lansdowne. Less spectacular than some of Titian’s best known portraits, the portrait now in California nonetheless belongs to his finest portrayals of the men of his time. Several identifications have been proposed for the sitter, but none advanced with particular conviction. Although the nameless portrait testifies eloquently to the exi- stence of a noble man at rest, whose existence it indeed preserves and continues, his worldly identity remains an unresolved point of interest.1 The San Francisco Art Museums’ ,Portrait of a Gentleman‘ bear’s Titian’s signa- · ture in the inscription which the sitter holds. It reads unequivocally: D Titiano Vecel- lio / Singolare Amico. In all publications the inscription has been read: Di Tiziano sin- golare amico. -

López De Aragón Arte Antiguo
LÓPEZ DE ARAGÓN ARTE ANTIGUO GIROLAMO DENTE ALSO KNOWN AS GIROLAMO DI TIZIANO (C. 1510 - BEFORE 1572) THE FOUR SEASONS OIL ON CANVAS / 162 X 187 CM INSCRIPTION: HIEMO. D. TITIAN/N° 21 PROVENANCE: PARIS, CIRCA 1934; BUENOS AIRES, CIRCA 1990 The discovery of the Four Seasons by Girolamo Dente, almost a century after it was first recognised in a private collection in Paris, allows for reflection on one of the most faithful assistants of Titian (Tiziano Vecellio), who was born in Pieve di Cadore, around 1483/1485, and died in Venice in 1576. The inscription leaves no doubt about the identity of the author however it raises the question over its early provenance, that remains unresolved. All scholars agree on the attribution, but virtually no-one after Baron von Hadeln has been able to study the painting from live (1). The canvas has a thick herringbone texture, according to the Venetian tradition. The colours are fresh and reflect Titian’s palette. The painting is in very good condition. It is a fundamental starting point to research other paintings by “Girolamo di Tiziano”, who, like in this case, worked alone quite early, probably even outside his master’s atelier. Girolamo Dente was originally from the episcopal county of Cèneda, which is now a neighbourhood of Vittorio Veneto (2). The dioceses of Cèneda - also called Saint Titian, bishop of Oderzo, and till today subordinate to the Patriarchate of Aquileia- offered work to Venetian artists, especially to minor ones (3). Together with Belluno and Cadore, it was one of the Venetian territories most actively involved in a “simplified Tizianismo”(4). -

Geschichte Der Venezianischen Malerei. Bd. 4: Tizian Und Sein
Günter Brucher GESCHICHTE DER VENEZIANISCHEN MALEREI Bd. 4: Tizian und sein Umkreis 2015 BÖHLAU VERLAG WIEN ∙ KÖLN ∙ WEIMAR Veröffentlicht mit Unterstützung des Austrian Science Fund (FWF): PUB 255-V23 Gedruckt mit der Unterstützung durch: Amt der Steiermärkischen Landesregierung Stiftungs- und Förderungsgesellschaft der Paris-Lodron-Universität Salzburg © 2015 by Böhlau Verlag Ges.m.b.H & Co. KG, Wien Köln Weimar Wiesingerstraße 1, A-1010 Wien www.boehlau-verlag.com Umschlagabbildung: Tizian, Bacchanal der Andrier (Ausschnitt) © Madrid, Museo Nacional del Prado Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig. Umschlaggestaltung : Michael Haderer, Wien Satz : Michael Rauscher, Wien Druck und Bindung : Balto Print, Vilnius Gedruckt auf chlor- und säurefrei gebleichtem Papier Printed in the EU ISBN 978-3-205-79630-5 INHALTSVERZEICHNIS Tizian ..................................... 7 Früher Ruhm und Aufbruch zum eigenen Stil (1516–1530) ....... 14 Altarbilder ............................... 16 Andachtsbilder ............................. 50 Porträts ................................. 65 Mythologische Werke ......................... 77 1530–1540 ................................. 88 Porträts ................................. 91 Venus von Urbino ...........................105 Tempelgang Mariens ..........................109 1540–1547 .................................114 Dornenkrönung .............................117 Ecce Homo ...............................121 -
CAMUL Cop ING
Una lunga storia di vini dal 1936 The vineyards of our hills Wine has a long history with deep and noble roots. Through the centuries we learned that wine has been present during meals since the ancient time. Today this beverage plays an important role in our Mediterranean diet as well as the international food, giving us pleasant and new sensations. In Veneto a long enological culture established itself in a modern a brilliant way which interprets a glorious tradition. This culture is not only the preservation of its high quality levels, but also the skill to technically progress. 1 Vittorio Veneto - Museo della Battaglia - Cattedrale The destruction of Opitergium (today’s Oderzo) in 665 AD marked the rise of Langobards powerful duchy. The first bishop was elected in 713. Under Carlo Magno and the German Emperor Ottone I, the duchy became a county. In 1768, Venice brought the temporal power of the bishop-counts to an end. The palace of Ceneda was rebuilt after a fire in 1537/38; Jacopo Tatti called “il Sansovino” superintended the works, while Pomponio Amalteo frescoed the rooms of the palace. Today the palace houses the important Museo della Battaglia. Vittorio Veneto cathedral is dedicated to S.Maria Assunta and San Tiziano. It was built in neo-classical style between 1740 and 1773, following the plan of its architect Ottavio Scotti. 2 ® ROSSO DEL CAM L BARRELS REFINED (50% cabernet sauvignon, 50% pinot nero) View of the barrels in which our Camúl is refined VARIETY: 50% Cabernet Sauvignon, 50% Pinot Nero. The yield per hectare has been reduced to 80/90 quintals with a final 60/65% wine result, that in order to obtain a better quality product. -

Revealing the African Presence in Renaissance Europe Revealing the African Presence in Renaissance Europe
12.1mm 203mm revealing the african presence in renaissance europe presencerevealing the african in renaissance the walters art museum art the walters revealing the african presence in renaissance europe revealing the african presence in renaissance europe Revealing The Presence African Renaissance Europe edited by Joaneath Spicer contributions by Natalie Zemon Davis Kate Lowe Joaneath Spicer RevealingBen Vinson III revealing the african presence The Presencein renaissanceAfrican europe Renaissance the Europewalters art museum This publication has been generously supported by the Robert H. and Clarice Smith Publication Fund Published by the Walters Art Museum, Baltimore All rights reserved. © 2012 Trustees of the Walters Art Gallery No part of the contents of this book may be reproduced, Third printing, 2013 stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, including photocopy, recording, or other information and retrieval systems without the written permission of the Trustees of the Walters Art Gallery. This publication accompanies the exhibition Revealing All dimensions are in centimeters; height precedes width the African Presence in Renaissance Europe, held at the precedes depth unless otherwise indicated. Walters Art Museum from October 14, 2012, to January 21, The Walters Art Museum 2013, and at the Princeton University Art Museum from 600 North Charles Street February 16 to June 9, 2013. Baltimore, Maryland 21201 This exhibition is supported by a grant from the National thewalters.org Endowment for the Humanities and by an indemnity Produced by Marquand Books, Seattle from the Federal Council on the Arts and Humanities. marquand.com Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Designed and typeset by Susan E. -

Titiaan En De Nederlanden Een Wisselwerking?
TITIAAN EN DE NEDERLANDEN EEN WISSELWERKING? Aantal woorden: 23.700 Camille Marynissen Studentennummer: 01308230 Promotor: Prof. dr. Koenraad Jonckheere MasterproeF voorgelegd voor het behalen van de graad master in de richting Kunstwetenschappen Academiejaar: 2016 - 2017 1 2 3 De auteur en de promotor(en) geven de toelating deze studie als geheel voor consultatie beschikbaar te stellen voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van gegevens uit deze studie. Het auteursrecht betreffende de gegevens vermeld in deze studie berust bij de promotor(en). Het auteursrecht beperkt zich tot de wijze waarop de auteur de problematiek van het onderwerp heeft benaderd en neergeschreven. De auteur respecteert daarbij het oorspronkelijke auteursrecht van de individueel geciteerde studies en eventueel bijhorende documentatie, zoals tabellen en figuren. De auteur en de promotor(en) zijn niet verantwoordelijk voor de behandelingen en eventuele doseringen die in deze studie geciteerd en beschreven zijn. 4 Voorwoord Graag wil ik mijn promotor, Professor Dr. Koenraad Jonckheere, bedanken voor zijn begeleiding bij het schrijven van deze masterproef. De bachelorproef vormde een grondige basis om mijn masteronderzoek op voort te bouwen. Bij onzekerheden over de afbakening van mijn onderwerp en de al dan niet juiste onderzoekspiste kon ik steeds rekenen op de juiste bijsturing. Verder hielp de behulpzame staf van het Rubenianum in Antwerpen mij steeds met de documenten die ik nodig had in hun onderzoekscentrum. Ook mijn mama wil ik bedanken voor de steun en liefde. Vooral merci aan mijn fantastische papie, die ik zo bewonder.