La Scuola Dei Macchiaioli
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Pittura-Romantica-2.Pdf
Lezioni di storia dell’arte L’arte del Romanticismo L’esperienza italiana: Francesco Hayez e i Macchiaioli. Prof.ssa Annamaria Donadio Lezioni di storia dell’arte In Italia si radicò una corrente del romanticismo, il cosiddetto romanticismo storico, il cui massimo esponente è Francesco Hayez (Venezia, 10 febbraio 1791 – Milano, 21 dicembre 1882). I dipinti di Hayez tendono a rappresentare soggetti del passato, per lo più medioevale, nel tentativo di ritrarre situazioni assimilabili al suo tempo (esattamente come Alessandro Manzoni conseguì nell'Adelchi). Il suo più noto dipinto, intitolato semplicemente Il bacio (1859), rappresenta un uomo in procinto di fuggire ma capace di dedicare all'amata un bacio appassionato e sincero, identificando quindi il primato del sentimento su qualsiasi altra cosa. F. Hayez “Il bacio” – 1859 Pinacoteca di Brera - Milano Prof.ssa Annamaria Donadio Lezioni di storia dell’arte … Per la prima volta viene espresso in un quadro un bacio passionale e carico di emotività. L'uomo, mentre bacia la sua amata, appoggia la gamba sul gradino: Hayez comunica, con questo particolare, l'impressione che egli se ne stia andando, e dà più enfasi al bacio. La scelta dell'artista di celare i volti dei giovani conferisce importanza all'azione e le ombre che si possono scorgere dietro al muro, nella parte sinistra del quadro, indicano un eventuale pericolo. L'intera scena, a giudicare dagli abiti e dall'architettura, si svolge in un'ambientazione medioevale, ma in realtà è del tutto immersa nel presente. F.Hayez “Il bacio” – 1859 Pinacoteca di Brera - Milano Prof.ssa Annamaria Donadio Lezioni di storia dell’arte Hayez attraverso i colori (il bianco della sottoveste, il rosso della calzamaglia, il verde della piuma sul cappello e del risvolto del mantello e infine l'azzurro dell'abito della donna) vuole rappresentare l'alleanza avvenuta tra l'Italia e la Francia (accordi di Plombières). -

Mario Puccini “Van Gogh Involontario” Livorno Museo Della Città 2 Luglio - 19 Settembre 2021
Mario Puccini “Van Gogh involontario” Livorno Museo della città 2 luglio - 19 settembre 2021 ELENCO DELLE OPERE GLI ESORDI E IL MAESTRO FATTORI Giovanni Fattori, Ritratto di contadina, 1880 circa, olio su tavola, 34x31 cm, Museo Civico Giovanni Fattori Livorno Silvestro Lega, Busto di contadina, 1872-1873, olio su tavola, 40x26 cm, Gallerie degli Uffizi, Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti, Firenze Mario Puccini, Ave Maria, 1887 circa, olio su tela, 69x42 cm, Istituto Matteucci, Viareggio Plinio Nomellini, Ritratto di signora, 1885 circa, olio su tela, 33x16 cm, collezione privata Mario Puccini, La modella (La fidanzata), 1889-1890, olio su tela, 49,6x26,6 cm, collezione Fondazione Livorno Plinio Nomellini, Signora in nero, 1887, olio su tela, 43x20 cm, collezione Giuliano Novelli Mario Puccini, Ritratto della fidanzata all’uscita dalla chiesa, olio su tela, 31x21 cm, collezione Rangoni Mario Puccini, Lupo di mare, olio su tela, 38,5x26,2 cm, collezione Rangoni Mario Puccini, Ritratto di giovane, 1890, olio su tela applicata a cartone, 35x25 cm, collezione Rangoni Mario Puccini, Autoritratto con colletto bianco, 1912, olio su tela, 31x21,8 cm, collezione Rangoni Mario Puccini, Interno del mio studio, olio su cartone, 44x28 cm, collezione Rangoni Mario Puccini, Autoritratto, 1914, 47x33 cm, collezione privata Mario Puccini, Autoritratto in controluce, 1914, olio su tavola, 38,5x32,8 cm, collezione privata, courtesy Società di Belle Arti, Viareggio Giovanni Fattori, Nel porto, 1890-1895, olio su tavola, 19x32 cm, Museo Civico Giovanni -

ITALIAN ART SOCIETY NEWSLETTER XXX, 1, Winter 2019
ITALIAN ART SOCIETY NEWSLETTER XXX, 1, Winter 2019 An Affiliated Society of: College Art Association International Congress on Medieval Studies Renaissance Society of America Sixteenth Century Society & Conference American Association of Italian Studies President’s Message from Sean Roberts benefactors. These chiefly support our dissertation, research and publication grants, our travel grants for modern topics, February 15, 2019 programs like Emerging Scholars workshops, and the cost of networking and social events including receptions. The costs Dear Members of the Italian Art Society: of events, especially, have risen dramatically in recent years, especially as these have largely been organized at CAA and I have generally used these messages to RSA, usually in expensive cities and often at even more promote upcoming programing and events, to call expensive conference hotels. The cost of even one reception attention to recent awards, and to summarize all the in New York, for example, can quickly balloon to activities we regularly support. There are certainly no overshadow our financial support of scholarship. It will be a shortage of such announcements in the near future and significant task for my successor and our entire executive I’m certain that my successor Mark Rosen will have committee to strategize for how we might respond to rising quite a bit to report soon, including our speaker for the costs and how we can best use our limited resources to best 2019 IAS/Kress lecture in Milan. With the final of my fulfill our mission to promote the study of Italian art and messages as president, however, I wanted to address a architecture. -

Egli È Di Quelli Che Vissero Di Pensiero
numero 4 anno II | Ottobre 2019 nRivista semestrale del Caffè Michelangoiolo -Firenze i ISSN 2611-4089 Egli è di quelli che vissero di pensiero Noi Caffè Michelangiolo indice n.4 anno II Ottobre 2019 Rivista semestrale in copertina | Foto di Silvestro Lega (nd) - Silvestro Lega, “ L’adolescente” (nd) Pubblicata per conto di: Accademia degli Incamminati Via dei Frati, 19 | Modigliana (FC) Lucrezia Caliani pag. 06 www.accademiaincamminati.it “Mi fermo a Firenze” Associazione Culturale Caffè Michelangiolo Chiara Lotti pag. 08 Via degli Artigiani 45, 50041, Calenzano (Firenze) Le ramificazioni dell’arte www.caffemichelangiolo.it Massimo Innocenti pag. 10 Direttore responsabile: Il sole basso e... Andrea Del Carria Segretario di redazione: Erika Vita pag. 14 Maria Grazia Fantini La poetica del vero Redazione: Chiara Lotti Francesca Bertini pag. 18 Le bambine che fanno le signore Per la stesura della bibliografia: Lorenzo Tofi Maria Emirena Tozzi pag. 22 Silvestro Lega e le amicizie fiorentine Ufficio stampa: Giulia Bertelli Stefania Balocco pag. 24 Costanza Peruzzi Dello sguardo nel tempo. Occhi che sentono Redazione: Associazione Culturale Caffè Michelangiolo, Via degli Artigiani 45, 50041, Calenzano (Firenze) fuoripagina [email protected] Edizione: Associazione Culturale Caffè Michelangiolo, Andrea Del Carria pag. 28 Accademia degli Incamminati di Modigliana La frontiera Progetto grafico e impaginazione: Valentina Ciardelli pag. 30 Alessandro Innocenti - [email protected] Le Lamentazioni della famiglia Puccini Stampa: Leonardo -

MARIO PUCCINI Con Il Patrocinio Di La Passione Del Colore Da Fattori Al Novecento
Mostra realizzata da MARIO PUCCINI Con il patrocinio di La passione del colore da Fattori al Novecento SERAVEZZA PALAZZO MEDICEO Con il contributo finanziario di PATRIMONIO MONDIALE UNESCO since 1821 11 luglio · 2 novembre 2015 Mostra a cura di Nadia Marchioni e Elisabetta Matteucci Palminteri 12 luglio · 6 settembre dal lunedì al venerdì 17 - 24 | sabato e domenica 10.30 - 12.30 e 17 - 24 Ufficio stampa Catalogo ILOGO, Prato Maschietto Editore 7 settembre · 2 novembre www.ilogo.it www.maschiettoeditore.com dal giovedì al sabato 15 - 20 | domenica 10.30 - 20 Ingresso intero 6.00 euro · ridotto 4.00 euro PONTE STAZZEMESE Biglietto famiglia: 12 euro (2 adulti con ragazzi fino a 14 anni) SERAVEZZA STRADA PROVINCIALE 9 STAZZEMA Ultimo ingresso 30 minuti prima dell’orario di chiusura. PALAZZO MEDICEO VIA SERAVEZZA Fondazione Terre Medicee STRADA PROVINCIALE 42 MARIO PUCCINI Palazzo Mediceo di Seravezza - Patrimonio Mondiale Unesco Viale L. Amadei, 230 (già Via del Palazzo) 55047 Seravezza LU VIA ALPI APUANE La passione del colore tel. 0584 757443 · [email protected] · www.palazzomediceo.it STRADA PROVINCIALE 8 Treno. Fermata di Forte dei Marmi · FORTE VIA AURELIA DEI MARMI Seravezza · Querceta da Fattori al Novecento Ufficio Informazioni Turistiche tel. 0584 757325 Collegamento con autobus di linea. [email protected] · www.prolocoseravezza.it Da Querceta per Seravezza: ogni ora PIETRASANTA VIA G.B. VICO A12 USCITA VERSILIA a partire dalle 6:55. Ultima corsa a 20:55 Visite guidate per singoli o gruppi: tutti i giovedì 21.00-22.30. Su prenotazione. (fermata Piazza Alessandrini, di fronte SERAVEZZA Disponibili su prenotazione anche in giorni diversi durante l’orario di apertura alla stazione ferroviaria). -

Il Finanziere N. 2/2017
Mostra I VOLTI DELLA PITTURA ITALIANA DELL’800 DA HAYEZ A BOLDINI Giovanni Boldini, Ritratto della principessa Radziwill stata una delle più vivaci e tradusse in movimenti, correnti e stili di SUSANNA PAPARATTI articolate stagioni artisti- che trasformarono le certezze prece- che che abbia interessato denti. A risentirne seppur con modi e CON OLTRE 100 l’Europa. Un secolo, il XIX, dinamiche diverse furono l’architettura Èdenso di avvenimenti e trasformazioni, e la decorazione, così come la scultura OPERE GIUNTE QUASI di fermenti sociali, scoperte scientifiche e la pittura. La scoperta con gli scavi di INTERAMENTE DA e industriali: due fra le tante, nel 1839 Pompei ed Ercolano nel 1738, le rovine COLLEZIONI PRIVATE Daguerre realizzò la prima macchina di Villa Adriana a Tivoli, i templi gre- fotografica mentre nel 1859 Darwin ci di Paestum i marmi fidiaci ritrovati SARÀ A BRESCIA diede alle stampe “L’origine della spe- nel Partenone ad Atene alimentarono SINO ALL’11 GIUGNO cie”. Nell’arte questo flusso di stimoli si un interesse particolare ed una nuova 62 | il FINANZIERE | Febbraio 2017 INFORMAZIONI DA HAYEZ A BOLDINI. ANIME E sensibilità verso la classicità e l’elegan- VOLTI DELLA PITTURA ITALIANA za delle forme che, proprio la scultura DELL’OTTOCENTO antica, suggerivano quale modello da Brescia – Palazzo Martinengo seguire. Non è un caso se lo storico Via dei Musei, 30 dell’arte e archeologo Joachin Win- Fino all’11 giugno ckelmann (al MAX di Chiasso si è da poco inaugurata una mostra su di Orari: lui, intitolata “Winckelmann. I monu- da mercoledì a venerdì 9.00-17.30 menti antichi inediti” fruibile sino al sabato, domenica e festivi 9.00-20.00 7 maggio) pubblicò nel 1755 “Con- Biglietti: siderazioni sull’imitazioni delle opere – Intero: 10 euro greche nella pittura e nella scultura”. -

I MACCHIAIOLI (Prof.Ssa M. Lisa Guarducci) La Maggiore Apertura
I MACCHIAIOLI (prof.ssa M. Lisa Guarducci) La maggiore apertura politica della Toscana rispetto al rigore poliziesco presente negli altri stati (controllo austriaco nel Lombardo-Veneto; Stato Pontificio al centro; Borboni al sud) fa sì che a Firenze, a partire dal 1855, giungano artisti da tutta Italia. Firenze è vista come nuova Atene. Dal '59 se ne vanno i Lorena; dal '60 la Toscana entra nel Regno d'Italia divenendone capitale tra il '65 e il '71. A Firenze giunge il foggiano Saverio Altamura (1826-97) che nel '55 è a Parigi per vedere l'Esposizione Universale ( e il Pavillon du Realism di Odoardo Borrani, Le cucitrici di camice rosse , 1863 Courbet): sarà lui ad offrire l'occasione del rinnovamento artistico in città. Prima significativa affermazione della maniera moderna: l'Esposizione Nazionale di Firenze del 1861. Luogo d'incontro: il Caffè Michelangiolo. Il gruppo si stringe intorno a Diego Martelli (1839-1896), vicine alle idee socialiste, scrittore e critico sostenitore dei macchiaioli ( che ricevette nella sua villa di Castiglioncello). Nel 1879 tiene a Livorno una memorabile conferenza sugli impressionisti che paragona alla baraonda del caffè Michelangiolo. Nel 1856 era stato a Firenze Degas. Fu Telemaco Signorini, pittore e teorico, a proporre l’appellativo di ‘Macchiaioli’. Il principe Antonio Demidoff apre al pubblico la propria collezione privata, ricca di opere di Ingres, Delacroix, Corot, i pittori della "scuola di Barbizon". 1856: data ufficiale di nascita della 'macchia', comunque convenzionale (conclusione: ’67 ca.). La macchia è esibita in opposizione feroce alla forma accademica ufficiale, immobilizzata e fredda. La macchia va messa in parallelo con l'impressionismo, ma è altra cosa: manca di sistematicità nella ricerca e coerenza nell'applicazione pittorica della teoria; è consistente, ha un peso, una solidità assenti nei 'trattini' impressionisti. -
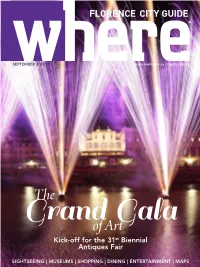
Florence City Guide ®
FLORENCE CITY GUIDE ® SEPTEMBER 2019 WWW.WHEREITALIA.COM/FLORENCE The Grandof Art Gala st Kick-off for the 31 Biennial Antiques Fair SIGHTSEEING | MUSEUMS | SHOPPING | DINING | ENTERTAINMENT | MAPS Florence September 2019 VIA SESTESE 14 INSIDER TIPS 32 DINING CASTELLO SESTO the guide apertura SIGHTSEEING FIORENTINO SVINCOLO SESTO FIORENTINO V I A 20 SHOPPING S AUTOSTRADA FIRENZE-MARE E S VI VIA XXV APRILE T A E VIA DEL CHIUSO DEI PAZZI G S E In The Merchant of . DUPRÈ VIA REGINALDO GIULIANI VIA DELLE PANCHE Venice boutique you can VIA ANDREA COSTA immerse yourself in the VIA ANDREA COSTA VIA G. DUPRÈ Teatro Romano brand’s new, enveloping VIA FAENTINA VIA DE' PERFETTI RICASOLI VIA CARLO DEL GRECO Museo Bandini VIA MARINI VIA PORTIGIANI Cattedrale di San Romolo fragrance, which draws SCONI BO STRAD A PROV INCIALE 54 DEI PIAZZA PIAZZA G.GARIBALDI MINO DA FIESOLE its inspiration from a VIA MASSICINI V. LUCCHESE A VIALE XI AGOSTO LUC V VIA SANT’APPOLINAR AUTOSTRADA FIRENZE-MARE fascinating animal. I VIA S.CHIARA A E VIA SALVADOR ALLENDE F R À VIALE SAN G VIALE GAETANO PIERACCINI I VIA GI O ULI AENTINA V O CACCIN A N I N VIA F SOLANA I PONTE D A 32 FOOD&WINE VIA DELLA BADIA DEI ROCCETTINI F I NUOVO E VIA REGINALDO GIULIANI S H I A F I E VIA DELLE PANCHE O FIESOLE L ALLA CC E D PIAZZA E Aeroporto A stay at Eataly Firenze T Amerigo V I A V E T ENRICO O Vespucci PIGNONE BADIA L MATTEI VIA MANTELLINI ' A N G E VIA PRATESE L I C is the ideal solution for PIZZERIA O TOP BRANDS V I A U G O C O R S I SAN DOMENICO V. -

A Palace and the City
A PALACE AND THE CITY 150 years since Florence was named An exhibition created and curated by the Capital of Italy Stefania Ricci and Riccardo Spinelli Palazzo Spini Feroni opens its doors Design to the city in a fascinating exhibition Maurizio Balò on its centuries of history in collaboration with Davide Amadei Museo Salvatore Ferragamo Exhibition organised by Florence, Palazzo Spini Feroni Museo Salvatore Ferragamo 8 May 2015- 3 April 2016 in collaboration with inauguration 7 May Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Firenze Fondazione Ferragamo With the sponsorship of Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Regione Toscana Comune di Firenze 1 A PALACE AND THE CITY “Long before I ever moved into the Palazzo Spini Feroni it was one of the buildings of Florence that I most admired and loved.” Salvatore Ferragamo From 8 May 2015 to 3 April 2016, at Palazzo Spini Feroni, via Tornabuoni, Florence, Museo Salvatore Ferragamo will hold an exhibition on the building’s centuries of history, commemorating the 150 years since Florence was named capital of the Kingdom of Italy (1865-1870), and Palazzo Spini Feroni became the city hall in 1865. Curated by Stefania Ricci and Riccardo Spinelli, the exhibition will include prestigious works of art and documents from museums and private collections and will tell the intricate stories behind the palace and its residents, in captivating displays created by stage designer Maurizio Balò, thus sharing one of the most important buildings in the city’s urban landscape with Florence, Florentines and travellers. -

Lo Non Finito En La Pintura Macchiaiola, Luminista Y Realista. Recursos, Materiales Y Procesos Técnicos Para Retratar Lo Imperceptible
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE BELLAS ARTES TESIS DOCTORAL Lo non finito en la pintura Macchiaiola, luminista y realista. Recursos, materiales y procesos técnicos para retratar lo imperceptible MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR Simona Cheli Director Manuel Huerta Torrejón Madrid, 2018 © Simona Cheli, 2017 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE BELLAS ARTES LO NON FINITO EN LA PINTURA MACCHIAIOLA, LUMINISTA Y REALISTA. RECURSOS, MATERIALES Y PROCESOS TÉCNICOS PARA RETRATAR LO IMPERCEPTIBLE MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTORA PRESENTADA POR: Simona Cheli Director: Prof. Dr. Manuel Huertas Torrejón Madrid, 2017 2 LO NON FINITO EN LA PINTURA MACCHIAIOLA, LUMINISTA Y REALISTA. RECURSOS, MATERIALES Y PROCESOS TÉCNICOS PARA RETRATAR LO IMPERCEPTIBLE DOCTORANDA: SIMONA CHELI DIRECTOR: PROF. DR. MANUEL HUERTAS TORREJÓN Catedrático de universidad de Técnicas Pictóricas y Materiales FACULTAD DE BELLAS ARTES UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 2017 3 4 Io stimo più il trovar un vero, benché di cosa leggiera, che ‘l disputar lungamente delle massime questioni senza conseguir verità nissuna. Yo aprecio más encontrar una verdad, aunque de algo pequeño, que disputar ampliamente de grandes cuestiones sin obtener ninguna verdad. (Galileo Galilei en Pisa, 15 de Febrero 1564) 5 6 A mi familia, a Elena, a vosotros os dedico esta tesis. 7 8 Agradecimientos Deseo expresar el más profundo y sincero agradecimiento a mi director de tesis D. Manuel Huertas Torrejón que nunca ha dejado de aconsejarme de la mejor manera al mismo tiempo el que haya depositado en mí su confianza. Su apoyo ha hecho posible que este proyecto se haya llevado a cabo. -

OTTOCENTO FORLI' LEONE.Pdf
catalogo a cura di Francesco Leone e Fernando Mazzocca Forlì, Musei San Domenico 9 febbraio - 16 giugno 2019 Mostra ideata e promossa da Comitato d’onore Giuseppe Pedrielli Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì Dirigente Uffi cio Scolastico Provinciale di Forlì-Cesena con Roberto Fico Comune di Forlì Presidente della Camera dei Deputati Antonio Lampis Direttore Generale Musei In collaborazione con Alberto Bonisoli Galleria d’Arte Moderna, Milano Ministro del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Antonio Tarasco Galleria Nazionale d’Arte Moderna Direttore Servizio I, Collezioni Museali - Direzione e Contemporanea, Roma Jacopo Morrone Generale Musei Gallerie dell’Accademia, Venezia Sottosegretario al Ministero della Giustizia Gallerie degli Uffi zi, Firenze Silvia Trisciuzzi Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli Stefano Bonaccini Dichiarazione di rilevante interesse culturale - Pinacoteca di Brera, Milano Presidente della Regione Emilia Romagna Direzione Generale Musei Con la partecipazione di Massimo Mezzetti Corrado Azzollini MusicMedia - Concerto Classics, Milano Assessore alla Cultura, Regione Emilia Romagna Direttore Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l’Emilia Romagna Con il patrocinio di Roberto Balzani Camera dei Deputati Presidente Istituto per i Beni Artistici Culturali Cristina Ambrosini Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Regione Emilia Romagna per la città metropolitana di Bologna -
Fondazione Cassa Di Risparmi Di Livorno 1992/2012 Nascita Di Una Collezione a Cura Di Stefania Fraddanni
Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno 1992/2012 Nascita di una collezione a cura di Stefania Fraddanni Fondazione Cassa di Risparmi Pacini di Livorno Editore Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno (1992/2012) © Copyright 2013 by Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno Nascita di una collezione ISBN 978-88-6315-530-3 Chiusura delle iniziative promosse per il XX anniversario della nascita della Fondazione. Inaugurazione della sede ristrutturata e del nuovo ingresso. Realizzazione editoriale e grafica Apertura al pubblico dell’esposizione di opere d’arte. Livorno, Fondazione Cassa di Risparmi, Via A. Gherardesca Piazza Grande 23, 16 marzo 2013 56121 Ospedaletto (Pisa) www.pacinieditore.it 1992/2012 I venti anni della Fondazione [email protected] Responsabile Comunicazione Stefania Fraddanni Progetto Grafico Logo e Immagine Coordinata Anna Laura Bachini Sales Manager Beatrice Cambi Progetto editoriale a cura di Responsabile editoriale Stefania Fraddanni Elena Tangheroni Amatori con la collaborazione di Raffaella Soriani Direzione produzione Testi di Stefano Fabbri Andrea Baboni Giovanna Bacci di Capaci Conti Fotolito e Stampa Silvestra Bietoletti Industrie Grafiche Pacini Francesca Cagianelli Francesca Dini Vincenzo Farinella Referenze forografiche Piero Frati Archivio Dini, Montecatini-Firenze Francesca Giampaolo Fondo fotografico Istituto Matteucci, Viareggio Monica Guarraccino Archivio Baboni, già Malesci, Correggio Maria Teresa Lazzarini Nadia Marchioni Dario Matteoni Giuliano Matteucci L’editore resta a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comuni- Nicola Micieli care e per le eventuali omissioni. Renato Miracco Michele Pierleoni Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di Sergio Rebora ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art.