(2006) Tharros Felix 2. Roma, Carocci Editore. 271 P.: Ill
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
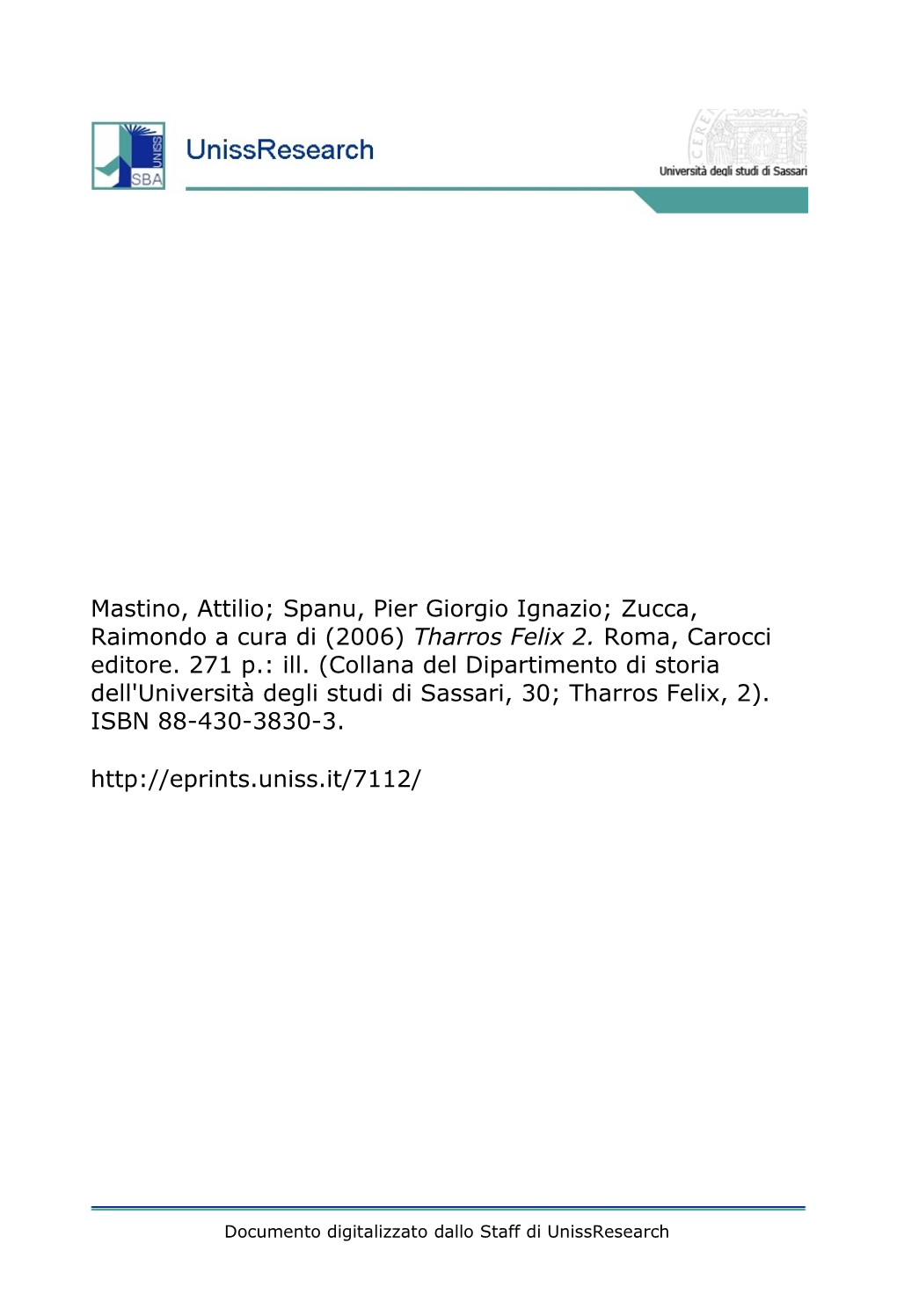
Load more
Recommended publications
-

Fig. 295. Suni, Domus Di Chirisconis. Interno Della Tomba 6. Fig. 296
Fig. 295. Suni, domus di Chirisconis. Interno della Tomba 6. Fig. 296. Suni, domus 10 di Chirisconis. Portello che introduce nella cella D. 268 Fig. 297. Suni, domus 5 di Chirisconis. Particolare del portello che introduce nella cella E. Fig. 298. Suni, domus di Chirisconis. Portello. 269 Fig. 299. Suni, domus di Chirisconis. Portello d’ingresso. Fig. 300. Suni, domus di Chirisconis. Portello d’ingresso. Fig. 301. Suni, domus 10 di Chirisconis. Portello d’ingresso. 270 Fig. 302. Suni, domus di Chirisconis. Interno della Tomba 5. Fig. 303. Suni, domus di Chirisconis. Interno della Tomba 10. 271 Fig. 304. Suni, domus di Chirisconis. Interno della Tomba 4. Fig. 305. Suni, domus di Chirisconis. Interno della Tomba 5. 272 12 – NURAGHE CHIRISCONIS 12/13 filari, nel quadrante settentrionale, mentre per il resto non è in alcun modo leggibile il pro- filo di pianta che comunque si può ipotizzare di Provincia -Nuoro forma circolare con una circonferenza di circa 36 Comune - Suni metri. Località - Chirisconis o Pedrasenta Sul piano di crollo è visibile un tratto della camera per una altezza di circa 3 metri con7/8 Posizione - IGM Foglio 206 IV NE Sindia filari di pietre di piccole e medie dimensioni 40°19’49” – 3°51’27” disposte a file orizzontali con numerose zeppe di Quota - m 288 s.l.m. rincalzo. Purtroppo, lo stato di notevole rovina del monumento non consente di valutare l’artico- lazione interna dei vani. Il monumento è arroccato su un’altura basal- Nell’area circostante laterizi e ceramiche di tica a meno di 200 metri dalla necropoli ipogeica età romana. -

Storia Della Sardegna E Della Corsica Durante Il Dominio Romano
BIBLIOTHECA SARDA N. 42 Ettore Pais STORIA DELLA SARDEGNA E DELLA CORSICA DURANTE IL DOMINIO ROMANO VOLUME PRIMO a cura di Attilio Mastino In copertina: Giovanni Marghinotti, Caio Gracco si discolpa davanti al senato dalle accuse di immoralità e vessazioni compiute in Sardegna (1850 circa) Comune di Cagliari INDICE 7 Saggio introduttivo 173 Capitolo IV 61 Nota biografica Dalla fine della seconda guer- ra Punica allo scoppio delle 65 Nota bibliografica guerre civili di Mario e di Silla 68 Cronologia della 191 Capitolo V Sardegna romana Dalle guerre civili di Mario 87 Carta della Sardegna ro- e di Silla a Cesare Augusto mana 219 Capitolo VI 88 Avvertenze redazionali Considerazioni circa il modo col quale procedette la con- Riedizione dell’opera: STORIA DELLA SARDEGNA quista della Sardegna e della Storia della Sardegna e della Corsica E DELLA CORSICA DURANTE Corsica durante il dominio romano, tomi I-II, IL DOMINIO ROMANO Roma, Nardecchia editore, 1923. 253 Capitolo VII 95 Prefazione Le vicende della Sardegna e della Corsica dall’età di Au- Libro primo gusto alla caduta dell’Impe- LA CONQUISTA ROMANA ro romano di Occidente. La DELLA SARDEGNA E DELLA diffusione del Cristianesimo Pais, Ettore CORSICA Storia della Sardegna e della Corsica durante il 275 Capitolo VIII dominio romano / Ettore Pais ; a cura di Attilio 107 Introduzione Mastino. - Nuoro : Ilisso, c1999. La dominazione dei Vanda- 316 p. ; 18 cm. - (Bibliotheca sarda ; 42) li in Sardegna ed in Corsica 1. Corsica - Storia - Occupazione romana 2. 117 Capitolo I Sardegna - Storia - Occupazione romana Le più antiche relazioni fra Ro- 295 Appendice I. Mastino, Attilio ma, la Sardegna e la Corsica La coppa di Gelamiro 937.9 125 Capitolo II 297 Capitolo IX Scheda catalografica: Dallo scoppio della prima La dominazione bizantina Cooperativa per i Servizi Bibliotecari, Nuoro guerra Punica all’invasione in Sardegna ed in Corsica. -

LAYERS Archeologia Territorio Contesti 1 – 2016
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI DIPARTIMENTO DI STORIA, BENI CULTURALI E TERRITORIO LAYERS Archeologia Territorio Contesti 1 – 2016 DAEDALEIA LE TORRI NURAGICHE OLTRE LʼETÀ DEL BRONZO Atti del Convegno di Studi (Cagliari, Cittadella dei Musei, 19-21 aprile 2012) a cura di ENRICO TRUDU, GIACOMO PAGLIETTI, MARCO MURESU Comitato Scientifico del Convegno Simonetta Angiolillo, Rossana Martorelli, Giuseppa Tanda, Riccardo Cicilloni, Marco Giuman, Fabio Pinna Layers 1, 2016, 406-423 Sardi Ilienses (Livio, XLI, 12, 4) Raimondo Zucca Riassunto: L’evoluzione possibile della cultura delle comunità indigene della Sardegna dalla prima età del Ferro fino alla possibile ed eccezionale acquisizione della forma urbana, in periodo punico, ci porta a riflettere sui modelli da applicare ai dati culturali di contesti distinti dagli ambiti urbani fenici e cartaginesi e dei territori di pertinenza connessi alla diretta colonizzazione punica, benché in essi sia possibile cogliere elementi culturali Sardi. Attualmente il modello riferito alla cultura sarda della Prima età del Ferro e delle età successive è quello degli Entangled Objects and Hybrid Practices. Parole chiave: Sardi Ilienses Iolaeis; villaggio; città; ibridismo. Abstract: The possible development of the culture of the indigenous communities of Sardinia, from the early Iron Age to the acquisition of the urban settlement in the Punic period, leads us to a reflection on the applying models to the different Phoenician and Carthaginian urban archaeological contexts and the areas directly related to the Carthaginian colonization, although it could be possible to find cultural Sardinian elements. Currently the model refers to the Sardinian culture of the First Iron Age and later ages is that of Entangled Objects and Hybrid Practices. -

Roma En Sardinia a Comienzos Del Siglo II AC
GLADIUS Estudios sobre armas antiguas, arte militar y vida cultural en oriente y occidente XXXVI (2016), pp. 77-95 ISSN: 0436-029X doi: 10.3989/gladius.2016.0005 ROMA EN SARDINIA A COMIENZOS DEL SIGLO II A. C.: LA CAMPAÑA DE TIBERIO GRACO EL MAYOR ROME IN SARDINIA AT THE BEGINNING OF THE 2ND CENTURY BC: THE CAMPAIGN OF TIBERIUS GRACCHUS THE ELDER POR ANDONI LLAMAZARES MARTÍN* RESUMEN - ABSTRACT Sardinia fue uno de los primeros espacios en los que la República Romana implantó el sistema de provinciae, lo cual no significa que Roma consiguiera un control efectivo sobre la isla. A pesar de su conquista temprana, Cerdeña fue foco de constantes revueltas durante siglos, incluso en época imperial. Sin embargo, fueron pocos los generales de envergadura que hicieron frente a dichos conflictos. Entre esos pocos hombres, en las etapas iniciales del dominio romano sobresale sin ninguna duda Tiberio Graco el Mayor, padre de los famosos tribunos de la plebe, que en calidad de cónsul consiguió pacificar la isla durante su campaña (177-175 a. C.). Si tenemos en cuenta que las dotes políticas de Graco fueron más admiradas que sus cualidades militares, podemos concluir que sus habili- dades como reformador, administrador y diplomático resultaron claves para conseguir el éxito en Sardinia, donde las revueltas parecen tener un componente económico. Sardinia was one of the first places were the Roman Republic established the provincial system, but that did not suppose an effective control over the island. Despite its early conquest, Sardinia was the scene of constant re- bellions for centuries, even in imperial times. -

Volume L, 2015
ISSN 2037-5514 VOLUME L DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA SARDEGNA CAGLIARI, 2015 ISSN 2037-5514 ARCHIVIO STORICO SARDO A CURA DELLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA SARDEGNA VOLUME L CAGLIARI - 2015 ARCHIVIO STORICO SARDO A CURA DELLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA SARDEGNA VOLUME L EDIZIONI AV CAGLIARI - 2015 Direttore: Luisa D’Arienzo Comitato scientifico: Francesco Artizzu, Enrico Atzeni, Luisa D’Arienzo, Gabriella Olla Repetto, Maria Luisa Plaisant, Renata Serra, Giovanna Sotgiu Nessuna parte di questo volume può essere riprodotta in qualsiasi forma senza il permesso dell’Editore e/o della DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA SARDEGNA © Cagliari - 2015 Il presente volume è stato pubblicato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna EDIZIONI Progetto grafico AV EDIZIONI AV di ANTONINO VALVERI Via Pasubio, 22/A - 09122 Cagliari Tel. (segr. e fax) 070 27 26 22 web: www.edizioniav.it e-mail: [email protected] Stampa e allestimento: I.G.E.S. – Quartu S. Elena I N D I C E SAGGI E MEMORIE ERCOLE CONTU - RICCARDO CICILLONI, La preistoria della Sarde- gna con particolare riguardo alla Sicilia ........................................................................ Pag. 9 PIERPAOLO LONGU, Materiali di età romana dal nuraghe ‘La Varrosa’ a Sorso (SS) .............................................................................................................................................................. » 55 ATTILIO MASTINO, Natione Sardus. Una mens, unus color, una vox, una natio ....................................................................................................................................................................................... -

Il Messaggero Sardo
POLITICA AGRICOLTURA SCUOLA EMIGRAZIONE CINEMA SPORT Confronto Dibattito Rivolta Savina Anche Incoraggiante aperto in Consiglio di insegnanti e Corriga il grande avvio sulla riforma sulla crisi amministratori premiata Orson Welles di stagione dello Statuto della pastorizia locali contro a Nuragus scelse l’Isola per il Cagliari a pagina 3 a pagina 6-7 i tagli alle classi a pagina 14 per i suoi film di Bisoli a pagina 8 a pagina 16 a pagina 30 TAXE PERÇUE - TASSA RISCOSSA DIRECT ENTRY CNS/CB CENTRALE/DE PDI/348/2008 DCOOS3568 ECONOMY NAZ / 028 / 2008 IL CNS/CB & PA028 MESSAGGERO Mensile della Regione Autonoma della Sardegna per i Sardi nel mondo SARDO www.ilmessaggerosardo.com Anno XLII / Ottobre 2010 Rilanciare l’Autonomia provocati dalla riforma Gelmini. Molti paesi dell’interno si Innovazione e ricerca stanno spopolando. Se in questi centri si cancellano classi per fronteggiare la crisi e scuole, sarà inevitabile che lo spopolamento continui con effetti sociali devastanti. Per questo alle proteste della scuola hanno partecipato molti amministratori locali. Tra gli strumenti che la Regione ha indicato per superare Anche la Regione è intervenuta. Così come interviene la crisi e rilanciare l’occupazione ci sono innovazione e per fronteggiare le continue crisi e le emergenze che si ricerca. Non è la prima volta che le forze politiche manifestano senza tregua nei più diversi settori economici. concordano su queste priorità per dare un futuro meno Dall’industria all’agricoltura (come è emerso in modo incerto alle nuove generazioni. Ma molto spesso ai buoni clamoroso con la protesta dei pastori), tutti i comparti propositi e ai progetti non sono seguiti fatti concreti. -

3. I Sardi Pelliti Del Montiferru O Del Marghine E Le Origini Di Hampsicora
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by UnissResearch Mastino, Attilio (2005) 3. I Sardi Pelliti del Montiferru o del Marghine e le origini di Hampsicora. In: Mele, Giampaolo (a cura di). Santu Lussurgiu: dalle origini alla "Grande Guerra", Nuoro, Grafiche editoriali Solinas, Vol. 1: Ambiente e storia. p. 141-166. http://eprints.uniss.it/4597/ Documento digitalizzato dallo Staff di UnissResearch AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SANTULUSSURGIU Santu Lussurgiu. Dalle origini alla "Grande Guerra" a cura di Giampaolo Mele I Ambiente e Storia AMMINISTRAZIONE COMUNALE SANTU LUSSURGIU CI/ratore scù!lltUico: GIA~IPAOL() MEI.E Coordinatore editoria/e: E~l1U() ClIESSA Seg rete ria o/go n i;:;.a ti \'([: TONIA MALICA Si rillgm~i{/ per il cOl1tribIlto fotogrq/ico: ANTONELLO CART.. \. GIUSEPPE ORRO. GIUSEPPE RIGGI{) E GIOVANNI SECHI Stampa: GRAFICHE EDITORIALI SOUNAS S.A.S. Nucm.o/BoL< >TANA III COfJcrtill(/: \~)I. I - Particolare di'comril'o di {(II li .finestra del f700; \~)I. Il - Scorcio IJ(/llo/wllico del Paese del I CJ()8. ATIILIO MASTINO III I Sardi Pelliti del Montiferru o del Marghine e le origini di Hanlpsicora Polibio nel VII libro delle Storie racconta che subito dopo la battaglia di Canne Annibale rinnovò il giuramento contro i Romani che il padre Amilcare gli aveva fatto fare bambino, a nove anni, a Cartagine e poi a Gades sull' Atlantico presso il tempio di Eracle: dopo vent'anni da quel lontanissimo giuramento, conquistata Sagunto ed attraversate le Alpi, Annibale ormai vinci tore sui -

Rome Threatens Sardinia in the First Punic
First Punic War. Rome finally won the long war with a naval victory at the Aegates Islands in 241. In the Peace of Lutatius that ended the war Carthage lost Sicily and had to pay an enormous indemnity, but retained control of Sardinia and Corsica. The Rape of Sardinia The end of the First Punic War brought no relief to Carthage. Hard on the heels of this war came the revolt of the mercenaries, the Truceless War, 240-238 (featured in C3i Nr. 7). While this brutal war raged in Africa, the contagion of rebellion spread to Carthage's mercenary garrison on Sardinia in 239. These soldiers of fortune rose up, and slew their Carthaginian commander Bostar and his officers. In response, Carthage sent an expedition under (another) Hanno to punish the rebels, but his troops deserted and joined the mutineers. The rebels crucified Hanno, then ran rampant over the island, slaying all the Carthaginian settlers. Once the Rome Threatens Sardinia against Corsica and Sardinia .He had euphoria of the initial uprising had in the First Punic War some success against the garrisons, worn off, these mercenaries began to 'The First Punic War began in 264 as a before being driven off by a reinforc - dread retribution from Carthage. So contest between Rome, Syracuse and ing fleet Under H annibal, son of they sent an offer to Rome to surren- Carthage for control of eastern Sicily. Gisgo. In the following year, the der Sardinia to them. Rome defeated Syracuse early on, consul Gaius Sulpicious Palerculus and the war expanded as a clash campaigned with a Roman fleet in The Roman Senate refused the offer. -

Agrigentum - 262 Bc
1 Commands & Colors: Ancients - Punic Wars AGRIGENTUM - 262 BC Historical Background legions. After more hard fighting, the Punic army broke. The The First Punic War began when Rome decided to invade largest battle of the First Punic War had ended in a decisive Sicily in 264. Chartage, unprepared, scrambled to raise an Roman victory, but ironically Hannibal’s army was able to army under Hannibal Gisgo. By 262 Hannibal arrived with an escape. Roman losses in the battle and the siege were so heavy advance force at Agrigentum, but the Roman consuls Lucius that Megellus and Vitulus were denied a triumph, despite their Postumius Megellus and Quintus Mamilius Vitulus made a victory.The stage is set. The battle lines are drawn and you are preemptive strike and placed him under siege. Months later, in command. Can you change history? Carthage dispatched a relief army of 30,000 foot and 4,500 War Council horse and 60 elephants under Hanno the Elder. Megellus and Carthaginian Army Vitulus detached about a quarter of their army to guard Leader: Hanno the Elder Hannibal, and brought the remaining 35,000 foot and 3,000 5 Command Cards horse onto the field. Hanno organized his army with his Move First mercenaries in the van, his elephants in a second lines and his African levies in a third. As the armies clashed the Roman Army Leader: Megellus, Vitulus mercenaries fought fiercely at first, but eventually buckled. As 5 Command Cards they routed in the line of elephants, all hell broke loose. The elephants were caught in the pandemonium, and began to Victory rampage in all directions. -

Sarin Ia in Ancient Times
SAR I N I A I N ANCIENT TIMES I - IER M A E S . OUCI I . j , . “ AUTHOR op S PAI N UND ER ms ROMAN E MPI RE S YRI A As A ROMAN PROV I NCE OXFORD B . H . BLAC KW E LL , BROAD STRE E T 1 9 1 7 NEW YORK D NGM NS GR D URTH V U O A N AN CC . FO A N . EE . E E. AND THIRTIETH STREET CONTE NTS CHAN T" INTROD UCTION THE pRE meRI c AGE D Y — P P II . LEGEN AR HIS TORY NATIVE EO LES TH III . E CARTHAGINIAN S UPREMACY I U P D U AND M V . NAT RAL RO CTS COM ERCE ' THE P B pR N V . RE U LICAN v cE VI . CARALES V I I Y MP E . THE EARL E IR O S D V III . THE CHIEF CITIES F AR INIA MP IX. THE LATER E IRE U AND S X . ARCHITECT RE THE ART XI G . RELI ION BIBLIOGRAPHY IND EX S A R D I NI A I N A NC I E NT T I M E S INTROD UCTION THE features of interest presented by a small and poor provincenecessarily differ from thoseof one O ERRATA. ’ . 22 or atrr éi read p , f e em rea d Pa ro m. note1 or Para p 5 5 , , f e last l n in er t beoreootnot . i e s p 7 5 , , 3 f f ea d S evins. 1 0 note1 or S ervius r p 4 , , f 1 n e or r 0 . -

Estratto Mastino, Zucca
Collana del Dipartimento di Storia dell’Università degli Studi di Sassari Nuova serie fondata da Mario Da Passano, Attilio Mastino, Antonello Mattone, Giuseppe Meloni I lettori che desiderano informazioni sui volumi pubblicati dalla casa editrice possono rivolgersi direttamente a: Carocci editore via Sardegna , Roma, telefono , fax Visitateci sul nostro sito Internet: http://www.carocci.it Oristano e il suo territorio 1 Dalla preistoria all’alto Medioevo A cura di Pier Giorgio Spanu e Raimondo Zucca Carocci editore La torre a destra: visione assonometrica (Giorgio Cireddu) della torre gotica di San Cri- stoforo in Oristano (), fusa alla torre razionalista dell’architetto Giovanni Battista Ceas della Casa del Fascio di Mussolinia-Arborea; rielaborazione grafica ADWM (Valter Mulas-Sebastiano Cubeddu) da G. PELLEGRINI , in Le città di fondazione in Sardegna, a cura di A. LINO , Cagliari . Provincia di Oristano a edizione, dicembre © copyright by Carocci editore S.p.A., Roma Realizzazione editoriale: Omnibook, Bari Finito di stampare nel dicembre dalla Litografia Varo (Pisa) ISBN ---- Riproduzione vietata ai sensi di legge (art. della legge aprile , n. ) Senza regolare autorizzazione, è vietato riprodurre questo volume anche parzialmente e con qualsiasi mezzo, compresa la fotocopia, anche per uso interno o didattico. Urbes et rura. Città e campagna nel territorio oristanese in età romana di Attilio Mastino e Raimondo Zucca* . Geografia storica dell’Oristanese L’ambito geografico di questa ricerca comprende sia le città antiche con i rispettivi agri insistenti sul golfo di Oristano, sia i centri urbani interni e i loro territoria gravitanti sulla media valle del Tirso e sulla vallata del Riu Mogoro, tra i plessi montani del Montiferru a nord-ovest, del Mar- ghine a nord-nord-est, del Grighine-Monte Arci a est e di Arbus-Mon- tevecchio-Guspini a sud. -

The Second Punic War, 218 BC to 202 BC the Course of The
The Romans fielded two armies of two Legions with his entire cavalry force of 6,000. Hannibal won each. The first under the command of Sempronius this engagement decisively and Scipio only just The Second Punic War, 218 BC was based in Sicily. This army consisted of two escaped with his life. Scipio then retreated over the to 202 BC legions totaling 8,600 Roman foot, 16,000 Italian Ticinus towards the Trebia where he found a good allied troops, 1,800 allied cavalry ,and 160 defensive position and fortified it. Hannibal By P.Chadford quinqueremes. followed Scipio and camped near his army. In an attempt to solve his supply problems Hannibal took The second under the command of Scipio was Claustidium, a Roman supply depot by treachery. Introduction ordered North into the Po Valley. This force The Second Punic W ar must rank as Ancient version consisted of two legions totaling 8,000 Roman foot, Soon the second consul, Sempronius arrived and of a W orld W ar. From the straits of Gibraltar to the 14,000 Italian allied troops, 1,600 allied cavalry, 600 joined Scipio's army. Sempronius led an attack coast of Asia the armies and fleets of the two mighty Roman cavalry, and sixty quinqueremes. against some of Hannibal's foragers and managed to alliances fought each other. History was to prove force them back to their camp. This made This force was held up in Gallia Cisalpina due to a Sempronius very confident and Hannibal was easily that the victor of this war would become the master revolt and Scipio raised a third army of similar size of the known world.