Pieve Alta (Passeggiata) Itinerario N
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
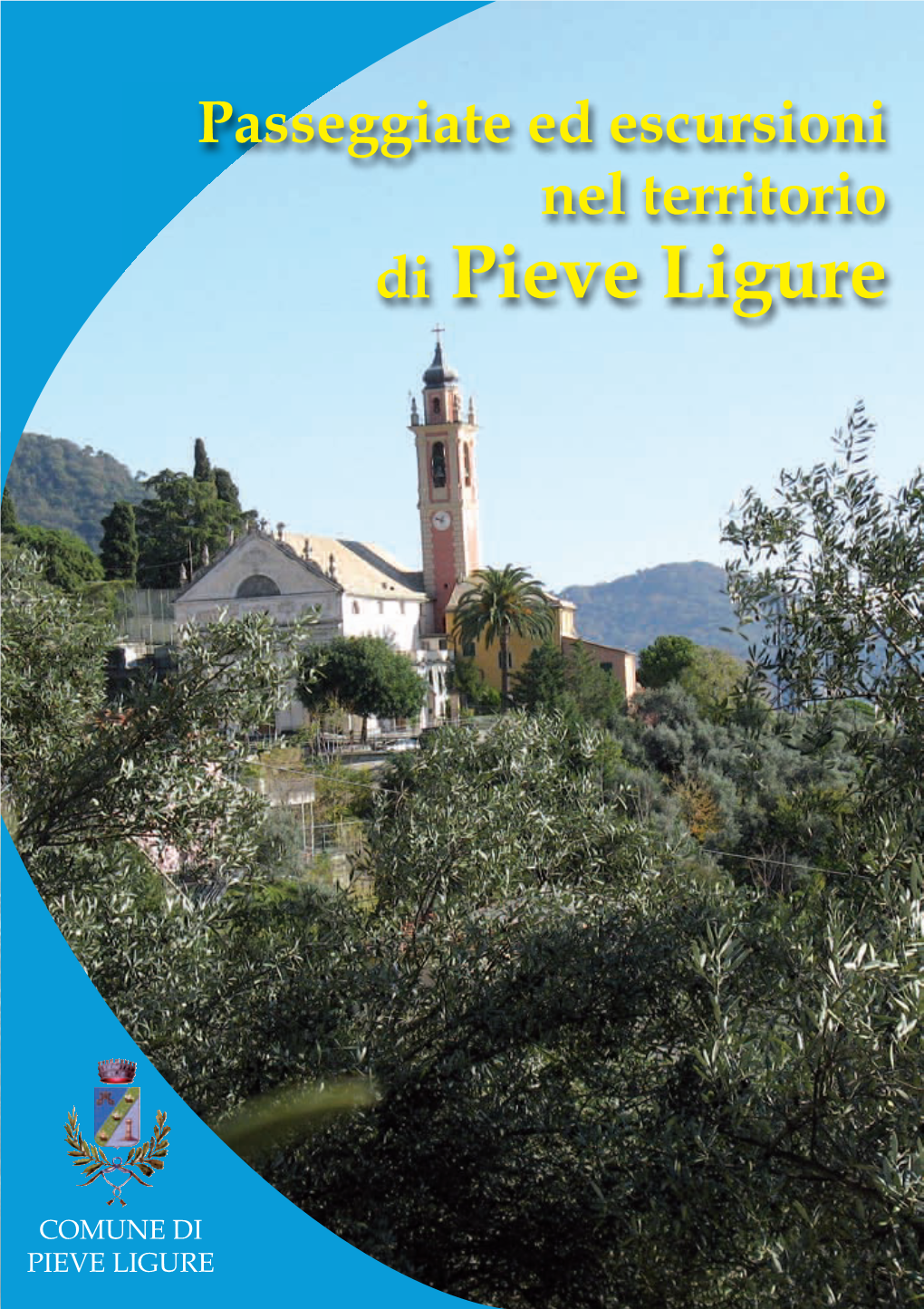
Load more
Recommended publications
-

Pieves O Çéivesìn
1| 2000 Periodico dell’Amministrazione Comunale di Pieve Ligure Pievesino Il O Çéivesìn L’indifferenza è un torto contro il creato, Cittadino, il benvenuto non contro la società. Benvenuti nel periodico che l’Amministrazione Comunale ha predisposto Erri De Luca per onorare un impegno preso con Voi nel momento elettorale: quello di ampliare sempre più i veicoli informativi tra noi. La funzione basilare di questo mezzo d’informazione è quella di fornire al cittadino un ulteriore strumento di comunicazione istituzionale e, nello stesso tempo, svilupparne altre, quali, ad esempio, la promozione delle attività sociali, culturali ed economiche; la valorizzazione della storia e delle tradizioni pievesi; la sensibilizzazione degli abitanti alle problematiche della tutela e della salvaguardia dell’ambiente e, non ultima, quella di favorire la crescita della partecipazione democratica. Questo è quindi l’impegno con il quale realizzare O Çéivesìn. A proposito del nome della testata, sono ben cosciente che potrebbero esserci altri suggerimenti, però la scelta tiene conto delle seguenti considerazioni: il nome dichiara il formato del periodico, piccolo, ma in crescita; ne rivela con semplicità l’identità pievese e ligure; non lo ingabbia nel solo ambito della comunicazione istituzionale; è un termine sufficientemente eufonico; risulta familiare ed è destinato in primo luogo alle famiglie pievesi. Questo è il primo numero, abbiamo bisogno di farci un’esperienza, quindi Anno primo, numero uno maggio 2000. chiedo collaborazione e suggerimenti, affinché diventi, nei fatti, quello Distribuzione gratuita. Pubblicazione quadrimestrale registrata al Tribunale di Genova che è nelle intenzioni: un vero e concreto veicolo di comunicazione (autorizzazione n. 5/00). tra tutti noi. -

Provincia Località Zona Climatica Altitudine GENOVA ARENZANO D
Premi ctrl+f per cercare il tuo comune Provincia Località Zona climatica Altitudine GENOVA ARENZANO D 6 AVEGNO D 34 BARGAGLI E 341 BOGLIASCO D 25 BORZONASCA D 167 BUSALLA E 358 CAMOGLI D 32 CAMPO LIGURE E 342 CAMPOMORONE D 118 CARASCO D 26 CASARZA LIGURE D 34 CASELLA E 410 CASTIGLIONE CHIAVARESE E 271 CERANESI D 80 CHIAVARI D 5 CICAGNA D 88 COGOLETO D 4 COGORNO D 38 COREGLIA LIGURE E 308 CROCEFIESCHI F 742 DAVAGNA E 522 FASCIA F 900 FAVALE DI MALVARO E 300 FONTANIGORDA F 819 GENOVA D 19 GORRETO E 533 ISOLA DEL CANTONE E 298 LAVAGNA D 6 LEIVI E 272 LORSICA E 343 LUMARZO D 228 MASONE E 403 MELE D 125 MEZZANEGO D 83 MIGNANEGO D 137 MOCONESI D 132 MONEGLIA D 4 MONTEBRUNO F 655 MONTOGGIO E 438 NE D 68 NEIRONE E 342 ORERO D 169 PIEVE LIGURE D 168 PORTOFINO D 3 PROPATA F 990 RAPALLO D 2 RECCO D 5 REZZOAGLIO F 700 RONCO SCRIVIA E 334 RONDANINA F 981 ROSSIGLIONE E 297 ROVEGNO F 658 SAN COLOMBANO CERTENOLI D 45 SANTA MARGHERITA LIGURE D 13 SANTO STEFANO D'AVETO F 1012 SANT'OLCESE D 155 SAVIGNONE E 471 SERRA RICCÌ D 187 SESTRI LEVANTE D 4 SORI D 14 TIGLIETO E 500 TORRIGLIA F 769 TRIBOGNA E 279 USCIO E 361 VALBREVENNA E 533 VOBBIA E 477 ZOAGLI D 17 Provincia Località Zona climatica Altitudine IMPERIA AIROLE D 149 APRICALE D 273 AQUILA D'ARROSCIA E 495 ARMO E 578 AURIGO E 431 BADALUCCO D 179 BAJARDO F 900 BORDIGHERA C 5 BORGHETTO D'ARROSCIA D 155 BORGOMARO D 249 CAMPOROSSO C 25 CARAVONICA D 360 CARPASIO E 720 CASTEL VITTORIO E 420 CASTELLARO D 275 CERIANA D 369 CERVO C 66 CESIO E 530 CHIUSANICO D 360 CHIUSAVECCHIA D 140 CIPRESSA D 240 CIVEZZA D 225 -

AVVISO AL PUBBLICO SNAM RETE GAS S.P.A INTEGRAZIONI ALLA
m_amte.MATTM_.REGISTRO UFFICIALE.INTERNA.0042385.08-06-2020 AVVISO AL PUBBLICO SNAM RETE GAS S.p.A INTEGRAZIONI ALLA DOCUMENTAZIONE PER IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE La Società SNAM RETE GAS S.p.A con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara N° 7 ed uffici in Via Cardinal G. Massaia 2 a – 15121 Alessandria, comunica di aver presentato in data 23.05.2019 al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell’art.23 del D.lgs.152/2006, istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto: Metanodotto Sestri Levante - Recco DN 400 (16”) DP 75 bar e opere connesse in Provincia di Genova compreso nella tipologia elencata nell’Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.lgs.152/2006, al punto 1 lett. b), denominata “installazione di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 Km.” di nuova realizzazione e ricadente parzialmente in aree naturali protette comunitarie (siti della Rete Natura 2000). Il progetto è localizzato in Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova nei comuni di Casarza Ligure, Sestri Levante, Ne, Mezzanego, Carasco, San Colombano Certenoli, Leivi, Coreglia Ligure, Cicagna, Tribogna, Uscio, Lumarzo, Sori e Pieve Ligure. Il progetto prevede la nuova realizzazione di un’opera denominata: Metanodotto Sestri Levante - Recco DN 400 (16”) DP 75 bar e opere connesse in Provincia di Genova. L’opera in progetto è costituita da una linea principale con partenza dall’area di lancio e ricevimento “pig”, posta nel territorio comunale di Casarza Ligure (GE) e arrivo nell’area impiantistica in progetto nel comune di Sori (GE). -

Il Ministro Delle Politiche Agricole Alimentari E Forestali
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto di declaratoria eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Liguria dal 02 ottobre 2020 al 03 ottobre 2020. VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi; VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006; MIPAAF - Affari Generali Prot. Interno N.0352028 del 02/08/2021 VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale; VISTI gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, e s.m.i., che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato; VISTO, in particolare, l’articolo 6 che individua le procedure e le modalità per l’attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; VISTO il regolamento (UE) n. -

Rankings Municipality of Pieve Ligure
9/29/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links ITALIA / Liguria / Province of Genova / Pieve Ligure Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH ITALIA Municipalities Powered by Page 2 Arenzano Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Fontanigorda AdminstatAvegno logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Genova Bargagli ITALIA Gorreto Bogliasco Isola del Borzonasca Cantone Busalla Lavagna Camogli Leivi Campo Ligure Lorsica Campomorone Lumarzo Carasco Masone Casarza Ligure Mele Casella Mezzanego Castiglione Mignanego Chiavarese Moconesi Ceranesi Moneglia Chiavari Montebruno Cicagna Montoggio Cogoleto Ne Cogorno Neirone Coreglia Ligure Orero Crocefieschi Davagna Pieve Ligure Fascia Portofino Favale di Propata Malvaro Rapallo Recco Rezzoaglio Ronco Scrivia Rondanina Rossiglione Rovegno San Colombano Certenoli Sant'Olcese Santa Margherita Powered by Page 3 Ligure L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Santo Stefano Provinces Adminstat logo d'Aveto DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH GENOVAITALIA Savignone IMPERIA Serra Riccò LA SPEZIA Sestri Levante SAVONA Sori Tiglieto Torriglia Tribogna Uscio Valbrevenna Vobbia Zoagli Regions Abruzzo Liguria Basilicata Lombardia Calabria Marche Campania Molise Città del Piemonte Vaticano Puglia Emilia-Romagna Repubblica di Friuli-Venezia San Marino Giulia -

Iscritti Albo Sett. a Al 02.07.2021
ALBO 2021 N. matr. Cognome e nome Laurea Residenza Iscriz. Albo Genova Luogo e data di nascita Es. Stato Studio 1a iscrizione Sezione 3514 ABBANEO LUCA GE - 27/10/2004 16137 GENOVA (GE) - VIA MONTALDO 29/10 25/01/06 ALESSANDRIA (AL) 19/12/1977 GE - 05 16121 GENOVA (GE) - VIA XXV APRILE 8/21 25/01/06 GE Tel. 3479604598 A - a architetto 4660 ABBO FRANCESCA GE - 13/12/2000 16146 GENOVA (GE) - VIALE FRANCESCO GAMBARO 19/3 13/02/19 GENOVA (GE) 18/06/1974 GE - 01 16146 GENOVA (GE) - VIALE FRANCESCO GAMBARO 19/3 13/11/09 SV A - a architetto 4116 ACACIA SIMONETTA GE - 13/12/2007 16043 CHIAVARI (GE) - CORSO ITALIA 16F/4 09/03/11 GENOVA (GE) 31/07/1981 GE - 08 16043 CHIAVARI (GE) - CORSO ITALIA 16F/4 09/03/11 GE A - a architetto 1191 ACCETTULLI GIUSEPPE TO - 14/03/1983 16147 GENOVA (GE) - VIA CARRARA 132/1 24/01/84 FOGGIA (FG) 21/10/1953 GE - 83 16147 GENOVA (GE) - VIA A.CARRARA 132/1 24/01/84 GE Tel. 0103761602 A - a architetto 1708 ACCOMANDO ROBERTO GE - 30/04/1987 16134 GENOVA (GE) - VIA DI MONTEMORO 7/7 28/03/90 GENOVA (GE) 08/05/1959 GE - 88 16134 GENOVA (GE) - VIA DI MONTEMORO 7/7 28/03/90 GE Tel. 010210820 A - a architetto 4831 ACCOMASSO CRISTINA GE - 24/04/2020 14100 ASTI (AT) - VIALE PILONE 21 05/03/21 ASTI (AT) 17/07/1994 GE - 20 05/03/21 GE A - a architetto 4618 ACCOTO GIULIANO GE - 28/10/2015 16144 GENOVA (GE) - VIA G. -

Obiettivo Sinergia
2011 O Çéive sìn dicembre PERIODICO DEL L’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIEVE LIGURE SI PUNTA A SVILUPPARE COLLABORAZIONI SU MOLTI SERVIZI AI CITTADINI Pieve, Bogliasco e Sori: obiettivo sinergia DI LORENZO RIZZO Già nel numero di Agosto del Questa iniziativa del nostro Sindaco ha Anno XII numero 4 2010 del “ Çeivesin”, in un edi - attivato un dibattito che è proseguito, dicembre 2011 toriale, il Sindaco Adolfo Ol - anche ma non solo, sulle pagine dei suc - Distribuzione gratuita cese metteva in evidenza cessivi numeri del nostro periodico, con Pubblicazione trimestrale registrata al Tribunale di Genova l’opportunità di sviluppare si - interventi del sindaco di Recco, Dario Ca - (autorizzazione n. 5/2000) nergie tra i Comuni del Golfo Paradiso, purro, del Sindaco di Sori, Luigi Casta - Spedizione in abb.post. 70% anche alla luce del fatto che era stato ap - gnola, e del Sindaco di Bogliasco, Luca art. 2 Legge 662/96 provato un Decreto Legge (78/2010) che Pastorino. Ciascuno di essi, condividendo Direzione Commerciale di Genova. Tassa pagata. In caso di mancato indicava che i Comuni al di sotto dei 5.000 la posizione espressa da Adolfo Olcese, in - recapito restituire alla filiale abitanti avrebbero dovuto in prospettiva dicava la possibilità di sviluppare sinergie di Genova Brignole Grandi Utenti associarsi per assolvere meglio a impor - su molti dei servizi che le Amministrazioni per la restituzione al mittente che s’impegna a pagare tanti funzioni di gestione. locali sono impegnate a erogare ai propri la relativa tassa Nell’intervento del Sindaco Olcese si cittadini, come nei trasporti locali e scola - Periodico prendeva atto, innanzitutto, dell’evidenza stici, per la gestione delle mense scolasti - del Comune di Pieve Ligure che le ridotte dimensioni demografiche e che, nei servizi sociali, per i servizi via Roma, 54 - 16031 Pieve Ligure tel. -

Regione Liguria
Regione Liguria - Uffici postali abilitati Invio delle istanze di nulla osta per l'assunzione di lavoratori stranieri relativamente al lavoro subordinato, domestico, stagionale Provincia Comune Località Denominazione Indirizzo ufficio postale GENOVA GENOVA GENOVA GENOVA 8 VIA S. FRUTTUOSO, 44 R GENOVA GENOVA GENOVA GENOVA 16 VIA ORSINI, 15 R GENOVA GENOVA GENOVA GENOVA 61 VIA MOLASSANA, 76/78 R GENOVA GENOVA GENOVA GENOVA 70 VIA TERPI, 60/62 R GENOVA GENOVA GENOVA GENOVA 68 VIALE G. FRANCHINI, 1 GENOVA GENOVA GENOVA GENOVA 66 PIAZZA SIVELLI, 1 GENOVA GENOVA GENOVA GENOVA 62 VIA STRUPPA, 224 B GENOVA GENOVA GENOVA GENOVA 19 VIA GRANELLO, 7 R GENOVA GENOVA GENOVA GENOVA 7 VIA FRANCESCO POZZO, 2/4/6 R GENOVA GENOVA GENOVA GENOVA 36 CORSO SARDEGNA, 2 ABCDE GENOVA ARENZANO ARENZANO ARENZANO VIALE S. PALLAVICINI, 2 GENOVA BORZONASCA BORZONASCA BORZONASCA VIA MARRE', 2 GENOVA BUSALLA BUSALLA BUSALLA PIAZZA MACCIO', 1 GENOVA CAMOGLI CAMOGLI CAMOGLI VIA CUNEO, 4 GENOVA CAMPO LIGURE CAMPO LIGURE CAMPO LIGURE LARGO FRERA, 2-3 GENOVA CAMPOMORONE CAMPOMORONE CAMPOMORONE PIAZZA MARCONI, 24-25-26-27R GENOVA CARASCO CARASCO CARASCO VIA MONTANARO DISMA, 72/74/76 GENOVA CASARZA LIGURE CASARZA LIGURE CASARZA LIGURE PIAZZA ALDO MORO, 20 GENOVA CASELLA CASELLA CASELLA PIAZZA XXV APRILE, 222 GENOVA CHIAVARI CHIAVARI CHIAVARI PIAZZA N.S. DELL'ORTO, 32 GENOVA COGOLETO COGOLETO COGOLETO PIAZZA MARTIRI LIBERTA', 13 GENOVA COGORNO SAN SALVATORE SAN SALVATORE VIA DIVISIONE CODURI, 51/53 GENOVA DAVAGNA DAVAGNA DAVAGNA VIA BOMBRINI, 14 GENOVA GENOVA GENOVA GENOVA 58 -

LIGURIA Provincia Nome Cognome Cell/Tel
LIGURIA Provincia Nome Cognome Cell/Tel. Disponibilità sul Comune di: Alessandro Navone 3468725234 Genova e comuni limitrofi Alessandro Simonetti 3892625505 Genova e Val Fontana buona 3408736548 Genova, Bogliasco, Pieve Ligure, Sori, Recco, Camogli, Uscio, Lumarzo, Alessio Gaspari 3475942781 Davagna, Montoggio, Bargagli Bogliasco, Pieve Ligure, Sori, Recco, Camogli, Uscio, Campomorone, Ceranesi, Lumarzo, Davagna, Montoggio, Bargagli, Torriglia, Montebruno, 3481497024 Angelo Guerrini Fontanigorda, Rovegno, Gorreto, Rondanina, Propata, Fascia, Valbrevenna, 0108317174 Casella, Savignone, Crocefieschi, Vobbia, Busalla, Ronco Scrivia, Isola del Cantone Antonella Oddino 3384400208 Da Recco a Chiavari Antonio Nino Bruzzone 3351224554 Sant Olcese, Molassana, Genova Tutti i comuni dell'Alta Val Trebbia, Alta Val Bisagno, Alta Valle Scrivia, Val Aurora Silanus 3204669326 Fontanabuona, Val d'Aveto, Sestri Levante, Moneglia, Deiva Marina, Brugnato e tutte le zone limitrofe 3293331118 Genova, Circoscrizione Pegli, Prà, Sestri Voltri e tutta la zona di Montebruno Claudio Barbieri 3396750246 e zone circostanti Val Trebbia 3393601025 Elisabetta Gorlero Zona Tigullio, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Casarza Ligure 0185309459 Enrico Mocka 3924033432 Genova 3881877740 Enzo Arrighini Valbrevenna 0109848775 3387921656 Fabio Damonte Arenzano, Cogoleto, Varazze, Mele, Voltri 109124364 Fabio Orocchi 3483724783 Genova e Provincia, Valle Trebbia Sanremo, Taggia, Terzorio, Riva Ligure, S. Stefano al mare, Pompeiana, Fabio Sappia 3282872418 Cipressa 0185469131 -
Referto Epidemiologico Della Regione Liguria Analisi Standardizzata Per Età Del Complesso Della Mortalità Specifica Per Genere Ed Anno Di Calendario
Referto Epidemiologico della Regione Liguria Analisi standardizzata per età del complesso della mortalità specifica per genere ed anno di calendario nei comuni della Liguria (aggiornamento 2017) A. Russo (dott. economia) – V. Gennaro (medico epidemiologo) Fonte dati: ISTAT 2012-2017 Antonello Russo, Valerio Gennaro. BOZZA 18-2-2019. PAG. 1 Antonello Russo, Valerio Gennaro. BOZZA 18-2-2019. PAG. 2 Indice generale Introduzione..........................................................................................................................................4 Obiettivo...............................................................................................................................................4 Materiali e metodi.................................................................................................................................4 Risultati.................................................................................................................................................7 Popolazione media (POP), numero di decessi osservati (OSS); decessi attesi (ATT); loro differenza media per anno (DIFF/ANNO); Rapporto Standardizzato di Mortalità (SMR) con intervalli di confidenza al 90% (IC90%). Periodo 2012-2017. Riferimento regione LIGURIA. Comuni e Provincia di IMPERIA TABELLA 1. Genere: MASCHI..........................................................................................8 TABELLA 2. Genere: FEMMINE.......................................................................................9 TABELLA 3. -

Prefettura – Ufficio Territoriale Del Governo Di Genova
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Genova Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Liguria Provincia di Genova CONVENZIONE CLASSE TITOLARE F ARENZANO-SORI II FINOCCHIETTI DOMENICO B CAMPO LIGURE-TIGLIETO III MASSACANE DOMENICO B CARASCO-BORZONASCA-COREGLIA LIGURE- SAN COLOMBANO CERTENOLI III CAFFERATA MARISA B CASARZA LIGURE-MOCONESI-NE III DESIDERATO SABINA B CASTIGLIONE CHIAVARESE-PIEVE LIGURE IV AMOROSO DARIO C CICAGNA-ORERO-TRIBOGNA-USCIO IV FORNACIARI FABIO B LAVAGNA-MONEGLIA I/B MORI GRAZIA A LEIVI-PORTOFINO IV TERRAZZINO ELISA C MELE-BARGAGLI-NEIRONE IV MORABITO MASSIMILIANO C RECCO-AURIGO-PRELA’ II BLOISE CRISTINA B SANTA MARGHERITA LIGURE-CAMOGLI I/B VALLESE MASSIMO A SANTO STEFANO D’AVETO-REZZOAGLIO IV SARTORI MARIA CHIARA C SESTRI LEVANTE-SANT’OLCESE I/B SCROCCO DOMENICO A TORRIGLIA-DAVAGNA-FASCIA-LUMARZO IV SALVATORI CRISTIANA B Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Genova Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Liguria Provincia di Imperia CONVENZIONE CLASSE TITOLARE F BORDIGHERA-BADALUCCO I/B MAURELLI LUIGI A BORGOMARO-CHIUSAVECCHIA-SAN LORENZO AL MARE IV NOVENA MARIA B CAMPOROSSO-SOLDANO III PRATA MARCELLO B CIPRESSA-CERVO-RIVA LIGURE III AVEGNO ANGELO B DIANO ARENTINO-DIANO CASTELLO-VILLA FARALDI IV CHIAROLANZA DOMENICO B DIANO MARINA-DIANO SAN PIETRO II MARINO MATTEO B DOLCEACQUA-VALLEBONA IV VEZIANO MONICA C OSPEDALETTI-VASIA III GUNTER MARCO B PROVINCIA DI IMPERIA-VENTIMIGLIA I/A GERMANOTTA ANTONINO A RANZO-DOLCEDO-BORGHETTO D’ARROSCIA IV VIGLIONE FRANCESCA -

Strade Provinciali
ELENCO STRADE PROVINCIALI Descrizione (Prog.va inizio - fine - SP Denominazione Zona Responsabile VALLE Località inizio Località fine Comune) Da: Manesseno (Confine A: Crocetta d'Orero (innesto Comune di Genova) per con la S.P. n. 3 al km Geom. Roberto km 0+000 ÷ 11+662 Comune S. Olcese; 2 di Sant' Olcese P POLCEVERA Arvigo, Piccarello, 11+900) FRANZ km 11+662 ÷ 13+590 Comune Serra Riccò; Sant'Olcese Chiesa, Busalletta Da: Mainetto (Confine A: Casella compreso la km 0+000 ÷ 11+760 Comune Serra Riccò; Comune di Genova) per Variante all'abitato di Geom. Roberto POLCEVERA - 3 di Crocetta d' Orero P Castagna, Pedemonte, Casella (innesto con la S.P. FRANZ Crocetta d'Orero n. 226) km 11+760 ÷ 13+224 Comune Casella SCRIVIA - Da: Pontedecimo (Confine A: Salagiandone (Confine Geom. Roberto km 0+000÷3+245, 3+472÷8+695, 9+410÷15+658 Comune Ceranesi; Comune di Genova) per S. Provinciale con Alessandria) dei Piani di Praglia P POLCEVERA 4 FRANZ km 3+245÷3+472, 8+695÷9+410 Comune Campomorone Martino, Pontasso, Molino Alto di Ceranesi, Praglia Da: Ponte della Gioventina A: Passo della Bocchetta Geom. Roberto (Confine Comune di (Confine Provinciale con della Bocchetta P km 0+000÷8+500 Comune Campomorone POLCEVERA 5 FRANZ Genova), Campomorone, Alessandria) Langasco, Pietralavezzara Da: Campomorone (S.P. n. A: Gattuccio di Geom. Roberto di Isoverde P km 0+000÷8+896 Comune Campomorone POLCEVERA 5) per Langasco, Cravasco Campomorone (S.P. n. 5) 6 FRANZ Geom. Roberto Da: Borgofornari (S.P. n. 35) A: Confine Provinciale con della Castagnola P km 0+000÷2+788 Comune Ronco Scrivia SCRIVIA 7 FRANZ Alessandria Da: Isola del Cantone (S.P.