Stefania Mantovani
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
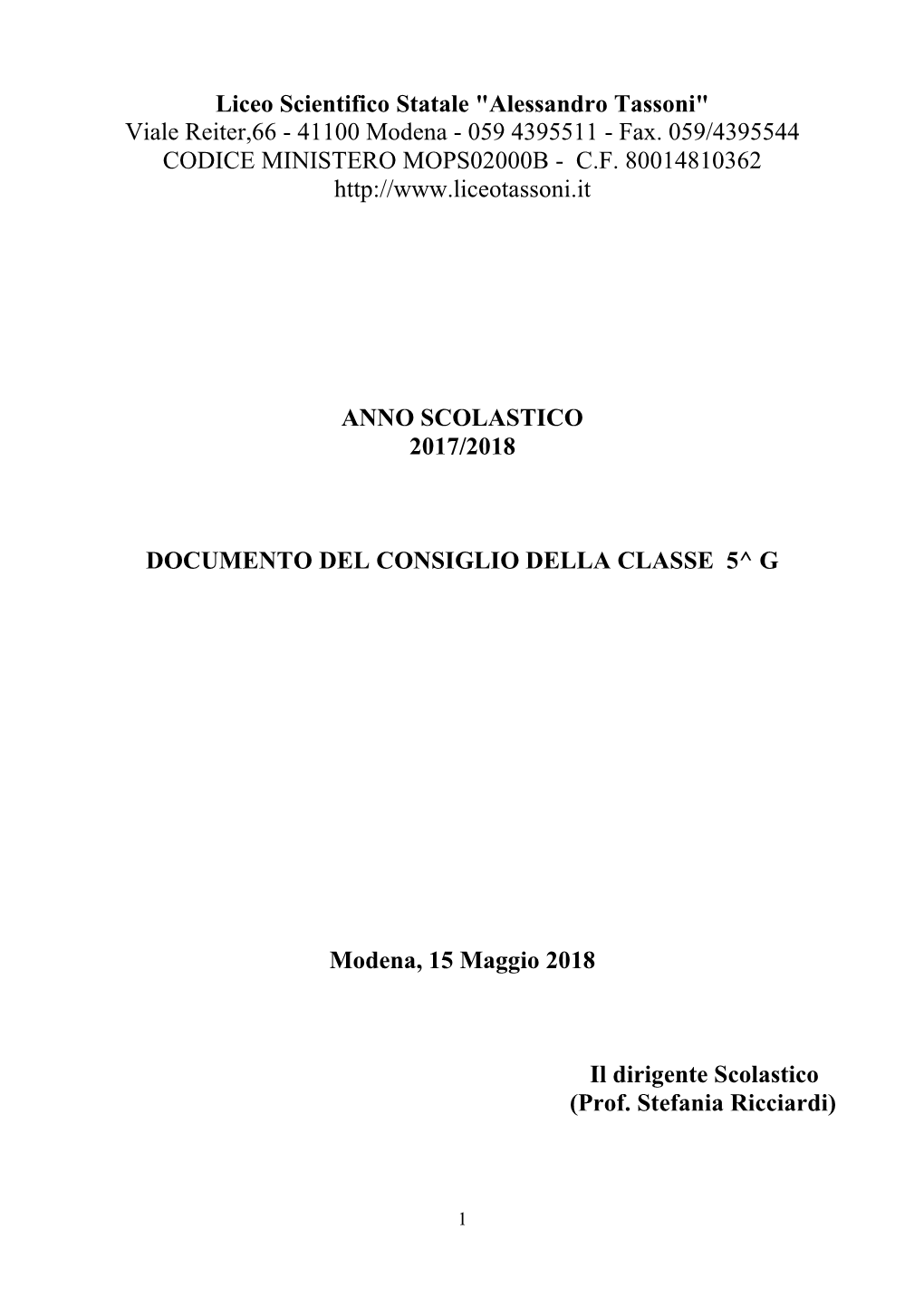
Load more
Recommended publications
-

Heather Buckner Vitaglione Mlitt Thesis
P. SIGNAC'S “D'EUGÈNE DELACROIX AU NÉO-IMPRESSIONISME” : A TRANSLATION AND COMMENTARY Heather Buckner Vitaglione A Thesis Submitted for the Degree of MLitt at the University of St Andrews 1985 Full metadata for this item is available in St Andrews Research Repository at: http://research-repository.st-andrews.ac.uk/ Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10023/13241 This item is protected by original copyright P.Signac's "D'Bugtne Delacroix au n6o-impressionnisme ": a translation and commentary. M.Litt Dissertation University or St Andrews Department or Art History 1985 Heather Buckner Vitaglione I, Heather Buckner Vitaglione, hereby declare that this dissertation has been composed solely by myself and that it has not been accepted in any previous application for a higher degree. I was admitted as a candidate for the degree of M.Litt. as of October 1983. Access to this dissertation in the University Library shall be governed by a~y regulations approved by that body. It t certify that the conditions of the Resolution and Regulations have been fulfilled. TABLE---.---- OF CONTENTS._-- PREFACE. • • i GLOSSARY • • 1 COLOUR CHART. • • 3 INTRODUCTION • • • • 5 Footnotes to Introduction • • 57 TRANSLATION of Paul Signac's D'Eug~ne Delac roix au n~o-impressionnisme • T1 Chapter 1 DOCUMENTS • • • • • T4 Chapter 2 THE INFLUBNCB OF----- DELACROIX • • • • • T26 Chapter 3 CONTRIBUTION OF THE IMPRESSIONISTS • T45 Chapter 4 CONTRIBUTION OF THB NEO-IMPRBSSIONISTS • T55 Chapter 5 THB DIVIDED TOUCH • • T68 Chapter 6 SUMMARY OF THE THRBE CONTRIBUTIONS • T80 Chapter 7 EVIDENCE • . • • • • • T82 Chapter 8 THE EDUCATION OF THB BYE • • • • • 'I94 FOOTNOTES TO TRANSLATION • • • • T108 BIBLIOGRAPHY • • • • • T151 LIST OF ILLUSTRATIONS Plate 1. -
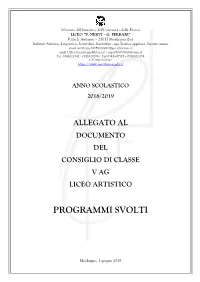
Programmi Svolti
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca LICEO “P. NERVI – G. FERRARI” P.zza S. Antonio – 23017 Morbegno (So) Indirizzi: Artistico, Linguistico, Scientifico, Scientifico - opz. Scienze applicate, Scienze umane email certificata: [email protected] email Uffici: [email protected] – [email protected] Tel. 0342612541 - 0342610284 / Fax 0342600525 – 0342610284 C.F. 91016180142 https://www.nerviferrari.edu.it ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V AG LICEO ARTISTICO PROGRAMMI SVOLTI Morbegno, 3 giugno 2019 RELIGIONE ITALIANO INGLESE STORIA FILOSOFIA MATEMATICA FISICA LABORATORIO GRAFICA DISCIPLINE GRAFICHE_LABORATORIO GRAFICA STORIA DELL’ARTE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ALLEGATO al Documento del Consiglio di classe – V AG Liceo Artistico – a.s. 2018/2019 1 PROGRAMMI SVOLTI LICEO “P. NERVI - G. FERRARI” - Morbegno (SO) MATERIA: RELIGIONE DOCENTE: don DIEGO FOGNINI PROGRAMMA SVOLTO - La responsabilità come impegna di persone autentiche e inserite nella vita quotidiana, non solo scolastica , ma anche sociale - L’etica applicata nelle relazioni, nel proprio lavoro scolastico e non e come deterrente all’illegalità - Fare dell’etica la propria professione - La solidarietà vista come impegno costante in tutte le fragilità sociali che ci circondano - La conoscenza di sé come forza per realizzare progetti di vita [torna all’elenco] ALLEGATO al Documento del Consiglio di classe – V AG Liceo Artistico – a.s. 2018/2019 2 PROGRAMMI SVOLTI LICEO “P. NERVI - G. FERRARI” - Morbegno (SO) MATERIA: ITALIANO DOCENTE: LUIGI NUZZOLI Libri di testo: Roncoroni, Dendi, Il rosso e il blu ed. blu vol. 3, Signorelli Dante, Paradiso, ed. a scelta PROGRAMMA SVOLTO Nota: i titoli delle letture antologiche si riferiscono a quelli del testo in adozione; alcuni testi sono stati forniti in fotocopia 1. -

Državni Izpit ZAKLJUČNI DOKUMENT RAZREDNEGA SVETA 5
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE CON LINGUA D'INSEGNAMENTO SLOVENA Liceo delle scienze umane e liceo scientifico "S. Gregorčič" Liceo classico „P. Trubar“ DRŽAVNI IZOBRAŽEVALNI ZAVOD S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM Humanistični in znanstveni licej „S. Gregorčič“ Klasični licej „P. Trubar“ 34170 GORIZIA GORICA via/Ul. Puccini 14 tel. 0481 82123 – Pres./Ravn. 0481 32387 C.F./D.Š. 91021440317 email [email protected] Državni izpit Šolsko leto 2015/16 ZAKLJUČNI DOKUMENT RAZREDNEGA SVETA 5. RAZREDA ZNANSTVENEGA LICEJA OPCIJA UPORABNE ZNANOSTI Z DNE 15. MAJA 2016 odobren na seji razrednega profesorskega zbora dne 13. maja 2016 po 2. odst. 5. čl. OPR št. 323 z dne 23.7.1998 Zaključni dokument razrednega sveta 5. razreda znanstvene smeri (5.čl. pravilnika) 1. Predstavitev razreda a) Sestava razreda a) Razred sestavlja osem dijakov, pet iz Gorice in okoliških vasi, dva dijaka z Laskega in eden iz tržaške pokrajine. Razred je v prvem letniku stel 16 dijakov; 5 jih je zapustilo razred in zamenjalo smer po prvem letniku, ena dijakinja po drugem letniku, druga dijakinja pa se je v tretjem razredu vrnila v Slovenijo; tretja dijakinja je v cetrtem letniku izbrala studij v tujini. Seznam dijakov 1. Daneluzzo Jaroš 2. Furlan Jan 3. Giacomazzi Cecilia 4. Marvin Elena 5. Muller Philip 6. Pahor Katja 7. Papais Franceso 8. Zio Leonardo b) Po prvem letniku, ko je bilo v razredu zaznati kar nekaj tezav s strani vec dijakov, ki jih gre v glavnem pripisati novemu solskemu okolju in bolj zahtevnemu pristopu do solskega dela, je razred zapustilo sest dijakov. V naslednjih letih je v razredu zavladalo pozitivno in konstruktivno vzdušje tako, da je razred postal homogen kolektiv, v katerem je šolsko delo potekalo tekoce in brez vecjih ovir in zastojev. -

Kolokytha, Chara (2016) Formalism and Ideology in 20Th Century Art: Cahiers D’Art, Magazine, Gallery, and Publishing House (1926-1960)
Citation: Kolokytha, Chara (2016) Formalism and Ideology in 20th century Art: Cahiers d’Art, magazine, gallery, and publishing house (1926-1960). Doctoral thesis, Northumbria University. This version was downloaded from Northumbria Research Link: http://nrl.northumbria.ac.uk/32310/ Northumbria University has developed Northumbria Research Link (NRL) to enable users to access the University’s research output. Copyright © and moral rights for items on NRL are retained by the individual author(s) and/or other copyright owners. Single copies of full items can be reproduced, displayed or performed, and given to third parties in any format or medium for personal research or study, educational, or not-for-profit purposes without prior permission or charge, provided the authors, title and full bibliographic details are given, as well as a hyperlink and/or URL to the original metadata page. The content must not be changed in any way. Full items must not be sold commercially in any format or medium without formal permission of the copyright holder. The full policy is available online: http://nrl.northumbria.ac.uk/policies.html Formalism and Ideology in 20 th century Art: Cahiers d’Art, magazine, gallery, and publishing house (1926-1960) Chara Kolokytha Ph.D School of Arts and Social Sciences Northumbria University 2016 Declaration I declare that the work contained in this thesis has not been submitted for any other award and that it is all my own work. I also confirm that this work fully acknowledges opinions, ideas and contributions from the work of others. Ethical clearance for the research presented in this thesis is not required. -

I Dream of Painting, and Then I Paint My Dream: Post-Impressionism
ART HISTORY Journey Through a Thousand Years “I Dream of Painting, and Then I Paint My Dream” Week Thirteen: Post-Impressionism Introduction to Neo-Impressionisn – Vincent Van Goh – The Starry Night – A Letter from Vincent to Theo – Paul Gaugin - Gauguin and Laval in Martinique - Paul Cézanne, Turning Road at Montgeroult - Paul Cézanne, The Basket of Apples - Edvard Munch, The Scream – How to Identify Symbolist Art - Arnold Bocklin: Self Portrait With Death - Fernand Khnopff, I Lock my Door Upon Myself Der Blaue Reiter, Artist: Wassily Kandinsky Dr. Charles Cramer and Dr. Kim Grant: "Introduction to Neo-Impressionism” smARThistory (2020) Just a dozen years after the debut of Impressionism, the art critic Félix Fénéon christened Georges Seurat as the leader of a new group of “Neo-Impressionists.” He did not mean to suggest the revival of a defunct style — Impressionism was still going strong in the mid- 1880s — but rather a significant modification of Impressionist techniques that demanded a new label. Fénéon identified greater scientific rigor as the key difference between Neo-Impressionism and its predecessor. Where the Impressionists were “arbitrary” in their techniques, the Neo- Impressionists had developed a “conscious and scientific” method through a careful study of contemporary color theorists such as Michel Chevreul and Ogden Rood. [1] A scientific method Pierre-Auguste Renoir, Bal du Moulin de la Galette, 1876, oil on canvas, 131 x 175 cm (Musée d’Orsay) This greater scientific rigor is immediately visible if we compare Seurat’s Neo- Impressionist Grande Jatte with Renoir’s Impressionist Moulin de la Galette. The subject matter is similar: an outdoor scene of people at leisure, lounging in a park by a river or dancing and drinking on a café terrace. -

GEORGES SEURAT (1859-1891) in the Eighteen Eighties, Georges Seurat Stuns the Seurat Offers the Perfect Solution
ENGLISH Master of pointillism GEORGES SEURAT (1859-1891) In the eighteen eighties, Georges Seurat stuns the Seurat offers the perfect solution. He replaces art world with his paintings composed of countless the quick brushstroke of the impressionists dotted – pointillist – brushstrokes. During his with the deliberate dot and the hasty practice of short career, he dies at the early age of thirty-one, working en plein air with the concentrated, time- Seurat paints some fifty works in this new style, consuming studio work. dubbed neo-impressionism by writer and critic Félix Fénéon, which quickly spreads among a group Seurat shares his love of light with the impressionists of young artists. and his subjects are also in keeping with his Seurat develops his revolutionary pointillist predecessors. Like them, he selects themes from technique based on the latest scientific theories modern life in Paris and its surroundings. His in the field of colour and light. His paintings are seascapes, the majority of his painted oeuvre, composed of a combination of miniscule dots and have long been a favourite theme in painting. stripes in complementary colour contrasts. The But unlike the impressionists, Seurat strives unmixed touches of paint blend together in the to depict the world around him reduced to its eye of the observer and create a vibrating effect essence with his new painting method. In that of shimmering light. respect, he finds his young contemporaries from symbolist circles on his side. They also seek a new Seurat is the right person at the right time. Many style with which to capture the timeless essence of his contemporaries are tired of impressionism, of reality. -

Van Gogh Discovers Colour
VAN GOGHGOGH KRIJGT DISCOVERS KLEUR COLOUR NIVEAULEVEL ++++ 1/5 In 1886, Vincent van Gogh went to Paris. There he encountered two new painting movements: impressionism and pointillism. Under the influence of these movements, Van Gogh’s paintings changed radically. A colourful lesson card on dots, dashes and much more! Find the space in the museum with paintings by impressionists, such as Auguste Renoir, Claude Monet and Paul Cézanne. 1 Imagine that you have to tell your class something about the works in this space. You only have 2 minutes to prepare your speech. What quick notes would you make? And which examples would you show? 1. Main impressionistic subjects/themes: Paul Cézanne, 1839 - 1906 La route vers l’ étang, c. 1880 Impressive example of this: 2. Characteristics of the painting style/technique: Impressive example of this: 2 Compare your notes with a classmate. Did you choose the same examples? Who would you find most impressive? The paintings by the impressionists may look old-fashioned to you. But in their day, they were revolutionary. The artists went outside to paint nature and their surroundings in a quick, picturesque style with thin paint. People weren’t used to that! So the general public was not immediately enthusiastic. 3 Look for a work from the same period, which according to you is not impressionistic. Artist: Title: VAN GOGH DISCOVERSKRIJGT KLEUR COLOUR 2/5 4 What are the two main differences (that the general public at that time were perhaps enthusiastic about)? 1 2 Now look at the painting Le Chahut by Georges Seurat (see map). -

Vita Futurista
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΦΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ Γιάννης Πέτκος Vita Futurista Γενεαλογίες του φουτουριστικού ο κινητισμού στον 19 αιώνα Διπλωματική εργασία Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές» Επόπτες Καθηγητές Επίκ. Καθ.: Μήτσος Μπιλάλης Επίκ. Καθ.: Ιωάννα Λαλιώτου Βόλος 2015 Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 10/01/2018 01:46:45 EET - 137.108.70.7 Σ’ αυτούς που τολμούν να ονειρευτούν και ν’ αποτύχουν 1 Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 10/01/2018 01:46:45 EET - 137.108.70.7 2 Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 10/01/2018 01:46:45 EET - 137.108.70.7 Ζ άκεζε απηνπαξαηήξεζε απέρεη πνιχ απφ ην λα καο νδεγεί ζηελ απηνγλσζία: ρξεηαδφκαζηε ηελ ηζηνξία δηφηη ην παξειζφλ ζπλερίδεη λα θπιά κέζα καο κε εθαηφ θχκαηα. Φ. Νίηζε 3 Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 10/01/2018 01:46:45 EET - 137.108.70.7 4 Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 10/01/2018 01:46:45 EET - 137.108.70.7 Περιεχόμενα Ευχαριστίες 7 Ένας κόσμος σε κίνηση 9 Προβληματική της κίνησης 17 Μοντέρνα αντίληψη: μια κινούμενη εικόνα 23 Περπατώντας (και καυγαδίζοντας) στο Παρίσι 28 Από τις οπτικές ψευδαισθήσεις στην 4η διάσταση 40 Cinématism 58 Υουτουριστική σύνοψη 83 Εξομολογητική αποφώνηση υπό τη μορφή συλλογής 85 απομνημονευμάτων Πηγές εικόνων 87 Βιβλιογραφία 93 Υιλμογραφία 105 5 Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 10/01/2018 01:46:45 EET - 137.108.70.7 6 Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 10/01/2018 01:46:45 EET - 137.108.70.7 Ευχαριστίες Αλ αξρίζσ λα ςάρλσ απαξρέο απφ δσ, ζα πξέπεη πξψηα λα επραξηζηήζσ ηνπο κεγάινπο επεξγέηεο ηεο δσήο κνπ: ηε κεηέξα κνπ, ηνπο Metallica θαη ηνλ Νίηζε. -

UNSTITCHING the 1950S FILM Á COSTUMES: HIDDEN
1 UNSTITCHING THE 1950s FILM Á COSTUMES: HIDDEN DESIGNERS, HIDDEN MEANINGS Volume I of II Submitted by Jennie Cousins, to the University of Exeter as a thesis for the degree of Doctor of Philosophy in Film Studies, October 2008. This thesis is available for library use on the understanding that it is copyright material and that no quotation from the thesis may be published without proper acknowledgement. I certify that all material in this thesis which is not my own work has been identified and that no material has previously been submitted and approved for the award of a degree by this or any other University. …………………………………. 2 Abstract This thesis showcases the work of four costume designers working within the genre of costume drama during the 1950s in France, namely Georges Annenkov, Rosine Delamare, Marcel Escoffier, and Antoine Mayo. In unstitching the cinematic wardrobes of these four designers, the ideological impact of the costumes that underpin this prolific yet undervalued genre are explored. Each designer’s costume is undressed through the identification of and subsequent methodological focus on their signature garment and/or design trademark. Thus the sartorial and cinematic significance of the corset, the crinoline, and accessories, is explored in order to determine an ideological pattern (based in each costumier’s individual design methodology) from which the fabric of this thesis may then be cut. In so doing, the way in which film costume speaks as an independent producer of cinematic meaning may then be uncovered. By viewing costume design as an autonomous ideological system, rather than a part of mise-en- scène subordinate to narrative, this fabric-centric enquiry consolidates Stella Bruzzi’s insightful exploration of film costume in Undressing Cinema, Clothing and Identity in the Movies (1997). -

Scientifico Statale “A
LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” Via A. Einstein, 3 20137 Milano DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE (D. P. R. 23 luglio 1998 n. 323, art. 5 c. 2) CLASSE 5a SEZIONE B ANNO SCOLASTICO 2018/2019 INDICE §1. Presentazione della classe ............................................................................................................................................... §2. Composizione del Consiglio di Classe ............................................................................................................................ §3. Obiettivi trasversali ......................................................................................................................................................... §4. Obiettivi di area ............................................................................................................................................................. §5. Modalità di lavoro ........................................................................................................................................................... §6. Strumenti di verifica ....................................................................................................................................................... §7. Valutazione ..................................................................................................................................................................... §7.1 Prima prova ............................................................................................................................................................ -
La Danza Nel Futurismo : Giannina Censi E La Danza Moderna Thesis = the Dance of Futurism : Giannina Censi and Modern Dance
博士学位論文(東京外国語大学) Doctoral Thesis (Tokyo University of Foreign Studies) 氏 名 横田 さやか 学位の種類 博士(学術) 学位記番号 博甲第 174 号 学位授与の日付 2013 年 11 月 6 日 学位授与大学 東京外国語大学 博士学位論文題目 未来派の舞踊 -ジャンニーナ・チェンシとモダン・ダンス- Name Yokota, Sayaka Name of Degree Doctor of Philosophy (Humanities) Degree Number Ko-no. 174 Date November 6, 2013 Grantor Tokyo University of Foreign Studies, JAPAN Title of Doctoral La danza nel futurismo : Giannina Censi e la danza moderna Thesis = The Dance of Futurism : Giannina Censi and Modern Dance La danza nel futurismo : Giannina Censi e la danza moderna Sayaka YOKOTA Tokyo University of Foreign Studies PhD Dissertation Sommario Prefazione ........................................................................................................................................ 1 Capitolo I. Il “secondo” futurismo: il problema della periodizzazione ........................................... 5 Capitolo II. La sensibilità corporea di Marinetti ........................................................................... 29 Capitolo III. Danza e futurismo ..................................................................................................... 51 III. 1. Il futurismo attorno alla danza ........................................................................................ 51 III. 2. “Catalisi” tra il futurismo e i Ballets Russes ................................................................... 75 III. 3. Il doppio filone della danza moderna .............................................................................. 99 Illustrazioni -
Teachers' Resource
TEACHERS’ RESOURCE TOULOUSE-LAUTREC AND JANE AVRIL: BEYOND THE MOULIN ROUGE CONTENTS 1: TOULOUSE-LAUTREC AND JANE AVRIL: BEYOND THE MOULIN ROUGE 2: OUT OF EDEN: THE DEMI-MONDE AND THE STAGE WORLD OF JANE AVRIL 3: ARTIST AND MUSE OR MUSE AND ARTIST? 4: TOULOUSE-LAUTREC: THE MASTER OF PRINTMAKING 5: MUSIC IN MONMARTRE 6: SWEET AND STRANGE: ART AND MADNESS AT THE CLOSE OF THE 19TH CENTURY 7: REGARDE!: NE ME PARLEZ PLUS DU ‘GAY PAREE’ 8: TEACHING RESOURCE CD The Teachers’ Resources are intended for use by secondary schools and colleges and by teachers of all subjects for their own research. Each essay is marked with suggested links to subject areas and key stage levels. The essays are written by early career academics from The Courtauld Institute of Art and are intended to give teachers and students access to the academic expertise available at a world renowned college of the University of London. We hope teachers and educators will use these resources to plan lessons, help organise visits to the gallery or gain further insight into the exhibitions at The Courtauld Gallery. SUGGESTED CURRICULUM LINKS FOR EACH ESSAY ARE MARKED IN BLUE. To book a visit to the gallery or to discuss any of the education projects at The Courtauld Gallery please contact: [email protected] 0207 848 1058 TOULOUSE-LAUTREC AND JANE AVRIL TEACHERS’ RESOURCE Compiled and produced by Joff Whitten Gallery Education Programmer The Courtauld Institute of Art WELCOME The Courtauld Institute of Art runs an exceptional programme of activities suitable for young people, school teachers and members of the public, whatever their age or background.