Scarica Il Booklet
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
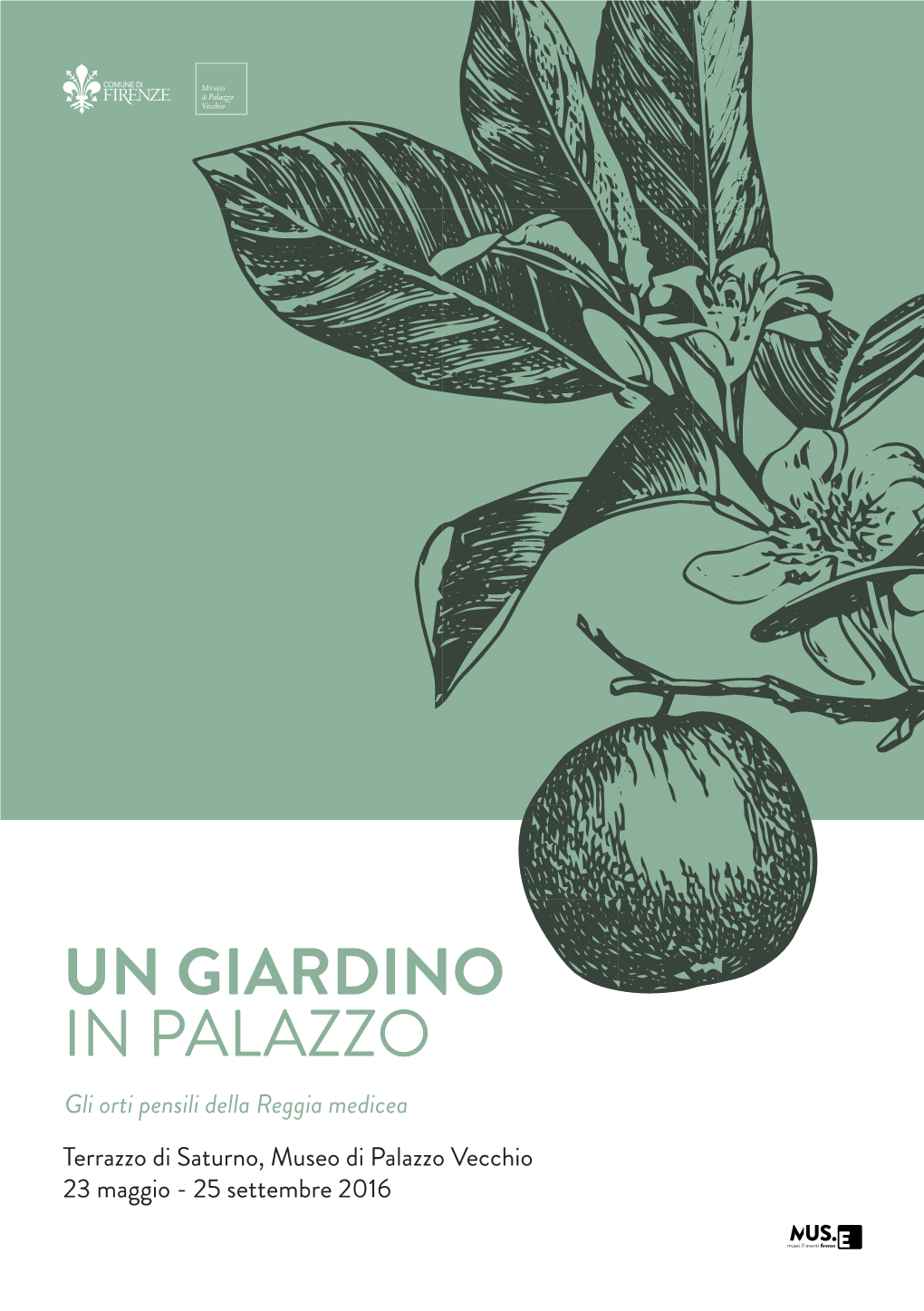
Load more
Recommended publications
-

La Piana Fiorentina, Potenzialità E Progetti Per Il Futuro
Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Sviluppo interculturale dei sistemi turistici Tesi di Laurea La piana fiorentina, potenzialità e progetti per il futuro Relatore Prof. Francesco Vallerani Correlatore Prof. Carlo Giupponi Laureando Elisa Bellini Matricola 855618 Anno Accademico 2015 / 2016 Ringraziamenti Ringrazio innanzitutto la mia famiglia, che mi ha sempre sostenuta ed appoggiata nelle mie scelte e desideri, standomi costantemente accanto. Lorenzo, punto fermo ed ancora, pronto ogni volta ad aiutarmi ed a camminare insieme. Gli amici di una vita, sempre disponibili ad accogliermi ad ogni mio ritorno a casa e con i quali condivido ogni esperienza. Alle amicizie che ho instaurato durante gli anni di università, con le quali non ho spartito solo stress e studio, ma veri momenti di vita di quotidiana ricchi di emozioni ed avventure. Agli amici dell’Erasmus, che nonostante abbia condiviso con loro solo 5 mesi, sono diventati una vera e propria familia madrileña. A tutti coloro che mi hanno aiutato a portare a termine il mio progetto di tesi, con il loro contributo e saggezza. 1 2 Indice Indice delle figure……………………………………………………………………. pag.5 Abstract………………………………………………………………………………..pag.9 Introduzione………………………………………………………………………….pag.11 Capitolo 1: Individuazione del luogo e peculiarità geo-storiche……………………...pag.13 1.1 Ombrone: caratteri geostorici…………………………………………….pag.15 1.1.1 Il contesto idrografico………………………………………………pag.16 1.1.2 Biodiversità…………………………………………………………pag.18 1.1.3 Cenni storici………………………………………………………...pag.19 -

Nome MARCO MOZZO Società/ Ente Qualifica Indirizzo Tel. Ufficio Mob.: E-Mail
CURRICULUM VITÆ INFORMAZIONI PERSONALI Nome MARCO MOZZO Società/ Ente Qualifica Indirizzo Tel. ufficio Mob.: E-mail INCARICHI MIBACT Date (da – a) Dal 29 gennaio 2019 ad oggi Tipo impiego Direttore di livello non dirigenziale (conferimento incarico - 29 gennaio 2019/ prot. 1756) della Villa Medicea della Petraia, del Giardino della Villa di Castello, della Villa medicea di Cerreto Guidi/ Museo della Caccia e del Territorio, del Museo e Galleria Mozzi Bardini. Società/ Ente Polo museale della Toscana Principali mansioni e responsabilità responsabile del personale, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, della conservazione e tutela dei siti museali assegnati, responsabile attività di valorizzazione, ricerca, studio e promozione del patrimonio culturale museale. Nell’ambito delle molteplici attività svolte per la valorizzazione e la conservazione dei siti museali afferenti sotto la mia direzione, sono state intraprese numerose azioni nell’ambito di progetti di manutenzione, tutela e valorizzazione. Date (da – a) Dal 9 settembre 2016 al dicembre 2018 Tipo impiego Referente del Polo museale della Toscana per i servizi educativi (ordine di serv. prot. 4565) di alcuni musei fiorentini (Ville medicee e Cenacoli). Società/ Ente Polo museale della Toscana. Principali mansioni e responsabilità promuove e coordina la progettazione di percorsi didattici e di ricerca promossi in collaborazione con altri enti, segue i rapporti con l’Ufficio Scolastico Regionale. Date (da-a) Dal 27 ottobre 2016 ad oggi Tipo impiego referente del Polo museale della Toscana per l’Unità di Crisi di Coordinamento Regionale (UCCR), ordine di servizio n. prot. 5370. Società/ Ente Polo museale della Toscana. Date (da – a) Dal 5 novembre 2015 al 5 novembre 2018, incarico prorogato fino al 28 gennaio 2019 (ordine di servizio n. -

Florence Florence Can Boast Many Histories – Artistic, Financial, Religious, the Central Point of the City’S Political and Cultural Development
AGENZIA PER IL TURISMO FIRENZE florence Florence can boast many histories – artistic, financial, religious, the central point of the city’s political and cultural development. cultural, political. These are so rich that it is impossible to sum By virtue of its geographic position and social climate, Florence them up in a few short lines. One word, however, has always dis- exercised a function of equilibrium in the history and art of the pe- tinguished the city in the eyes of the world: the Renaissance. riod known as the Renaissance. After various vicissitudes involving the Florentine Republic and history Medici restorations, another historic era started for Florence in a brief 1530 with the establishment of the Grand Duchy of Tuscany. The The early Etruscan settlements sprang up on the hill of Fiesole, power of the city grew, reaching a peak with the defeat of arch-ri- while the Romans established themselves (in 59 BC) on the plain val Siena in 1555. The House of the Medici died out in the 18th around the Arno. The Forum of Roman Florentia was situated where century, giving way to the rule of the Habsburg-Lorraine, under Piazza della Republica stands today, and the inner circle of walls whom Florence also conquered Lucca (1847). Finally, the Duchy ran along today’s Via Tornabuoni, Via Cerretani and Via del Pro- entered the Kingdom of Italy in 1859 following a plebiscite. consolo. Florence was the capital of unified Italy from 1865 to 1870, dur- Miniato and Reparata were the first patron saints of Florence, ing which time Giuseppe Poggi produced an urban planning proj- which became an episcopal see in the 4th century. -

Toscana Itinerari D’Autore
TOSCANA ITINERARI D’AUTORE Alla scoperta del fascino di una meta prediletta dai grandi viaggiatori toscana ITINERARI D'AUTORE Alla scoperta del fascino di una meta prediletta dai grandi viaggiatori La Toscana – con Firenze, Siena, Lucca, il Chianti, la Maremma, i gioghi dell’Appennino – è il punto d’incontro fra l’antico e la modernità, meta prediletta dai viaggiatori del Gran Tour e da milioni di turisti di oggi. Il suo paesaggio è da secoli fonte di ispira- zione per l’umanità e le torri di San Gimignano, le mura di Radda, i castelli della Val d’Orcia, il mare di Livorno, i marmi di Pisa hanno «fatto palpitare molti freddi cuori nordici». I suoi tesori artistici, i teatri e i salotti, i chiassosi mercati e le case coloni- che, i filari dei cipressi e il profumo del vino hanno colpito l’immaginazione di Byron e Goethe, di Mozart e Dickens, di Andersen e Lawrence. Raffinati poemi e melodie ispirati dalla bellezza toscana sono stati scritti da Her- mann Hesse e John Milton, da Ciajkovskij e Franz Liszt, ma altrettanto celeberrimi sono gli scrittori, i collezionisti d’arte, gli storici che hanno fissato la loro residenza in Toscana arricchendola con i loro studi, le loro preziose raccolte, le loro stesse tombe al Cimitero degli Inglesi e degli Allori, a Bagni di Lucca, quali Vieusseux e i De- midoff, Horne e Stibbert. Conoscere le testimonianze artistiche e culturali che questi grandi viaggiatori han- no lasciato in Toscana è un modo inedito di cogliere il fascino di una meta da loro tanto desiderata. -

Florence Fall & Winter Guide 2011 – 2012
FLORENCE FALL & WINTER GUIDE 2011 – 2012 The best places to eat, sleep and play in Florence this fall and winter With more than 50 million reviews and opinions, TripAdvisor makes travel planning a snap for the 50 million travelers visiting our site each month. Think before you print. And if you do print, print double-sided. INTRODUCTION TripAdvisor, the most trusted source for where to eat, sleep and play in thousands of destinations around the world, has collected the best insider tips from its 50 million monthly visitors to produce a unique series of travel guides. In addition to the best hotels, restaurants and attractions for every type of traveler, you’ll get great advice about what to pack, how to get around and where to find the best views. Be sure to check out the guides at www.tripadvisor.com. You’ll find reviews for more than 520,000 hotels, 125,000 vacation rentals, 155,000 attractions and 715,000 restaurants on Inside TripAdvisor.com. Learn from other travelers what to expect before you make your plans. FLORENCE Michelangelo’s famed statue of David, a huge presence (literally and figuratively) in the Galleria dell’Accademia in Florence, is nearly synonymous with the city itself. And for good reason. PACKING TIPS Florence is a city of art, and this 17-foot-tall marble sculpture .1 “Carry small packets of Kleenex for the is an undisputed masterpiece. Florence is the “City of Stone,” bathrooms…’nuff said.”—TripAdvisor from its sidewalks to its doorjambs, and David elevates stone Member to an art form. -
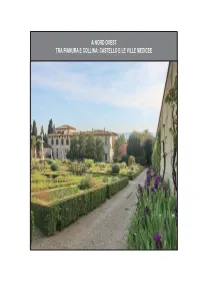
TRA PIANURA E COLLINA: CASTELLO E LE VILLE MEDICEE La Mappa Il Territorio Del Nostro Percorso
A NORD OVEST TRA PIANURA E COLLINA: CASTELLO E LE VILLE MEDICEE La mappa Il territorio del nostro percorso Questo percorso presenta aspetti di assoluto interesse storico, artistico e paesaggistico, in cui spiccano per bellezza, importanza, monumentalità le ville suburbane di svago e delizia: quelle medicee di Castello e Petraia, con i loro meravigliosi giardini all’italiana (non solo natura adattata alla geometria prospettica del verde, ma programma metaforico e simbolico del potere e del prestigio del Principe) e quelle che furono dei Villa di Castello; la grotta degli animali Medici, come Villa Corsini, ma anche Villa La Quiete alle Montalve (anch’essa appartenuta ai Medici) dove, dal 1724, risiedette Anna Maria Luisa de’ Medici, elettrice Palatina, ultima discendente della famiglia. Questa zona, in parte arrampicata sulla collina di Quarto, deve il suo nome all’antico borgo di origine etrusca e romana (Castellum, cioè cisterna, serbatoio d’acqua) su cui passava l’acquedotto fatto costruire dal senatore Marco Opelio Macrino (164-218) e col quale venivano distribuite Villa della Petraia:veduta le acque verso Firenze. Terra elettiva per l’otium e la delizia dei Medici, teatro di eventi fondamentali nella vita della famiglia, oggi la zona preserva, pur assediata a valle dallo sviluppo urbanistico, una sua precisa e straordinaria memoria storica fatta, anche, di strade e viuzze murate a racchiudere porzioni di campagna, antiche case contadine, olivete e poderi, testimonianza di un passato a vocazione agricola basato sull’organizzazione -

Botticelli's Muse
Media Kit for Botticelli’s Muse by Dorah Blume In the villa of his irritating new patron, Renaissance artist Sandro Botticelli feels his creative well run dry—until he accidentally discovers Floriana, a Jewish weaver imprisoned in his sister’s convent. Events threaten to keep his unlikely muse out of reach, and so begins a tale of one of the art world’s most beloved paintings, La Primavera, as Sandro, a confirmed bachelor, and Floriana, a headstrong artist in her own right, enter into a turbulent relationship. Sales, Marketing, and Publicity Contacts: Deborah Bluestein, Publisher Juiceboxartists Press, 617-733-9016 [email protected] P.O. Box 230553, Boston, MA 02123 Juiceboxartists Press Botticelli’s Muse by Dorah Blume About the Book Relegated to an obscure Medici villa and the whims of an annoying patron half his age, Renaissance artist Sandro Botticelli falls into indecision and depression. Once he meets Floriana, a Jewish weaver held prisoner at a near- by convent under the control of Sandro’s estranged older sister, Oslavia, everything changes. Although the Medici hold the purse strings, Floriana— the inspiration behind his painting La Primavera—holds his heart strings. All the while, the religious fanatic Savonarola watches and waits to renounce Sandro’s work and threaten the safety of his muse and her unborn child. A tanner’s son, Sandro lives in a world of nobles, philosophers, and intellectuals, yet never belongs to it. Whether to love and leave his work behind, or love his work and leave Floriana behind—Botticelli’s divided loyalties torment him. How long can he refuse to choose? THe first of a three-volume series that begins in 1477 and culminates with Sensuous and provocative as well as the execution of Girolamo Savonarola in 1498, book one, Botticelli’s Muse, mysterious . -

Le Collezioni Delle Porcellane Cinesi Al Tempo Dei Medici
LE COLLEZIONI DELLE PORCELLANE CINESI AL TEMPO DEI MEDICI La porcellana orientale era il filo conduttore del collezionismo di oggetti esotici in Toscana, era presente nelle collezioni Medicee sempre in forma crescente fino a raggiungere l’apice nel 1700. Difficile era però individuare la provenienza dei manufatti se cinesi o giapponesi o addirittura italiani, data la descrizione che veniva riportata negli inventari sotto la voce generica di “porcellana”. Il gusto per l’esotico comprendeva anche altre curiosità come le giade, i tessuti, le armi, che venivano raccolte nelle così dette “camere delle meraviglie” e che in genere ogni palazzo signorile ne possedeva una più o meno fornita, questa forma d’interesse per le scienze, la botanica la matematica, la cartografia e la filosofia era stato il corpus del fermento del pensiero del Rinascimento fiorentino che animava l’attività intellettuale della città sotto la guida umanistica dei Medici, fino al suo massimo con la scuola neoplatonica. Il primo esempio di camera delle meraviglie lo possiamo rintracciare nella raccolta di Piero il Gottoso che aveva allestito un piccolo ambiente nei suoi appartamenti del palazzo di via Larga, attuale Palazzo Medici Riccardi. Successivamente Lorenzo il Magnifico approfondisce i suoi interessi culturali e l’allestimento delle sue collezioni con ogni sorta di oggetti insoliti provenienti dall’Oriente con particolare riferimento alla porcellana cinese. La raccolta è documentata già nei primi anni del 1400, alcuni oggetti vennero offerti a Lorenzo il Magnifico come doni di Stato e scambi diplomatici e comprendevano vasellame cinese bianco e blu e Celadon. Foto n. 1 Dono a Lorenzo de Medici del sultano d'Egitto. -
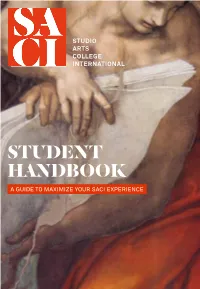
STUDENT HANDBOOK a GUIDE to MAXIMIZE YOUR SACI EXPERIENCE Front and Back Cover Images: Details of Michelangelo’S Sistine Chapel
STUDIO ARTS COLLEGE INTERNATIONAL STUDENT HANDBOOK A GUIDE TO MAXIMIZE YOUR SACI EXPERIENCE Front and back cover images: details of Michelangelo’s Sistine Chapel. SACI STUDENT HANDBOOK A Guide to Maximize Your SACI Experience Studio Arts College International Palazzo dei Cartelloni Via Sant’Antonino 11 50123 Florence - ITALY T (+39) 011 055 289948 F (+39) 011 055 2776408 [email protected] www.saci-florence.edu 4 CONTENTS Welcome..................................................7 SACI Mission Statement............................8 SACI Facilities.............................................9 School Regulations and Policies.............10 Housing................................................14 Other SACI Services..................................17 Visitors...............................................18 SACI Academic Information.....................20 Course Information....................20 Financial Information...............22 SACI Field Trips.........................................24 Florence’s Schedule.................................26 Health and Safety ...................................27 Fitness Facilities.......................27 Medical Information.................28 Safety Information....................31 Communication.....................................35 Telephone...............................35 Faxes, Photocopies, and IDs......37 Email and Internet....................37 Mail.....................................38 Money Transactions.................................39 Getting Around in Florence.....................41 -

Management Plan Men Agement Plan Ement
MANAGEMENTAGEMENTMANAGEMENTEMENTNAGEMENTMEN PLAN PLAN 2006 | 2008 Historic Centre of Florence UNESCO WORLD HERITAGE he Management Plan of the His- toric Centre of Florence, approved T th by the City Council on the 7 March 2006, is under the auspices of the Historic Centre Bureau - UNESCO World Heritage of the Department of Culture of the Florence Municipality In charge of the Management Plan and coordinator of the project: Carlo Francini Text by: Carlo Francini Laura Carsillo Caterina Rizzetto In the compilation of the Management Plan, documents and data provided di- rectly by the project managers have also been used. INDEXEX INDEX INTRODUCTIONS CHAPTER V 45 Introduction by Antonio Paolucci 4 Socio-economic survey Introduction by Simone Siliani 10 V.1 Population indicators 45 V.2 Indicators of temporary residence. 46 FOREWORD 13 V.3 Employment indicators 47 V.4 Sectors of production 47 INTRODUCTION TO THE MANAGEMENT 15 V.5 Tourism and related activities 49 PLANS V.6 Tourism indicators 50 V.7 Access and availability 51 FIRST PART 17 V.8 Traffi c indicators 54 GENERAL REFERENCE FRAME OF THE PLAN V.9 Exposure to various sources of pollution 55 CHAPTER I 17 CHAPTER VI 56 Florence on the World Heritage List Analysis of the plans for the safeguarding of the site I.1 Reasons for inclusion 17 VI.1 Urban planning and safeguarding methods 56 I.2 Recognition of Value 18 VI. 2 Sector plans and/or integrated plans 60 VI.3 Plans for socio-economic development 61 CHAPTER II 19 History and historical identity CHAPTER VII 63 II.1 Historical outline 19 Summary -

Orari D'apertura Opening Hours
Orari d'apertura Opening hours dei luoghi d'interesse of the places of interest Ultimo aggiornamento/ Last Update 30/05/2021 LEGENDA E NOTE GLI UFFIZI 17 MUSEO DEL MUSEI COMUNALI ALTRI MUSEI SINAGOGA Legenda & Notes FC Piazzale degli Uffizi 1 BARGELLO 31 MUNICIPAL MUSEUMS OTHER MUSEUMS E MUSEO EBRAICO 48 c 8:15-18:50 Accessibile ai disabili / FC Via del Proconsolo 4 Gratis per minori di 18 anni, BIBLIOTECA MEDICEA FC Via L.C. Farini 6 g lun / Mon g temporaneamente chiuso/ Accessible for disabled c lun-ven / Mon-Fri disabili e accompagnatore. LAURENZIANA 1 temporarily closed (PC/RS lun-ven/Mon-Fri) 8:45-13:30 Riduzioni per tutti tra i 18 e i 25 Piazza San Lorenzo 9 c orari di apertura / anni e studenti universitari. / € 20,00 mar-ott / Mar-Oct sab / Sat 8:45-19:00 g temporaneamente MUSEO STIBBERT 38 opening hours a a a Free under 18, disabled and € 12,00 nov-feb / Nov-Feb 1 , 3 , 5 dom del mese / chiuso/ temporarily closed FC Via Stibbert 26 g giorni di chiusura / include ingresso a / includes free 1st,3rd, 5th Sun of the month carer. Reductions for everybody c lun-mer / Mon-Wed between 18 & 25 and university MUSEO DI CASA closing days entrance to Museo Archeologico 8:45-13:30 10:00-14:00 students. BUONARROTI 21 FC Firenze Card & Opificio delle Pietre Dure 2a e 4a dom del mese / ven-dom / Fri-Sun ------------------------------------- FC Via Ghibellina 70 firenzecard.it PALAZZO PITTI 42 -47 2nd & 4th Sun of the month 10:00-18:00 http://bigliettimusei.comune.fi.it c sab-lun / Sat-Mon PC prenotazione consigliata/ Piazza Pitti 1 9:00-14:00 g gio / Thu Acquisto con prenotazione/ 10:00-16:30 /RS reservation suggested FC GALL. -

Florence City Guide
www.firenzeturismo.it www.firenzeturismo.it LIBERA Florence City Guide Guida alla città di Firenze 2 0 1 1 1 2 A CITY GUIDE TO FLORENCE of Renaissance art by the likes of Botticelli, One day in Florence Filippo Lippi, Paolo Uccello, Leonardo da One day in Florence: the city deserves a little longer than that, but a one-day visit will at least give you an Vinci and Michelangelo. A visit to the gal- idea. With just one day at your disposal, you will want to see the main sites and walk around the heart of the lery requires several hours. If you do not historic city centre. have time, continue on foot towards Ponte Start from Piazza del Duomo, where the Baptistery and the cathedral of Santa Maria del Fiore face each Vecchio, another symbol of the city, which other. The cathedral was begun by Arnolfo di Cambio in 1296, but it was not until 1436 that it was crow- has survived wars and flooding. Since the ned by the Cupola, Filippo Brunelleschi’s Guida alla città/City Guide 16th century, the buildings on the bridge masterpiece. The dome is the symbol of have been occupied by goldsmiths. Florence, a bold and majestic piece of ar- Crossing the bridge, you find yourself di là chitecture that affords fantastic views of d’Arno, that is, ‘beyond the Arno’, an impor- the city (and of the cathedral interior). On tant notion in Florence. Of the four historic the façade side of the cathedral is the bol- neighbourhoods, three (San Giovanni, San- dly coloured campanile of Giotto, which ta Maria Novella and Santa Croce) are north also has fine views of the city.