Scaricabile In
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
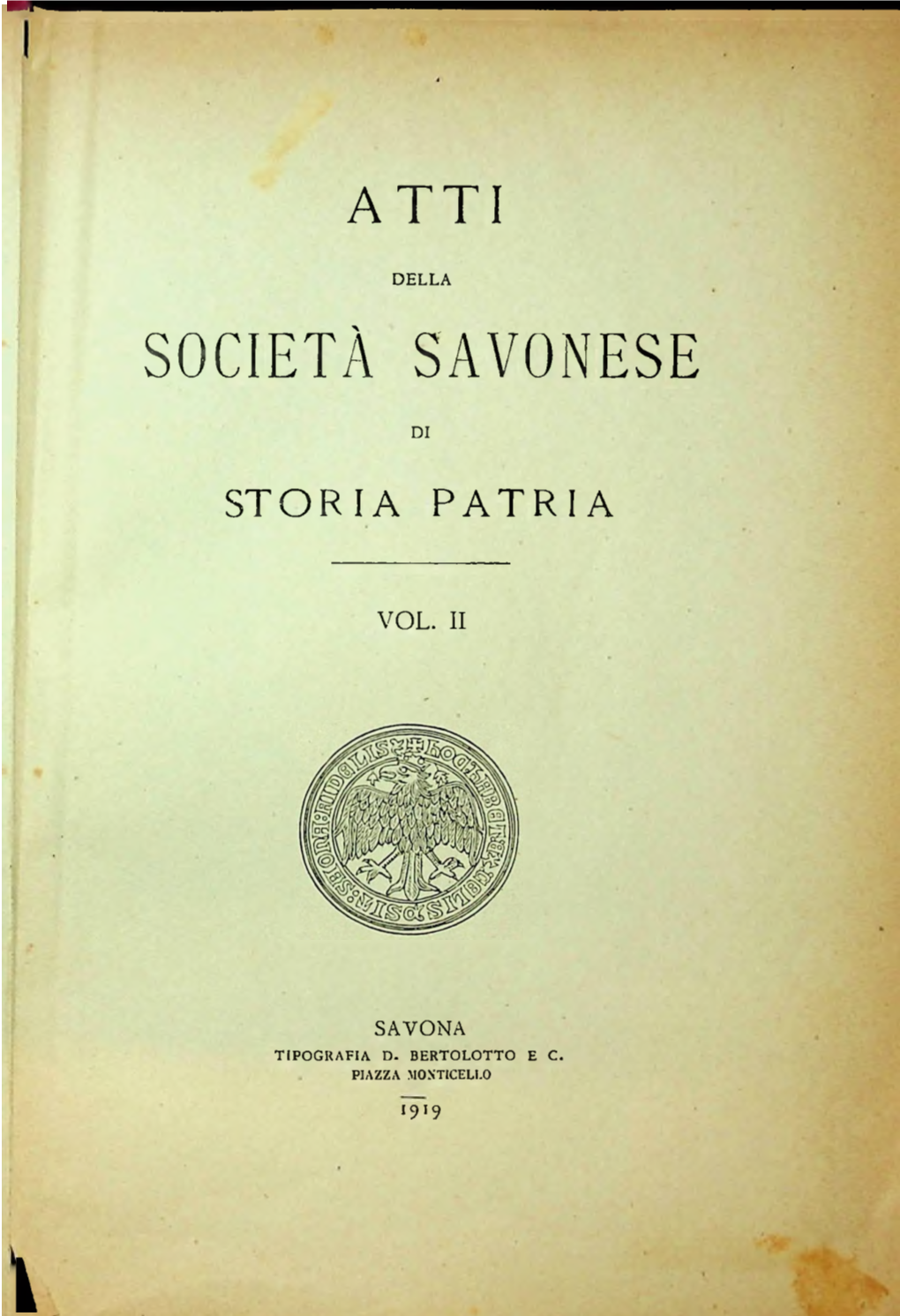
Load more
Recommended publications
-

'In the Footsteps of the Ancients'
‘IN THE FOOTSTEPS OF THE ANCIENTS’: THE ORIGINS OF HUMANISM FROM LOVATO TO BRUNI Ronald G. Witt BRILL ‘IN THE FOOTSTEPS OF THE ANCIENTS’ STUDIES IN MEDIEVAL AND REFORMATION THOUGHT EDITED BY HEIKO A. OBERMAN, Tucson, Arizona IN COOPERATION WITH THOMAS A. BRADY, Jr., Berkeley, California ANDREW C. GOW, Edmonton, Alberta SUSAN C. KARANT-NUNN, Tucson, Arizona JÜRGEN MIETHKE, Heidelberg M. E. H. NICOLETTE MOUT, Leiden ANDREW PETTEGREE, St. Andrews MANFRED SCHULZE, Wuppertal VOLUME LXXIV RONALD G. WITT ‘IN THE FOOTSTEPS OF THE ANCIENTS’ ‘IN THE FOOTSTEPS OF THE ANCIENTS’ THE ORIGINS OF HUMANISM FROM LOVATO TO BRUNI BY RONALD G. WITT BRILL LEIDEN • BOSTON • KÖLN 2001 This book is printed on acid-free paper. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Witt, Ronald G. ‘In the footsteps of the ancients’ : the origins of humanism from Lovato to Bruni / by Ronald G. Witt. p. cm. — (Studies in medieval and Reformation thought, ISSN 0585-6914 ; v. 74) Includes bibliographical references and indexes. ISBN 9004113975 (alk. paper) 1. Lovati, Lovato de, d. 1309. 2. Bruni, Leonardo, 1369-1444. 3. Latin literature, Medieval and modern—Italy—History and criticism. 4. Latin literature, Medieval and modern—France—History and criticism. 5. Latin literature, Medieval and modern—Classical influences. 6. Rhetoric, Ancient— Study and teaching—History—To 1500. 7. Humanism in literature. 8. Humanists—France. 9. Humanists—Italy. 10. Italy—Intellectual life 1268-1559. 11. France—Intellectual life—To 1500. PA8045.I6 W58 2000 808’.0945’09023—dc21 00–023546 CIP Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Witt, Ronald G.: ‘In the footsteps of the ancients’ : the origins of humanism from Lovato to Bruni / by Ronald G. -

Le Famiglie Ei Minori
Bilancio Sociale di Fine Mandato 2012 - 2016 SOMMARIO 8 La comunità cairese Il territorio, la popolazione, le risorse BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO Il territorio comunale La popolazione residente Gli stranieri Coordinamento e gestione del Progetto Le risorse economiche Matteo Pennino Capogruppo di Maggioranza 18 Lo sviluppo sostenibile in collaborazione con le opere pubbliche, le attività produttive, la sicurezza Sviluppo Informatico e Tecnologico, Cultura e Turismo La tutela del paesaggio del Comune di Cairo Montenotte La pianificazione urbanistica Le opere pubbliche Lo S.U.A.P. Si ringraziano per la collaborazione Il Commercio gli Assessori, i Dirigenti e i dipendenti La sicurezza di tutti gli Uffici del Comune, potuto realizzare 40 Vivere nella comunità il Bilancio Sociale di Fine Mandato. Le famiglie, i minori, la scuola, le persone disabili, gli anziani, le politiche abitative Le famiglie I minori La scuola Il Bilancio Sociale di fine Mandato Le persone disabili è pubblicato sul sito del Comune Gli anziani www.comunecairomontenotte.gov.it Le politiche sociali abitative 46 Condividere le conoscenze La cultura, la comunicazione, lo sport, la solidarietà Le foto di pagina 2, 7, 17, 39 e 53 sono di La cultura Silvano Baccino La comunicazione Le foto di pagina 30, 34 e 59 sono di Lo sport Marco Mastrantonio La solidarietà La foto di pagina 12 è di Punto a Capo 54 Il governo della Città Il Sindaco La Giunta Questa pubblicazione è stata chiusa in redazione il 24 marzo 2017 Il Consiglio comunale Le risorse umane Le Società partecipate Bilancio Sociale di Fine Mandato 2012 - 2016 4 Bilancio Sociale di Fine Mandato 2012 - 2016 5 Bilancio Sociale di Fine Mandato 2012 - 2016 I valori in cui crediamo Il Comune di Cairo Montenotte è Ente Locale Autonomo, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. -

Sandra Macchiavello Quiliano Tra Genova E Savona: Un Contrasto Secolare
Sandra Macchiavello Quiliano tra Genova e Savona: un contrasto secolare. Dagli atti di una causa del 1264 [A stampa in «Atti della Società ligure di storia patria», n.s. 35 (1995), 1, pp. 61-144 © dell’autrice - Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”, www.retimedievali.it]. * ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA NUOVA SERIE XXXV (CIX) FASC. I GENOVA — MCMXCV NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA PALAZZO DUCALE - PIAZZA MATTEOTTI, 5 SANDRA MACCHIA VELLO QUILIANO TRA GENOVA E SAVONA: UN CONTRASTO SECOLARE Dagli atti di una causa del 1264 Intorno agli anni ’60 del secolo XIII, dopo il lungo conflitto per l’affer mazione territoriale nel Ponente ligure, che ha condotto Savona a trattare con Genova la pace di Varazze del 1251, il territorio controllabile da Quiliano è più che mai oggetto di tensione fra i due comuni che da tempo si fronteggia no. E vero che le fonti documentarie presentano elementi per delineare un quadro generale dello svolgimento della contesa, i cui primi segnali si manife stano già prima del trattato di Varazze, ma non sempre è possibile trovare un filo conduttore che colleghi le diverse notizie. Nuovi dati che permettono di integrare le lacune lasciate dalle fonti già note relativamente alla controversia sono emersi dal ritrovamento di un manoscritto, conservato presso l’Archivio di Stato di Genova, contenente 16 deposizioni testimoniali raccolte tra il 16 e il 23 ottobre 1264 su mandato di Giacomo Solbrito, giudice e assessore del podestà di Genova Guglielmo Scarampi, entrambi astigiani1. Le testimonian ze sono sollecitate per chiarire se il comune di Genova abbia o meno il diritto di appaltare i proventi della “castellania” che comune Sagone dicit non debere incantari. -

Barbieri Arnaut De Maroill E L'italia Dei Trovatori
Lecturae tropatorum 13, 2020 http://www.lt.unina.it/ – ISSN 1974-4374 http://www.lt.unina.it/Barbieri-2020S.pdf RIASSUNTO · ABSTRACT Luca Barbieri Arnaut de Maroill e l’Italia dei trovatori Il perigordino Arnaut de Maroill è senza dubbio un trovatore la cui importanza, per la qualità e l’influenza della sua produzione, non è stata finora adeguatamente riconosciuta. Alcune caratteristiche del suo stile poetico ne fanno supporre un ruolo rilevante, benché ancora ine- splorato, nella fissazione e diffusione di formule e immagini che dan- no consistenza all’ideale della fin’amor. La scarsa attenzione riserva- tagli dagli studiosi va di pari passo con la sostanziale assenza di riferi- menti a personaggi ed eventi storici nella sua opera e con la mancanza di documenti che possano fornire qualche informazione sulla sua attivi- tà. Tutto quello che si sa di lui è riconducibile al contenuto della vida e delle razos medievali,1 la cui affidabilità è notoriamente soggetta a estrema cautela: Arnaut avrebbe amato la contessa Adelaide di Bur- lats, figlia del conte Raimondo V di Tolosa e sposa dal 1171 del vi- sconte di Béziers Ruggero II Trencavel, citata e celebrata anche da di- versi altri trovatori.2 La relazione cortese avrebbe suscitato la gelosia del re d’Aragona Alfonso II, anch’egli innamorato di Adelaide, che avrebbe costretto la contessa a congedare il trovatore, il quale sarebbe 1 Si veda Jean Boutière e Alexander H. Schutz, Biographies des troubadours: textes provençaux des XIIIe et XIVe siècles, Paris 19642, pp. 32-38. 2 Per esempio Guillem de Berguedan, Reis, s’anc nuill temps foz francs ni larcs donaire (BdT 210.17), vv. -

N°15 Del 18 Aprile 2021
Poste Italiane S.p.A. SETTIMANALE D’INFORMAZIONE | ANNO 119 | N. 15 | € 1,50 Spedizione in abb. postale D.L. 353/2003 giornale locale DOMENICA 18 APRILE 2021 Giornale (conv. in L. 27/02/2004 nº 46) P.I.: 15/04/2021 Identità art. 1, comma 1, Piemonte MP-NO/AL n. 0556/2011 DCOIO0047 RICALDONE STREVI BISTAGNO Brutta “la gelata Il centro vaccinale Inaugurato della brina” comunale il punto vaccinale gravi danni a vigneti, in onda nella palestra frutta e verdure su radio e televisione comunale A pagina 13 A pagina 15 A pagina 19 Intervista all’on. Federico Fornaro sul Recovery Plan La Regione non ha favorito progetti capaci di andare al di là dei confini dei Comuni Acqui Terme. Non c’è an- rizzati su queste due missioni: razione “Bottom-up”, ma esat- dato troppo per il sottile, l’ono- digitale e transizione ecologi- tamente al contrario. Certo, revole Federico Fornaro, nella ca». può piacere o no. Ma è così, e valutazione del documento Quindi? se non si capisce si rischia di presentato a Roma dalla Re- «Quindi è del tutto evidente perdere un’occasione. Si par- gione Piemonte per quanto che si è sbagliato l’approccio. te dall’Europa, si arriva all’Ita- concerne il Recovery Plan. Il modo giusto di operare non lia, e poi si scende sul territo- «Assomiglia molto a una bu- può essere mettere solo insie- rio». ca delle lettere di Babbo Nata- me i progetti dei Comuni, im- Ma non può esserci in qual- le». pacchettarli e spedirli a Roma. che misura un coinvolgimento Secondo il capogruppo di Li- Questa non è una sfida della delle periferie anche in fase di beri e Uguali alla Camera, Regione Piemonte, è una sfida ideazione? Con la zona arancione è ripreso il mercato cittadino nonché parlamentare di riferi- del sistema-Paese». -

Angelo Arata Spade E Denari
Angelo Arata Spade e denari. Manfredino del Carretto, un capitano di guerra tra Piemonte e Liguria nel primo Trecento* [A stampa in “Rivista di Storia, Arte Archeologia per le Province di Alessandria e Asti”, CXI/2 (2002), pp. 311-390 © dell’autore - Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”] «... in pace vivere et tranquilla quiete...»: questo appare, in sostanza, il desiderio che spinge Manfredino del Carretto ed il figlio Ottone a cedere i loro vasti domini in favore del marchese Manfredo di Saluzzo nel 1322. Queste parole, che emergono vividamente dal documento di cessione 1 , forniscono una risposta umana, che rimanda alla sfera “privata” dei sentimenti, alle domande relative ai motivi per cui una delle stirpi carrettesche più potenti per territori ed influenza politica avrebbe rinunciato ai suoi vasti domini per accontentarsi di pochi feudi montani ed eclissarsi, poco dopo, dalla scena politica del Piemonte meridionale. La prospettiva intimistica, pur non rispondendo in modo per noi accettabile a queste domande, aggiunge l’intensità del “vissuto” umano all’interpretazione storiografica che vede nella drammatica scomparsa delle antiche dinastie aristocratiche la crisi di poteri locali non in grado di reggere alla spinta espansionistica di altre famiglie aristocratiche, tese a costruire un principato di vaste proporzioni, e quindi dei ceti urbani, caratterizzati da un forte dinamismo e da solidi capitali finanziari. Questa prospettiva si coglie nell’intervento di Renato Bordone in un recente convegno acquese, che delinea in un suggestivo affresco il processo che vede la nobiltà di spada dei Del Carretto lasciare il passo ai marchesi di Saluzzo e quindi al denaro delle nuove classi dominanti le città italiane, composte da uomini intraprendenti, con lo sguardo aperto alle ampie dimensioni del mercato e della politica internazionale, ma in fondo sensibili ai valori cavallereschi e risoluti a seguire le antiche tradizioni aristocratiche 2 . -

Alla Ricerca Della “Magistra Langarum”
Associazione Ligure per lo Sviluppo degli Studi Archeoastronomici Circolare n° 34 Febbraio 2021 Alla ricerca della “Magistra Langarum” Premessa Le Langhe furono colonizzate dai Romani attorno al II secolo a.C. Dopo aver ottenuto il predominio sulle numerose tribù liguri della zona, i vincitori cominciarono a realizzare una fitta rete viaria, col duplice scopo di muovere gli eserciti (e quindi di mantenere l’ordine) ma anche di favorire e potenziare gli scambi commerciali. Una di queste strade, la via Æmilia Scauri (dal nome del censore Marco Emilio Scauro cui è legata la sua costruzione attorno al 109 a.C.), secondo la testimonianza del geografo greco Strabone (64/63 a.C. - 25 d.C.), metteva in comunicazione la città di Luna (l’odierna Luni) con Vada Sabatia (Vado Ligure), scavalcando nel suo tragitto gli Appennini e passando attraverso le città di Placentia (Piacenza), Derthona (Tortona), Aquae Statiellae (Acqui Terme) e il Colle di Cadibona. Lungo il suo percorso sorsero, nel corso del tempo, numerosi centri abitati, ricchi di storia e di arte. Tra questi ricordiamo, ad esempio, la cittadina di Cortemilia con la Pieve di Santa Maria (fine del XII secolo) e il suo stupendo bassorilievo, la cui iconografia mistica, ricca di simboli a carattere astronomico, si ricollega all’eclisse totale di Sole del 3 giugno 1239 (vedi Veneziano G., 2012 , Astronomia e simbolismo mistico nella pieve romanica di S. Maria in Cortemilia, Atti del XIV Seminario di Archeoastronomia ALSSA, pp. 30-73). In età imperiale, questa via fu parzialmente sovrapposta da una strada consolare, denominata Iulia Augusta , la cui costruzione iniziò per volere dell’imperatore Ottaviano Augusto attorno al 13 a.C., strada che costituì il maggiore collegamento terrestre tra la pianura Padana, la riviera ligure di ponente, la Gallia Narbonense e la Spagna. -

A Campanassa
Campanassa 1-2016.qxd 22-03-2016 17:17 Pagina 1 NOTIZIARIO TRIMESTRALE DI STORIA, ARTE, CULTURA, ECONOMIA E VITA SOCIALE - Direzione e Amministrazione: SAVONA - Piazza Brandale, 2. ANNO XLIV - NUMERO 1/2016 - Direttore: Carlo Cerva. - Dir. resp.: Fabio Sabatelli. Stampa: Marco Sabatelli Editore, Savona - Aut. Trib. Savona - N. 217 del 21-12-73 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Direzione Commerciale Business Savona. CITTÀ DI SAVONA A CAMPANASSA 10 aprile 1191 - 10 aprile 2016 825º Anniversario “Savona Libero Comune” Invito Domenica 10 aprile 2016 Programma ore 16,00 Raduno in Piazza del Brandale ore 16,30 Partenza del corteo e sfilata lungo le vie del centro storico medievale al suono dei rintocchi della Campanassa Sabato 12 marzo 2016 alle ore 17,30 nella basilica del Santuario di Savona è stato presentato da Fulvio Cervini, ore 17,00 docente di Storia dell’Arte Medievale presso l’Università Piazza del Brandale degli Studi di Firenze, il volume “SPLENDE IL TEMPIO ADORNO” Studi e restauri per il Santuario di Nostra Signora della Misericordia a Savona edito dalla Marco Lettura dell’Editto con il quale Sabatelli Editore. il Marchese Ottone del Carretto A trent’anni di distanza dalla monografia La Madonna di vendette le terre savonesi al Podestà rendendo Savona (novembre 1985), esce un nuovo volume di studi sul “Savona Libero Comune” Santuario. Già dal titolo Splende il tempio adorno, tratto dal componimento di un poeta savonese del Settecento, il libro Da fine cerimonia sino alle ore 19,30 e, annuncia il proprio obiettivo: far luce sulle vicende decorative dopo un intervallo, dalle ore 21,00 sino alle ore 23,30 della chiesa con uno sguardo rivolto alla molteplicità e varietà visita al Complesso del Brandale: dei suoi aspetti artistici. -

Società Savonese Di Storia Patria
ATTI DELLA SOCIETÀ SAVONESE DI STORIA PATRIA V. I t. 2° wasF SAVONA TIPOGRAFIA D. BERTOLOTTO E C. PIAZZA PONTICELLO 1919 ì ! LE PERGAMENE DELL’ARCHIVIO COMUNALE DI SAVONA PER FILIPPO NOBERASCO .i r * •# ! PREFAZIONE Della ricchezza degli Archivi savonesi testimo niano, oltre che i cronisti e storiografi locali, dal Verzellino, dal Monti, ai Belloro, al Garoni, ai Bruno, al Poggi, studiosi d’altri paesi, a quelli uniti dal profondo amore delle storie, primi Giorgio Viani, Domenico Promis, Gerolamo Rossi, se pur per vie più indirette e più direttamente il San Quintino (1), il de Oircourt, il Cipolla, troppo presto rapito alle alte benemerenze degli studi, il Filippi (2). (1) Cfr. spec. « Osservazioni critiche sopra alcuni particolari delle . storie del Piemonte e della Liguria nell’ XI e XII secolo », Torino, Tip. Reale, 1851. (2) Il Cipolla, da solo o collaborando col Filippi, illustrò pecu- , Ilarmente la raccolta diplomatica imperiale del Comune savonese ; il Filippi pubblicò la pregiatissima collana ; « Studi di Storia Ligure- Savona », Roma, S. E. D. Alighieri, 1897. 6 Il civico Archivio storico del Comune savonese, precipuo tra i cittadini, per la tristizia degli eventi, irreparabile quello della perduta libertà nel 1528, subì dispersioni fatali, che tolsero alla storica suppel lettile e completezza e continuità di registri, di filze, di atti, di cronache, originando incolmabili lacune (1). Quanto resta, però, è importantissimo, tale da porre il materiale storico del Comune savonese subito appresso alle raccolte genovesi. Accennerò appena alle redazioni dello Statuto cittadino del 1345(2), del 1376, del 1404-5, ai due preziosissimi « Registri > così detti < della catena » (3), ai Capitolari singoli delle varie Corporazioni artigiane cittadine (4), al grosso codice •in cui vennero descritti tutti in sugli ultimi del sec. -

Poesie Trobadoriche Relative a Federico II Di Svevia
Università degli Studi di Napoli Federico II Dottorato di ricerca in Filologia Coordinatore: Prof. Antonio Gargano Tesi di dottorato Ciclo XXIX Poesie trobadoriche relative a Federico II di Svevia Candidato: Dott. Francesco Saverio Annunziata Tutore: Prof.ssa Oriana Scarpati Cotutore: Prof. Paolo Di Luca Napoli 2017 1 INDICE Premessa p. 6 Introduzione I. Federico II e i trovatori, elogi e critiche cortesi p. 20 1.1 La crisi della cortesia in Italia p. 23 1.2 La rinascita dei valori cortesi, la Meggia p. 29 1.3 I conselhs all‘imperatore p. 33 1.4 Critiche giullaresche ed elogi de lonh p. 39 II. Federico II e la poesia politica dei trovatori p. 45 2.1 Federico e i Comuni, la lotta vista dai trovatori p. 46 2.2 Guilhem Figueira, un trovatore ghibellino? p. 48 2.3 Posizioni guelfe p. 57 2.4 Le voci del Midi p. 62 III. La crociata e Federico II p. 78 3.1 Il ciclo di crociata del 1213-1214 p. 80 3.2 Esortazioni alla crociata p. 97 3.3 Critiche al clero ed evoluzione dell‘idea di crociata p. 113 Testi Federico II in Germania, gli appelli alla Crociata (1213-1220) I. Pons de Capdoill, En honor del pairʼen cui es (BdT 375.8) p. 125 II. Pons de Capdoill, So quʼom plus vol e plus es voluntos p. 136 (BdT 375.22) III. Anonimo, Lo seigner que formet lo tro (BdT 323.22) p. 142 IV. Aimeric de Peguillan, Ara parra qual seran envejos (BdT p. 157 10.11) V. -

La De Razon No·M Cal Metre En Pantais (Bdt 352,2)
CRITICÓN, 87-88-89, 2003, pp. 719-728. la de razón no'm cal mètre en pantais (BdT 352,2) Carlo Pulsoni Université di Padova La questione attributiva Da quando nel suo Grundriss Bartsch assegnô il componimento BdT 352,2 a Peire de la Muía per ragioni di maggioranza1, nessuno studioso si è più posto il problema délia sua paternità. Cosï tra gli editori di Falquet de Romans, Zenker scartô l'attribuzione al suo trovatore perché trasmessa da un solo códice2; Arveillier e Gouiran, pur allestendo una sezione dedicata aile «Pièces d'attribution douteuse ou erronée», neanche prendono in considerazione questo testo3. All'opposto Bertoni, cui si deve la cura dello scarno corpus di Peire de la Muía, lo pubblica senza accennare al problema attributivo4. Cronología Falquet de Romans e Peire de la Mula sono vissuti alPincirca negli stessi anni, visto che hanno gravitato entrambi nella corte di Ottone del Carretto, signore non ai vertici délia rinomanza nel periodo nel quale è attestato (1190-1235?), ma che fu tuttavia podestà di Genova nel 1194 ed alleato dei Genovesi contro Ventimiglia nel 1219. 1 Bartsch, 1872. Quattro manoscritti ascrivono il testo a Peire de la Mula contro uno che lo assegna a Falquet de Romans. L'attribuzione di Bartsch, 1872 è riproposta da Pillet e Carstens, 1933 (da qui in avanti BdT). Sui criteri di registrazione délie bibliografie provenzali, si veda Asperti, 1992. 2 Zenker, 1896, p. 5. 3 Arveiller e Gouiran, 1987, pp. 183-220. Da questa edizione le citazioni dei testi di Falquet. 4 Bertoni, 1915, p. 249. 720 CARLOPULSONI Criticón, 87-88-89,2003 Mentre di Falquet de Romans abbiamo qualche notizia délia sua vita5, brancoliamo nel buio per Peire de la Mula6. -

Del CARRETTO (I) - Aleramici
Nikolai Wandruszka: Un viaggio nel passato europeo – gli antenati del Marchese Antonio Amorini Bolognini (1767-1845) e sua moglie, la Contessa Marianna Ranuzzi (1771-1848) 20.2.2013, 11.10. 2017 del CARRETTO (I) - Aleramici XIV.15719 del Carretto1 Caterina, * 1456 Finale, + 1513 Genoa; oo Genoa 1473 Gian Luigi II Fieschi Count of Lavagna, Lord of Pontremoli and Torriglia (+Genoa 1510) XV.31438 del Carretto Giovanni Lazzarino, * ca 1410 Finale, + 04.1468 Finale; oo 1451 Genoa Viscontina, figlia di Barnaba Adorno, Doge of Genoa (+Finale 1481) Marchese di Finale and Noli, etc.. XVI.62876 del Carretto Lazzarino (II), + 08.1412 Pietasanta, oo Caterina del Carretto (ved. del Carretto III). Marchese di Finale and Noli, etc XVII.125752 del Carretto Lazzarino (I), + 05.1393 Finale, oo Marietta del Carretto (ved. del Carreto II). Marchese di Finale and Noli, etc XVIII.351504 del Carretto Giorgio, * ca. 1280 Finale, + ca 1359 Finale; oo 1320 Leonora (or Venezia or Valentina) figlia di Federico Fieschi, Patrice of Genoa (*ca 1305 Genoa, + 1361 Finale). Leonora Fieschi wird nach anderen aber als Ehefrau seines Vaters Antonio geführt2. Marchese di Finale and Noli, etc. XIX.703008 del Carretto Antonio, * 1260 Finale (ex 2°), + 1313 Finale; oo Agnese, figlia di Pietro Valperga, Conte di Masino (oder Leonora di Federico Fieschi). Ampia biografia nel Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 36 (1988), pp.387-389 di Giovanni NUTI: „Figlio di Giacomo, marchese del Finale, e di Caterina di Marrano, figlia naturale di Federico II, nacque verso la metà del sec. XIII. Morto il padre, il 21 ott. 1268 Corrado, il figlio maggiore, Enrico e il D., questi ultimi ancora minorenni e affidati alla tutela di Nicoloso Doria, dividevano il feudo.