Romacultura Agosto 2016
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

For a History of the Use of the Antoninian Baths: Owners, Excavations and Dispossession
ArcHistoR anno VII (2020) n. 13 For a History of the Use of the Antoninian Baths: Owners, Excavations and Dispossession Isabella Salvagni For centuries, the monumental ruins of the Baths of Caracalla in Rome have attracted the attention of humanists, philologists and antique dealers, tickling their curiosity and arousing imaginative reconstructions. From the forefathers to the spokespersons of modern archaeology, it is this discipline that has mostly directed and guided the most recent studies on the complex, from the 1800s to today. However, while the ‘archaeological’ vocation constitutes the most evident and representative essence of these remains, for over a thousand years the whole area over which they lay was mainly used as agricultural land divided and passed on from hand to hand through countless owners. An attempt is made to provide a brief overview of this long and little-known history of use, covering the 300 years from the mid-16th century to the Unification of Italy. Starting from the identification of some of the many figures who have alternated over time as owners of the individual estates in different capacities, the story gives us a valuable amount of information also relating to what the owners themselves, as customers, have deliberated and conducted on the farms which they used, cultivating them, building and directing stripping, excavation, accommodation, reuse, and destruction operations, while providing us with useful data for the analysis of the transformative mechanisms of the land use of this portion of the city, to be related to the more general urban history of Rome. AHR VII (2020) n. -

7 Colonne E Marmi Colorati Delle Chiese Di Roma Nelle
INDICE INTRODUZIONE Pag. 1 STORIA DEGLI STUDI SUL REIMPIEGO » 7 COLONNE E MARMI COLORATI DELLE CHIESE DI ROMA NELLE OPERE DI FAUSTINO CORSI, FRANCESCO BELLI E L'lNTERESSE ERUDITO SULLA QUALITÄ E ORIGINE DEI MARMI NEGLI STUDI DEL XIX SECOLO . » 9 L'lNTERPRETAZIONE DEL FENOMENO DEL REIMPIEGO NEGLI STUDI DEL XX E DEL XXI SECOLO . » 10 IL QUADRO LEGISLATIVO E LA PRASSI »21 PREMESSA ............... 23 DALL'ETA TARDO REPUBBLICANA ALLA FINE DEL III SEC. D.C. ........ 24 Appendice I: leggi e disposizioni sulle demolizioni e sul riuso dei materiali . » 26 DALL'ETÄ COSTANTINIANA ALLA CADUTA DELL'IMPERO ROMANO D'OCCIDENTE . » 27 Premessa .............. 27 Ii periodo da Costantino a Valentiniano 1 . » 27 Ii periodo da Teodosio I a Maiorano .......... 28 Trasformazione in chiese di edifici con altre funzioni e le disposizioni suU'abbattimento dei templi 29 Conclusione .............. 33 PERIODO OSTROGOTO E BIZANTINO . » 34 Appendice II: legislazione sugli edifici pubblici, sul divieto dei sacrifici e sulla chiusura dei templi ............. 34 Appendice III: fonti sull'ediliza teodoriciana nelle Variae di Cassiodoro . » 40 PERIODO MEDIEVALE . » 41 REIMPIEGO E PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DALL'ETÄ TARDO REPUBBLICANA AL III SEC. D.C »43 Colosseo ............... 48 PORTICO IN SUMMA CAVEA . » 51 FUSTI ............... 53 CAPITELLI............... 56 1 - Capitelli corinzi ad acanthus mollis ......... 56 2 - Capitelli corinzi asiatici ad acanthus spinosus . » 58 3 - Capitelli corinzi a foglie lisce . » 59 4 - Capitelli corinzi sbozzati........... 60 5 - Capitelli figurati ........... y> 60 6 - Capitelli compositi ad acanthus mollis . » 61 7 - Capitelli compositi a foglie lisce ......... 62 8 - Capitelli ionici lisci ........... 64 Pensabene, Patrizio digitalisiert durch: Roma su Roma IDS Basel Bern VIII ROMA SU ROMA BASI 64 1 - Basi attiche semplici .......... -

2019 Gli Angeli
Angeli Le immagini angeliche sono quanto di più nobile, dolce, n1aestoso, possa trovarsi nella storia dell'arte occidentale. E le ali di cui gli angeli sono dotati hanno sempre suggerito agli artisti inunagini di radiosa bellezza, variegata di colori, dispiegata nello spazio della devozione. Così le imn1agini qui raccolte ci forniscono una precisa conoscenza sulle diverse modalità di rappresentazione del volo angelico nel corso dei secoli. Prima di tutti i puttini,figure a metà strada tra Sacro e Profano,rappresentati da due giganti della pittura europea, Polidoro da Caravaggio e Pietro Paolo Rubens. Vi si contrappone l'imn1agine della milizia angelica, sia in un mirabile mosaico medievale della Martorana di Palermo, sia nella bella figura dell'Arcangelo Michele di Guido Reni. Poi una ulteriore, magica, fi gurazione celeste è quella degli angeli volanti che planano su un sacro evento, portando doni e beneficidivini, e ne abbiamo tre supreme esemplificazioni: una nella fiera immagine dell' angelo di Gherardo delle Notti; le altre due nei gruppi angelici dipinti rispettivamente dal bolognese Marcantonio Franceschini, solenne pittore, e dal ro mano (ancorchè nativo delle Marche) Carlo Maratta, principe del classicismo barocco. Un ulteriore aspetto si trova nell' angelo quale figura familiare, intima, presente in una quotidianità che è nel con tempo metafisica,ri marcando anche quel misterioso essere androgino latente in tutta la tradizione rinascimentale. Ed ecco gli angeli pudichi e compunti di Jacopo di Cione (o più probabilmente della scuola di quel famoso pittore fiorentino) e di Neri di Bicci; l'angelo di Tiziano circonfuso di un mistico alone; l'angelo del Domenichino delicato e maestoso; l'Angelo Custode dello Spadarino, una autentica gemma, capolavoro del Seicento italiano, con quella figura che protegge il fanciullo salvandolo e guidandolo, quasi a voler garantire ad ognuno di noi la propria dignità e il diritto a vivere il proprio tempo felice. -
Quotidiano Online
Abriga.it Quotidiano online 2012 Gennaio 2012 Maria Santissima Madre di Dio Sant'Antonio abate 1 domenica - Solennità 17 martedì Santi Basilio Magno e Gregorio Santa Margherita d'Ungheria 2 lunedì Nazianzeno 18 mercoledì (principessa e religiosa) Santi Mario, Marta, Audiface e Santissimo Nome di Gesù 3 martedì 19 giovedì Abaco (martiri) Sant'Elisabetta Anna Bayley San Sebastiano e Fabiano 4 mercoledì Seton (vedova) 20 venerdì (martire)- Memoria facoltativa San Giovanni Nepomuceno Sant'Agnese (vergine e martire) 5 giovedì (vescovo) 21 sabato Santi Vincenzo (diacono e Epifania - Solennità 6 venerdì 22 domenica martire) e Anastasio (martire) Sant'Emerenziana (vergine e San Raimondo di Peñafort 7 sabato 23 lunedì martire) San Francesco di Sales domenica Battesimo di Gesù martedì (vescovo e dottore della Chiesa 8 24 del XVII secolo) 9 lunedì Battesimo di Gesù 25 mercoledì Conversione di Paolo Sant'Aldo (eremita dell'VIII Santi Timoteo e Tito 10 martedì secolo) 26 giovedì 11 mercoledì Sant'Igino (papa del II secolo) 27 venerdì Sant'Angela Merici San Tommaso d'Aquino giovedì San Bernardo da Corleone sabato (sacerdote e dottore della 12 28 Chiesa) Sant'Ilario di Poitiers (vescovo venerdì e dottore della Chiesa del IV domenica San Valerio 13 secolo) 29 San Felice da Nola (confessore Santa Martina 14 sabato e martire) 30 lunedì 15 domenica San Mauro 31 martedì San Giovanni Bosco Santi Berardo, Otone, Pietro, lunedì Accursio e Adiuto 16 (protomartiri) Febbraio 2012 Santi Sette Fondatori Santa Verdiana (vergine e dell'Ordine dei Servi dellaBeata -

19 Marzo 2017 Del Conflitto Che Da Anni In- Vici Di Roma Capitale, Per Of- Di Roma
On line su www.romasette.it facebook.com/romasette twitter.com/romasette solidarietà in città / 1 in città / 2 in città / 3 Sud Sudan, la Cei «L’Arte ti Accoglie»: Viaggiatori disabili, Da aprile le iscrizioni dona un milione massima accessibilità la nuova sala Blu aperte agli asili nido ROMA di euro dall’8xmille in tanti Musei Civici alla Stazione Termini Identificarsi al portale SETTE La Cei ha destinato un milione Percorsi tattili e visite multi- Una nuova sala Blu per dare Uscirà nei primi giorni di apri- di euro, dai fondi dell’8xmille, sensoriali. Partito il progetto assistenza ai viaggiatori con di- le l’avviso pubblico per le iscri- per dare assistenza alle vittime «L’Arte ti Accoglie» nei Musei Ci- sabilità alla stazione Termini zioni agli asili nido comunali. In Anno XLIV – Numero 11 Domenica 19 marzo 2017 del conflitto che da anni in- vici di Roma Capitale, per of- di Roma. I locali, al Binario 1, vista della pubblicazione, il Di- sanguina il Sud Sudan. La som- frire all’intero pubblico la pos- sono stati inaugurati giovedì: partimento Scuola informa che ma, attraverso Caritas italiana, sibilità di accedere agli spazi 100 metri quadrati in cui tre anche quest’anno le domande Supplemento di Avvenire - Responsabile: Angelo Zema Abbonamento annuo euro 62,00 sosterrà interventi di Medici museali abbattendo le barrie- operatori daranno informa- dovranno essere inoltrate e- Coordinamento redazionale: Giulia Rocchi C. Corr. Postale n. 6270 intestato a Avvenire - Nei Spa con l’Africa Cuamm, l’ospeda- re architettoniche e sensoriali zioni e aiuto a viaggiatori con sclusivamente online. -

La Santa Sede
La Santa Sede CONCISTORO ORDINARIO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI NUOVI CARDINALI OMELIA DEL SANTO PADRE Mercoledì, 21 febbraio 2001 1. "Chi vuol essere grande tra di voi si farà vostro servitore" (Mc 10, 43). Ancora una volta abbiamo sentito risonare ai nostri orecchi la sconcertante parola di Cristo. Oggi essa è echeggiata in questa Piazza particolarmente per voi, venerati e cari Fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio, che ho avuto la gioia di annoverare tra i membri del Collegio cardinalizio. Con profondo affetto vi porgo il mio saluto cordiale, che estendo alle molte persone che vi fanno corona. Una speciale parola di gratitudine va al caro Cardinale Giovanni Battista Re per le gentili espressioni che, interpretando con calore i sentimenti di voi tutti, mi ha indirizzato. Rivolgo poi un fraterno saluto a tutti gli altri Cardinali presenti, come pure agli Arcivescovi e Vescovi che sono qui con noi. Saluto, inoltre, le Delegazioni ufficiali, venute da vari Paesi per far festa ai loro Cardinali: attraverso di esse invio il mio deferente pensiero alle Autorità come pure alle care popolazioni che esse rappresentano. Oggi è festa grande per la Chiesa universale, che si arricchisce di quarantaquattro nuovi Cardinali. Ed è festa grande per la città di Roma, sede del Principe degli Apostoli e del suo Successore, non solo perché essa instaura uno speciale rapporto con ciascuno dei nuovi Porporati, ma anche perché il confluire qui di tante persone di ogni parte del mondo le offre la possibilità di rivivere un momento di gioiosa accoglienza. Questa solenne adunanza, infatti, richiama alla mente i tanti eventi che hanno contrassegnato il Grande Giubileo, concluso da poco più di un mese. -

Romanit〠a Roma
Bryn Mawr College Scholarship, Research, and Creative Work at Bryn Mawr College History of Art Faculty Research and Scholarship History of Art 2012 Romanità a Roma: Le Basiliche del XII Secolo Fra Tradizioni e Innovazioni Dale Kinney Bryn Mawr College, [email protected] Let us know how access to this document benefits ouy . Follow this and additional works at: http://repository.brynmawr.edu/hart_pubs Part of the Ancient, Medieval, Renaissance and Baroque Art and Architecture Commons Custom Citation Kinney, Dale. "Romanità a Roma: Le Basiliche del XII Secolo Fra Tradizioni e Innovazioni." In La Cattedrale Cosmatesca di Civita Castellana: Atti del Convegno Internazionale di Studi (Civita Castellana, 18-19 settembre 2010). ed. Luca Creti. Roma: L'Erma di Bretschneider, 2012. 53-76. This paper is posted at Scholarship, Research, and Creative Work at Bryn Mawr College. http://repository.brynmawr.edu/hart_pubs/64 For more information, please contact [email protected]. LA CATTEDRALE COSMATESCA DI CIVITA CASTELLANA ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI (Civita Castellana, 18-19 settembre 2010) a cura di Luca Creti «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER LA CATTEDRALE COSMATESCA DI CIVITA CASTELLANA Atti del Convegno Internazionale di Studi (Civita Castellana, 18-19 settembre 2010) a cura di LUCA CRETI Copyright 2012 © «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER Via Cassiodoro, 11 – 00193 Roma http://www.lerma.it Progetto grafico: «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione di testi e illustrazioni senza il permesso scritto dell’Editore ISBN 978-88-8265-761-1 Con l’Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Segreteria di Stato della Santa Sede e della Conferenza Episcopale Italiana REGIONE LAZIO PROVINCIA DI VITERBO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI SOPRINTENDENZA PER I BENI ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI UNIVERSITà “LA SAPIENZA” ROMA UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA VITERBO UNIVERSITÀ DI SIENA UNIVERSITà “G. -
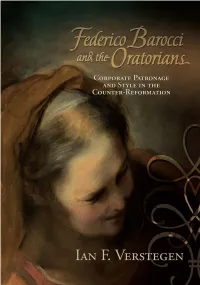
Federicobaroccilookinside.Pdf
Habent sua fata libelli Early Modern Studies Series General Editor Michael Wolfe St. John’s University Editorial Board of Early Modern Studies Elaine Beilin Framingham State College Christopher Celenza Johns Hopkins University Barbara B. Diefendorf Boston University Paula Findlen Stanford University Scott H. Hendrix Princeton Theological Seminary Jane Campbell Hutchison University of Wisconsin– Madison Mary B. McKinley University of Virginia Raymond A. Mentzer University of Iowa Robert V. Schnucker Truman State University, Emeritus Nicholas Terpstra University of Toronto Margo Todd University of Pennsylvania James Tracy University of Minnesota Merry Wiesner- Hanks University of Wisconsin– Milwaukee Verstegen-Barocci.indb 2 5/21/15 3:57 PM Early Modern Studies 14 Truman State University Press Kirksville, Missouri Verstegen-Barocci.indb 3 5/21/15 3:57 PM Copyright © 2015 Truman State University Press, Kirksville, Missouri, 63501 All rights reserved tsup.truman.edu Cover art: Federico Barocci, Head of an Old Woman Looking to Lower Right, 1584–86, brush and oil paint on paper (Harry G. Sperling Fund, 1976, Metropolitan Museum of Art, New York) Cover design: Teresa Wheeler Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Verstegen, Ian. Federico Barocci and the Oratorians : corporate patronage and style in the Counter-Reformation / Ian F. Verstegen. pages cm. — (Early modern studies ; 14) Includes bibliographical references and index. ISBN 978-1-61248-132-6 (library binding : alk. paper) — ISBN 978-1-61248-133-3 (e-book) 1. Barocci, Fed- erigo, 1528–1612—Criticism and interpretation. 2. Oratorians—Art patronage. 3. Santa Maria in Vallicella (Church : Rome, Italy) 4. Christian art and symbolism—Italy—Rome—Modern period, 1500– 5. -

Santi Nereo E Achilleo Alle Terme Di Caracalla
(010) Santi Nereo e Achilleo alle Terme di Caracalla Santi Nereo e Achilleo is a 4th century basilica church in Rome. The church is located in the rione Celio, close to the Baths of Caracalla. The current titular priest of the church is H.E. Theodore Edward Cardinal McCarrick, Archbishop of Washington. History: The church was one of the tituli, the first parish churches of Rome, known as the Titulus Fasciolae, the Title of the Bandage. The name refers to the legend of Peter's flight from Rome to escape martyrdom; a bandage is said to have fallen from his leg at this site. It is uncertain when the church was built, but an inscription in the museum of San Paolo fuori le mura dated 377 says that the a deceased man named Cinnamius had been a lector in the Titulus de fasciolae. The synod list from 499 also mentions this name, and lists it as being served by five priests. This same building is recorded as titulus Sanctorum Nerei et Achillei in 595; therefore the dedications to Sts. Nereus and Achilleus, two soldiers and martyrs of the 4th century, must have happened during the 6th century. It was rebuilt under Pope Leo III in 814, when the relics of the two martyrs were brought here from the Catacomb of Domitilla. At that time, relics were moved from the catacombs to protect them from Saracen raiders, and since the church had already been dedicated to the two saints for more than 200 years it was only natural to translate their relics here. -

The Spolia Churches of Rome
fabricius maria hansen ISBNisbn 978-87-7124-210-2 978-87-7124-210-2 A tour around the Rome of old maria fabricius hansen The church-builders of the Middle 1 The Lateran Baptistery Piazza di San Giovanni in Laterano Ages treated the architecture of 2 Sant’Agnese fuori le Mura Via Nomentana 349 ancient Rome like a quarry full of pre- 3 San Clemente Piazza di San Clemente fabricated building materials. This 4 Santa Costanza Via Nomentana 349 THE 9 788771 242102 resulted in some very eclectically 5 San Giorgio in Velabro Via del Velabro 3 and ingeniously constructed churches. THE SPOLIA 6 San Lorenzo fuori le Mura Piazzale del Verano 3 Søndergaard In The Spolia Churches of Rome we SPOLIA 7 Santa Maria in Cosmedin Piazza Bocca della Verità Trine learn of the principles for the distri- 8 Santa Maria in Trastevere Piazza di Santa Maria in Trastevere Photo: bution of these antique architectural elements and the significance of CHURCHES 9 San Nicola in Carcere Via del Teatro di Marcello 35 About the author breaking down and building on the past. 10 Santa Sabina Piazza Pietro d’Illiria Maria Fabricius Hansen is Also presented here is a selection of 11 Santo Stefano Rotondo Via di Santo Stefano Rotondo 6 eleven particularly beautiful churches an art historian and associate CHURCHES featuring a wide variety of spolia. OF ROME professor at the University of 1 Sant’ Adriano Foro Romano This book contains maps and other Copenhagen. She has written 2 San Bartolomeo all’Isola Piazza di San Bartolomeo all’Isola practical information which make it books and articles on the 3 San Benedetto in Piscinula Piazza in Piscinula the ideal companion when seeking out legacy and presence of antiquity 4 Santa Bibiana Via Giolitti 150 the past in modern-day Rome. -

Rome, the Eternal City
Chapter 9 – Rome, the Eternal City Flying into Rome, Italy aboard Alitalia. We were greeted at the airport by our tour director, Georgio: http://wigowsky.com/travels/GreeceRome/audios/rome1.wma (audio file) “Bongiorno (good morning), I’m Georgio (rolling his r’s). I’m going to be with you all the way to Venice, for those going that far. Some of you, two or three of you, are leaving early (after Rome). I’m not a tour guide, just a tour director, the kind that takes care of your itinerary. Anyway, welcome to Rome, Italy. Tomorrow, we’ll be visiting Ostia Antigua, the ancient Roman city. It used to be the ancient port and harbor. We’ll be driving for about 28 kilometers (17.8 miles) to the city. It will take us about 45 minutes, traffic permitting. Our driver’s name is Mauro. The agenda for today is easy. We are first going to the catacombs – Santa Domitilla. Once there we’ll be meeting four more fellows of our group. We’ll have a guided tour there. Afterwards, we’ll drive to the hotel Universo and check in. Tomorrow we’ll be very busy, and we’ll be leaving the hotel by 8:15am. We’ll be meeting our local guide, and then we’ll go to the Mamertine prison, and the Colosseum. That will be in the morning. In the afternoon, we’ll make our way to Ostia Antigua with the same guide. Any questions? Question: “What will the weather be like tomorrow?” Answer: “What is it you’re worrying about tomorrow? Think about today. -

Categorie Di Santi Citati Nell'invito Ai Santi Da Don Giustino Russolillo
Categorie di Santi citati nell’Invito ai Santi da Don Giustino Russolillo (dal Devozionale, I e II volume, Edizione del 1949) Santi Angeli e Arcangeli (I Devozionale, 90) San Michele, San Gabriele, San Raffaele, Santi Principi dei Cori celesti, Santi Spiriti Assistenti al Trono di Dio, Santi Angeli nostri, Santi Angeli, Santi Arcangeli, Santi Principati, Sante Potestà, Sante Virtù, Sante Dominazioni, Santi Troni, Santi Cherubini, Santi Serafini Santi Favoriti dagli Angeli (II Devozionale, 1387) San Cornelio, San Concordio, san Pacomio, San Felice, San Mercurio, San Ponziano, Santo Stefano, San Valeriano, San Tiburzio, San Basileo, Sant’Antino, Santo Stanislao Santi Patriarchi, Leviti, Giudici e Re dell’Antico Testamento (II Devozionale, 1662) Adamo, Eva, Abele, Abramo, Mosè, Aronne, Eleazaro, Finees, Giosuè, Gedeone, Samuele, Davide Santi Leviti (I Devozionale, 502) San Leone, San Rustico, San Desiderio, San Gioviniano, San Sinesio, San Settimio, San Tarcisio, San Modesto, Sant’Ermete, San Baldomero, San Quadragesimo, Santo Eutropio Santi più vicini nel tempo all’Incarnazione del Verbo (II Devozionale, 1522) Sant’Anna, San Gioacchino, Santa Elisabetta, San Zaccaria, San Simeone, Sant’Anna, Santa Marta, Santa Maria Maddalena, Santa Maria di Cleofa, Santa Salome, Santa Maria di Giacomo, San Giovanni di Cusa Santi Apostoli ed Evangelisti (I Devozionale, 640) San Pietro, San Paolo, Sant’Andrea, San Giacomo, San Giovanni, San Tommaso, San Giacomo, San Filippo, San Bartolomeo, San Matteo, San Simone, San Taddeo, San Mattia, San Barnaba, San