27 Gennaio 2013
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
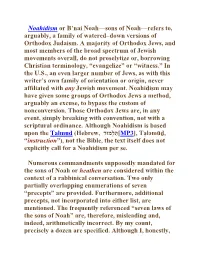
Noahidism Or B'nai Noah—Sons of Noah—Refers To, Arguably, a Family
Noahidism or B’nai Noah—sons of Noah—refers to, arguably, a family of watered–down versions of Orthodox Judaism. A majority of Orthodox Jews, and most members of the broad spectrum of Jewish movements overall, do not proselytize or, borrowing Christian terminology, “evangelize” or “witness.” In the U.S., an even larger number of Jews, as with this writer’s own family of orientation or origin, never affiliated with any Jewish movement. Noahidism may have given some groups of Orthodox Jews a method, arguably an excuse, to bypass the custom of nonconversion. Those Orthodox Jews are, in any event, simply breaking with convention, not with a scriptural ordinance. Although Noahidism is based ,MP3], Tạləmūḏ]תַּלְמּוד ,upon the Talmud (Hebrew “instruction”), not the Bible, the text itself does not explicitly call for a Noahidism per se. Numerous commandments supposedly mandated for the sons of Noah or heathen are considered within the context of a rabbinical conversation. Two only partially overlapping enumerations of seven “precepts” are provided. Furthermore, additional precepts, not incorporated into either list, are mentioned. The frequently referenced “seven laws of the sons of Noah” are, therefore, misleading and, indeed, arithmetically incorrect. By my count, precisely a dozen are specified. Although I, honestly, fail to understand why individuals would self–identify with a faith which labels them as “heathen,” that is their business, not mine. The translations will follow a series of quotations pertinent to this monotheistic and ,MP3], tạləmūḏiy]תַּלְמּודִ י ,talmudic (Hebrew “instructive”) new religious movement (NRM). Indeed, the first passage quoted below was excerpted from the translated source text for Noahidism: Our Rabbis taught: [Any man that curseth his God, shall bear his sin. -

Odoardo Focherini
6 marzo 2019- Odoardo Focherini Odoardo Focherini è stato un dirigente d'azienda e intellettuale cattolico italiano, medaglia d'oro al merito civile della Repubblica Italiana e iscritto all'Albo dei Giusti tra le Nazioni a Yad Vashem per la sua opera a favore degli ebrei durante l'Olocausto, per la quale fu arrestato e morì nel campo di concentramento di Hersbruck in Germania. Il 10 maggio 2012 papa Benedetto XVI ha firmato il decreto che ne riconosce il martirio in odium fidei. Tale riconoscimento ha aperto la strada alla beatificazione di Focherini celebrata a Carpi il 15 giugno 2013. Odoardo Focherini aveva 37 anni quando scrisse l’ennesima lettera d’amore alla sua Maria, con la quale aveva già avuto sette bambini ed erano in attesa di un ottavo. Sandro o Sandra si sarebbe dovuto chiamare quel desideratissimo figlio se Odoardo fosse uscito vivo dalla prigione. Quella lettera fu scritta, infatti, durante la sua detenzione per aver salvato oltre cento ebrei dalla deportazione. L'11 marzo 1944 egli organizzò la fuga dal campo di concentramento di Fossoli del medico ebreo Enrico Donati con la scusa di una operazione chirurgica urgente. Giunto in ospedale, però, venne arrestato. Fu inizialmente detenuto nel carcere di San Giovanni in Monte a Bologna dal 13 marzo fino al 5 luglio e venne trasferito successivamente al campo di concentramento di Fossoli. Il 4 agosto fu trasportato al campo di Gries; da qui venne deportato nel campo di concentramento di Flossenbürg e poi nel sottocampo di Hersbruck, dove trovò la morte il 27 dicembre 1944. In questi momenti ebbe il conforto dell'amico Teresio Olivelli, il quale morirà anche lui il mese successivo per le percosse ricevute da una guardia. -

Éclaireur De Rencontre, Bâtisseur De Paix
Publiez vos annonces légales et judiciaires dans toute la France Pétanque Gommer une mauvaise image ■ Les responsables départementaux de pétanque veulent changer certaines mauvaises image d’une activité sportive qui veut attirer des jeunes joueurs. Lire en page 6 74e ANNÉE 1,50 € Teleport 1 - BAT. Arobase 2 - AV. du Futuroscope - 86360 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL - RÉDACTION : Tél. 05.49.55.07.42 - Courriel : [email protected] DIFFUSION - PUBLICITÉ : TÉL. 05 24 07 39 63 - ANNONCES LÉGALES : TÉL. 05 56 44 72 24, FAX 05 56 44 23 70 22 DÉCEMBRE 2017 N° 3823 Élections sénatoriales Yves Bouloux sénateur Au terme de quelques mois de campagne discrète auprès des élus locaux, Yves Bouloux, maire de Montmorillon, a été élu sénateur en remplacement de Jean-Pierre JoyeuxJoyeux NoëlNoël Raffarin, démissionnaire. Lire en page 5 Atelier des Quatre-Roues Une caverne d’Ali baba La période est aux cadeaux. L’atelier des Quatre-Roues à Poitiers offre toujours, et cette année encore, un choix original d’objets d’artisanat d’art. Un moyen de se démarquer des produits standards. Lire en page 4 Autoroute A10 La sécurité avance Avec le plan de relance autoroutier, le concessionnaire Cofiroute a entrepris le remplacement des glissières centrales entre Tours et Poitiers. On devrait y gagner en sécurité. Lire en page 2 L’adoration des bergers, Jean-Honoré Fragonard (1732-1806), Palais des Beaux-Arts de Lille Lumière de la paix de Bethléem Coup de projecteur Éclaireur de rencontre, Zootopie bâtisseur de paix La lumière de la paix est passée par Niort, dimanche 17 décembre dernier. Un invitation à la conversion avant Noël. -

Federation News March-April 2021 1
Federation News_March-April_2021 1 Federation News NEWS FROM CANADA: Sister Gabriella celebrates her 98th birthday with her favourite dessert—ice-cream cake. It was delicious! NEWS FROM CALIFORNIA Proposal to rename a University library in honor of Sr. Sara Salkahazi along with Mr. Odoardo Focherini Recently, Sr. Maribeth, our General Director was informed of the proposal to rename the main library at the St. Louis University in St. Louis, Missouri. A committee was formed, led by alumni Timothy Bagwell, Ph.D. to open a process to rename this library for Sr. Sara Salkahazi along with Mr. Odoardo Focherini, both martyrs. An article in the St. Louis Post-Dispatch editorial section in part states that Sisters of Social Service Sister Sara Salkahazi was executed for hiding over 100 Jews in Hungary. The article also included information on Mr. Odoardo Focherini, who was an Italian Roman Catholic journalist. He gave false documents to Jews so they could escape the Nazi regime. He was sent to a concentration camp in Heisbruck where he died for an untreated leg infection. Both died on December 27, 1944 and both suffering death and subsequent martyrdom. Sr. Sara was beatified on September 17, 2006 and Mr.Focherini was beatified on June 15, 2013. It is interesting to note that both had experience as journalist. These two individuals are among those recognized in The Righteous among the Nations in Israel for risking their lives to save Jews during Federation News_March-April_2021 2 World War II. The work of the aforementioned committee of alumni is continuing in order to honor and memorialize these two martyrs. -

Odoardo Focherini
Archivio della Memoria di Odoardo Focherini 1904 – 2018 Elenco di consistenza analitico a cura dell’Archivio Storico Comunale di Carpi (rev. Zanasi Eleonora) 2021 Tipologia Denominazione Estremi cronologici Unità archivio Archivio della Memoria di Odoardo Focherini 1904 - 2018 0 sezione — Odoardo Focherini 1904 - 1996 0 partizione —— Documentazione raccolta da Maria 1944 - 1979 35 Marchesi, 1944-1979 partizione —— Lettere di Odoardo Focherini 1944 marzo 13 - 1947 maggio 15 4 partizione —— "[Documenti personali di] Odoardo 1913 luglio 2 - 1944 14 Focherini", 1913-1937 partizione —— Documenti famigliari, 1930-1946 1921 - 1955 11 partizione —— Articoli di Odoardo Focherini 1926-1944 1926 - 1944 1 partizione —— Raccolta di giornali 1924-1929 1924 - 1929 1 partizione —— Materiali a stampa 1945-anni '80 1944 giugno 20 - 1984 marzo 2 2 partizione —— Lettere condoglianze OF 1945 1945 maggio 6 - 1948 settembre 23 4 partizione —— Documentazione fotografica 1910-1940 circa 1904 - 1956 4 partizione —— Documentazione miscellanea, 1930-1996 1930 - 1996 7 partizione —— Quaderno di Attilio 1944 - 1946 3 partizione —— Lettere di Maria Marchesi 1944 maggio 9 - 1945 maggio 29 1 sezione — Olga Focherini 1914 - 2018 0 partizione —— Beatificazione di Odoardo Focherini 1944 - 2018 8 partizione —— Elaborati scolastici e materiali didattici 1973 - 2013 6 partizione —— Materiali di promozione 1929 - 2014 3 partizione —— Pubblicazioni, mostre e testi bibliografici 1945 - 2003 40 partizione —— Materiali di ricerca 1914 - 2008 33 partizione —— Corrispondenza e carteggio -

Newsletter 11720
January 17, 2020 ST. JOSEPH NEWS St. Joseph Catholic School assists parents in developing good stewards who are both spiritually and academically prepared to live their lives in honor of God. UPCOMING EVENTS Mr. Arnold’s Message VIRTUE OF THE QUARTER: SAT. 1st Reconciliation for Thank you to all that came to this week's PTO Meeting, and FORTITUDE JAN 18 2nd Grade thank you to our School Council members that met to chart Fortitude is courage in doing the the course for our Strategic Plan. Please pray for our 2nd good, even when you don't want to. MON. NO School- graders as they receive the sacrament of Reconciliation for To break apart the word, it really is JAN. 20 Teacher Retreat the first time tomorrow! And please keep our staff in your a fort-attitude, being on defense prayers as we have our annual retreat on Monday. We will be against the devil and making a SAT. Winter Carnival taking a pilgrimage to the Cathedral and reflecting on the positive difference in the world. JAN. 25 virtues and spiritual gifts God has blest us with. Firefighters don't want to run into a burning building, but they have JAN. 27- Catholic School Week fortitude! Students might not want JAN. 31 (Info on back) SCHOOL MALL to do their homework, but with the On Tuesday, your child will bring home a packet for our help of this virtue they can offer it THUR. Body Venture at up and triumph! Our connected annual School Mall fundraiser. Each child is asked to fill out FEB. -

Standing up for Our Schools
Members of Scotland’s NEWWN DA G8 LEADERS respond to anti-hunger youth ministry bring their message campaigners in Belfast and to young Catholics in Scotland answer Pope Francis’ call for ahead of national event. Page 5 peace in Syria. Pages 7, 8 No 5523 YOUR NATIONAL CATHOLICwww.sconews.co.uk NEWSPAPER SUPPORTS THE YEAR OF FAITH Friday June 21 2013 | £1 CAMINO DE SANTIAGO FLYING THE FLAG FOR ARCHBISHOP MÜLLER IN MOTHERWELL Before he delivered the annual Cardinal Winning Lecture last Saturday, Archbishop Gerhard Müller, along with Archbishop Philip Tartaglia, Bishop Emeritus Joseph Devine, Mgr Patrick Burke and Mgr Slawomir Sledziewski, paid a visit to Our Lady of Good Aid Cathedral Primary School, Motherwell on Friday June 14, where they were able to see an excellent example of Catholic education at first hand. They were greeted at the entrance by headteacher JOE McGRATH Maria Shields, pupils from the school and various dignitaries tells of the trials and before enjoying a special tribulations he faced service and tour of the building. For more on the archbishop’s on the pilgrimage trail visit, turn to page 3 PIC: GERARD GOUGH Pages 12-13 Standing up for our schools IArchbishop Gerhard Müller delivers defence of Catholic education at Cardinal Winning Lecture By Ian Dunn to educate their children according to sages of hope for the future.” St Andrew’s Foundation, said the Cardi- their desire to pass on their Faith to After his lecture, reverent, a lively nal Winning Lecture had been a ‘tremen- ONE of Pope Francis’ most senior their children.” debate by a panel of academics including dous success’ and Archbishop Müller’s advisers has told Scotland that The archbishop stressed that teach- Papal advisor Professor John Haldane words and visit were ‘a tour de force.’ Catholic education remains ‘vitally ers had a very special role to play in of St Andrew’s University was held. -

Palm Sunday of the Passion of the Lord S���� T������ P����� A���������� �� G��������—H����
S. T C C A 9, 2017 PALM SUNDAY OF THE PASSION OF THE LORD S T P A G—H S T C C 705 S T B S L, T 77498 281-494-1156 .SLC. S. T C C A 9, 2017 CONTENTS B Pope Francis…………….…..……………………...… 3 Ministerios en Español…………….……......……...….. 4 D Papa Francisco…………………………….……….… 5 St. Theresa Catholic School………………..……….... 6 Adult Confirmation…………………………………... 7 Faith Formation………...…………………..………….. 8 Mass Intentions……………………………….……….. 9 Weekly Schedule of Events…………………………… 9 2017 Bazaar…………….……………………….…….. 10 Proyector de los Ministerios (CCE Primaria)…. 11 Daily Scripture Readings……………………………… 12 Education Grant Opportunity…………………..…... 13 Parish contact information………………...................... 15 TODAY, www.SugarLandCatholic.com April 9, 2017 On the cover: in the Knights of Orrente, Pedro. Entry of Christ into Jerusalem. Columbus Hall. 1620, oil on canvas, Hermitage Museum, St. Petersburg. M C S W E S C S S Monday—Friday Saturday Sábado 8:30 a.m. 6:45 a.m., 8:30 a.m. 3:15 p.m. – 4:15 p.m. 5:00 p.m. Anticipatory Sunday Mass During Lent: Tuesday 5:30 p.m. Sunday Domingo S D 4:00 p.m. – 4:45 p.m. 7:00 a.m.*, 8:00 a.m. (Español), Miércoles (Español) 10:00 a.m., Noon, 7:00 p.m. 2:00 p.m. (Español), Weekdays Entre Semana 5:00 p.m. Monday-Friday: after each Mass Tuesday-Thursday at 6:00 p.m. *The 7:00 a.m. Mass will move to 6:30 (Miércoles 6:00 p.m. en Español)* a.m. beginning Easter Sunday this year (April 16, 2017) 2 S. -

Odoardo Focherini, Giusto Tra Le Nazioni
Odoardo Focherini, Giusto tra le nazioni La vita: giugno 1907 – negli ultimi giorni del dicembre 1944. Il 17 aprile 1955 la comunità israelitica dicembre 1944 conferì alla sua memoria la medaglia d’oro Odoardo Focherini nacque a Carpi il 6 e il 5 agosto 1969 l’Istituto commemorativo giugno 1907 da Tobia e Maria Bertacchini ed dei Martiri e degli Eroi, ovvero la in gioventù frequentò l’oratorio di Don commissione Yad Vashem di Armando Benati e di Don Zeno Saltini, con i Gerusalemme, gli conferì la medaglia dei quali dapprima collaborò all’Opera Realina Giusti tra le nazioni. Nel marzo 1995, in (fondata a Carpi nel 1923), poi lavorò occasione del pellegrinaggio diocesano in all’interno dell’Azione cattolica. Dal 1927 si Terra Santa, alcuni figli e nipoti di Odoardo occupò degli scout, di cui diventò presto scoprirono nella Valle della Gloria, alla delegato diocesano e, contemporaneamente, presenza delle autorità ebraiche e del iniziò il servizio di cronaca locale per il console d’Italia a Gerusalemme, una giornale L’Avvenire d’Italia, ritornato piccola lapide che ricorda Focherini come proprio in quell’anno nell’alveo ufficiale Giusto. della Chiesa. Sposatosi nel 1930 con Maria Marchesi, Nella contraddizione, la carità da cui avrà sette figli, continuò a svolgere un’intensa e multiforme attività nell’Azione e la speranza cattolica diocesana che lo elesse dapprima Nel 1935 si iscrisse al Partito Nazionale presidente degli Uomini cattolici (1934), poi Fascista (PNF), ma dichiarò apertamente di presidente generale nel 1936. Nello stesso averlo fatto Per Necessità Familiare: aveva anno, lasciato il lavoro nella bottega paterna, dovuto prendere la tessera del partito per venne assunto presso la società di poter essere in grado di lavorare, assicurazioni La Cattolica di Verona e adeguandosi in qualche maniera alle ricevette il conferimento del cavalierato di contingenze del momento storico. -

Libretto Spiegazione Album Mostra
PRESENTAZIONE “ALBUM FOCHERINI” Materiale didattico a disposizione della scuola Da tempo nella scuola si avvertiva la necessità di corredare la conoscenza della figura di Focherini di un dignitoso apparato illustrativo di supporto che come si sa, è parte fondamentale della didattica ed è estremamente importante per il coinvolgimento dei ragazzi. L’Album è stato pensato proprio per rispondere a questa esigenza, in vista di una spiegazione maggiormente esaustiva, diretta ed efficace del personaggio agli studenti. Si trattava di ridare ad Odoardo un volto concreto, una personalità precisa, un comportamento, una storia intessuta di incontri, azioni, emozioni, sentimenti, nonché calare il tutto in una realtà storica precisa per consentire ai ragazzi il confronto con la figura di un grande carpigiano e favorire l’immedesimazione con le sue scelte di vita. A detto scopo, l’opera si presenta come una specie di banca-dati su Odoardo Focherini nel contesto del suo tempo e del suo operato con Don Dante Sala a favore degli ebrei. Un impianto corredato da immagini, citazioni dalle lettere, testi di testimonianza, foto originali d’archivio della famiglia e storiche di Carpi. Schede illustrative a disposizione di una scuola dove studenti ed insegnanti ciclicamente ne affrontano lo studio. Pannelli comodi da maneggiare, destinati a rimanere all’interno della scuola in modo permanente, comodamente a disposizione di ragazzi ed insegnanti negli anni a venire. Si tratta di n.60 schede didattiche (n.30 pannelli fronte e retro/ dimensione 35x50) da mostrare in classe durante le lezioni. Risulta comoda la disponibilità delle immagini mentre si fa riflettere i ragaz- zi. E questa metodologia, a differenza di una video-proiezione, oltre alla comodità d’uso, permette di non perdere il contatto visivo con gli alunni. -

Maggio-Giugno 2014 - N
maggio-giugno 2014 - n. 5 Vita Giuseppina MENSILE DEI GIUSEPPINI DEL M URIALDO AnnoAnno CXX CXX- N. -5 N. Maggio-Giugno5 Maggio-Giugno 2014 2014 - POSTE - POSTE ITALIANE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE S.P.A. - SPEDIZIONE D.L.INA.P. D.L.IN353/03A.P. 353/03 (CONV. IN (CONV. L.IN 27/02/2004 L. 27/02/2004 N. 46) 1N. ART. 46)COMMA 1ART. COMMA 1, ROMA 1, ROMA 1 In copertina maggio-giugno 2014 - n. 5 3 L’ORIZZONTE Vita Giuseppina Passione per il carisma “San Leonardo Murialdo divenne amico, fratello, padre MENSILE DEI GIUSEPPINI DEL MURIALDO L ’ORIZZONTE di p. Mario Aldegani dei giovani poveri, sapendo che in ognuno di essi c’è 4 CARA VITA GIUSEPPINA un segreto da decifrare: la bellezza del Creatore riflessa nelle loro anime”. Giovanni Paolo II (28 marzo 2000). 5 GRANDANGOLO La semplicità è straordinaria “São Leonardo Murialdo tornou-se um amigo, irmão, pai AnnoAnno CXX CXX- N. -5 N. Maggio-Giugno5 Maggio-Giugno 2014 2014 - POSTE - POSTE ITALIANE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE S.P.A. - SPEDIZIONE IND.L.A.P. IND.L.353/03A.P. 353/03 (CONV. IN (CONV. L.IN 27/02/2004 L. 27/02/2004 N. 46) N.1 ART. 46) COMMA1ART. COMMA 1, ROMA 1, ROMA di Giuseppe Novero dos jovens pobres, sabendo que em cada um deles há um 6 PERIFERIE AL CENTRO segredo para decifrar: a beleza da criação refletida em suas 1 Vale la pena sorridere almas”. João Paulo II (28 de março de 2000). di Luna D’Ambrosi “San Leonardo Murialdo se convirtió en un amigo, hermano, padre de los 8 Dalle periferie del disagio.. -
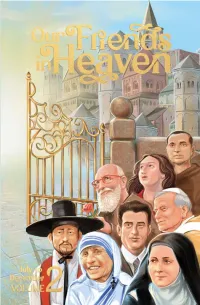
Read a Sample
Our iņ ev Saints for Every Day Volume 1 January to June Written by the Daughters of St. Paul Edited by Sister Allison Gliot Illustrated by Tim Foley Boston 5521–9_interior_OFH_vol1.indd 3 12/22/20 4:45 PM Library of Congress Control Number: 2020943471 CIP data is available. ISBN 10: 0– 8198– 5521– 9 ISBN 13: 978– 0- 8198– 5521– 3 The Scripture quotations contained herein are from the New Re- vised Standard Version Bible: Catholic Edition, copyright © 1989, 1993, Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in the United States of America. Used by permission. All rights reserved. Cover and interior design by Mary Joseph Peterson, FSP Cover art and illustrations by Tim Foley All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechan- ical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher. “P” and PAULINE are registered trademarks of the Daughters of St. Paul. Copyright © 2021, Daughters of St. Paul Published by Pauline Books & Media, 50 Saint Pauls Avenue, Boston, MA 02130– 3491 Printed in the USA OFIH1 VSAUSAPEOILL11-1210169 5521-9 www.pauline.org Pauline Books & Media is the publishing house of the Daughters of St. Paul, an international congregation of women religious serving the Church with the communications media. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 25 24 23 22 21 5521–9_interior_OFH_vol1.indd 4 12/14/20 4:12 PM We would like to dedicate this book to our dear Sister Susan Helen Wallace, FSP (1940– 2013), author of the first edition of Saints for Young Readers for Every Day.