Il Fiume OGLIO Grande Giardino Dei Camuni
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
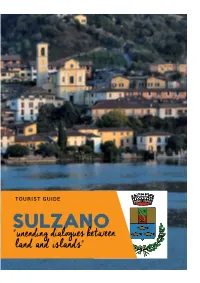
SULZANO " Unending Dialogues Between Land and Islands" SULZANO GUIDE 3
TOURIST GUIDE SULZANO " unending dialogues between land and islands" SULZANO GUIDE 3 SULZANO BACKGROUND HISTORY much quicker and soon small Sulzano derives its name from workshops were turned into actual Sulcius or Saltius. It is located in an factories providing a great deal of area where there was once an ancient employment. Roman settlement and was born as a lake port for the area of Martignago. Along with the economic growth came wealth and during the Twentieth Once, the fishermen’s houses were century the town also became a dotted along the shore and around tourist centre with new hotels and the dock from where the boats would beach resorts. Many were the noble leave to bring the agricultural goods to and middle-class families, from the market at Iseo and the materials Brescia and also from other areas, from the stone quarry of Montecolo, who chose Sulzano as a much-loved used for the production of cement, holiday destination and readily built would transit through here directed elegant lake-front villas. towards the Camonica Valley. At the beginning of the XVI century, the parish was moved to Sulzano and thus the lake town became more important and bigger than the hillside Sulzano is a village that overlooks the one. During the XVII Century, many Brescia side of the Iseo Lake mills were built to make the most of COMUNE DI the driving force of the water that SULZANO flowed abundantly along the valley to the south of the parish. Via Cesare Battisti 91- Sulzano (Bs) Tel. 030/985141 - Fax. -

Prontuario Per La Pesca Dilettantistica Ricreativa Nel Bacino N. 14 Sebino
PRONTUARIO PER LA PESCA DILETTANTISTICA RICREATIVA NEL BACINO N. 14 SEBINO ANNO 2021 Per informazioni: Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Bergamo Via XX Settembre, 18/A - 24122 Bergamo [email protected] [email protected] 035/273.373 - 371 Orari di apertura al pubblico sportello Caccia e Pesca: • dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 • mercoledì anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Brescia Via Dalmazia, 94 – 25125 Brescia [email protected] [email protected] 030/3462345 – 318 -366 Orari di apertura al pubblico sportello Caccia e Pesca: • da lunedì a giovedì: 9.00-12.30 / 14.30-16.30 • venerdì: dalle 9,00 alle 12,30 INDICE IL BACINO DI PESCA Confini e acque del bacino pag. 3 Classificazione delle acque pag. 3 COSA SERVE PER PESCARE NEL BACINO 14 La licenza di pesca pag. 4 Il tesserino segnapesci pag. 4 NORME PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA DILETTANTISTICA RICREATIVA Tempi di pesca pag. 5 Orari di pesca pag. 5 Pesca notturna pag. 5 Periodi di divieto di pesca e misure minime di cattura pag. 5 Fauna ittica protetta pag. 9 Limiti di cattura giornalieri per pescatore pag. 9 Pesca da natante pag. 10 Posto di pesca pag. 10 Attrezzi consentiti pag. 10 Esche e pasture, pesca con il pesce vivo pag. 13 Divieti pag. 13 ZONE A REGOLAMENTAZIONE SPECIALE Zone di protezione e ripopolamento pag. 15 Lago di Iseo - Zone di Tutela con divieto assoluto di pesca professionale e limitazione alla pesca dilettantistica pag. -

L'antica Via Valeriana Tratto 1: Pilzone – Marone Km: 12 Tempo Di Percorrenza
L’antica Via Valeriana L’antica via Valeriana offre i suoi spettacolari paesaggi a coloro che amano immergersi nella natura. Un percorso sospeso tra l’acqua del lago e le cime calcaree delle Prealpi. Oltre le bellezze naturalistiche si possono ammirare numerosi elementi di interesse storico-artistico. L’antica Valeriana del Lago D’Iseo Tratto 1: Pilzone – Marone Km: 12 Tempo di percorrenza: 8 ore Dislivello: + 500 / - 375 m Periodo: da Maggio a Ottobre Difficoltà: Turistica (facile) Salendo da Pilzone d’Iseo e inoltrandosi tra esemplari di castagni e nocciolo, si possono ammirare scorci caratteristici del Lago d’Iseo tra cui l’isola più grande d’Europa, Montisola. Proseguendo si arriva presso l’abitato di Tassano a Monte del paese di Pilzone, dove si possono ammirare il panorama sul lago e la piccola chiesetta di San. Fermo protettore dei contadini. La struttura in tempi medioevali era adibita a ospizio per i viandanti. Passando per il borgo medievale e seguendo antiche mulattiere si giunge al borgo di Maspiano, con la chiesa di San. Giacomo protettore dei pellegrini. La via si snoda attraverso distese di uliveti fino a raggiungere la meta suggestiva di Colpiano. Tratto 2: Marone – Zone Km: 8 Tempo di percorrenza: 8 ore Dislivello: +400 / - 50 m Periodo: da Maggio a Ottobre Difficoltà: Medio-facile Partendo dall’abitato di Marone inizia la salita panoramica che porta a Zone, tra muretti in pietra, antichi casolari e distese di ulivi. Proseguendo per il sentiero, in prossimità di un tornante, si possono ammirare delle particolari formazioni rocciose dette “Piramidi”: grossi funghi di terra formatasi durante l’ultima glaciazione e plasmati dall’erosione piovana. -

Rankings Municipality of Quinzano D'oglio
10/2/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links ITALIA / Lombardia / Province of Brescia / Quinzano d'Oglio Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH ITALIA Municipalities Powered by Page 2 Acquafredda Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Esine AdminstatAdro logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Fiesse Agnosine ITALIA Flero Alfianello Gambara Anfo Gardone Riviera Angolo Terme Gardone Val Artogne Trompia Azzano Mella Gargnano Bagnolo Mella Gavardo Bagolino Ghedi Barbariga Gianico Barghe Gottolengo Bassano Gussago Bresciano Idro Bedizzole Incudine Berlingo Irma Berzo Demo Iseo Berzo Inferiore Isorella Bienno Lavenone Bione Leno Borgo San Giacomo Limone sul Garda Borgosatollo Lodrino Borno Lograto Botticino Lonato del Bovegno Garda Bovezzo Longhena Brandico Losine Braone Lozio Breno Lumezzane Brescia Maclodio Brione Magasa Caino Mairano Calcinato Malegno Calvagese della Malonno Riviera Manerba del Calvisano Garda Powered by Page 3 Capo di Ponte Manerbio L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Capovalle Marcheno Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Capriano del MarmentinoITALIA Colle Marone Capriolo Mazzano Carpenedolo Milzano Castegnato Moniga del Castel Mella Garda Castelcovati Monno Castenedolo Monte Isola Casto Monticelli Brusati Castrezzato Montichiari Cazzago San -

Istituto Istruzione Superiore Giovanni Falcone Palazzolo S/O Brescia Italy
WELCOME TO OUR SCHOOL GIOVANNI FALCONE Istituto Istruzione Superiore Giovanni Falcone Palazzolo s/O Brescia Italy State vocational and technical school specializing in • Administration and Business • Tourism • Graphic Design and New Media • Social and health studies Giovanni Falcone It was founded more than 30 years ago and in 1997 it was dedicated to Giovanni Falcone, the Italian magistrate who, on May 23, 1992 was killed, together with his wife and three of his bodyguards, by a dynamite explosion placed beneath the motorway from Palermo Airport . Where is Palazzolo? Palazzolo s/ Oglio, Palazzolo upon Oglio, is located between Brescia and Bergamo two historical towns in the North of Italy, not far from Lake Iseo and the famous area called Franciacorta, made of gentle hills, covered with vineyards and olive trees . Lombardy Palazzolo sull’Oglio,takes its name from the river where it is located, the river comes out of Lake Iseo, one of the most important lakes in Northern Italy. Something about it This town was born along the river Oglio. Palazzolo was a fundamental industrial centre of Italy at the end of the 19th century. The Tower of the People, that is the symbol of the town was built between 1813 and 1830 and is today the second highest circular Italy's tower, after the Tower of Pisa. Lake Iseo Lake Iseo or Lago d'Iseo or Sebino is the fourth largest lake in Lombardy. The lake is almost equally divided between the Provinces of Bergamo and Brescia. This is an industrialised part of Italy but the area is also one of outstanding natural beauty. -
Autobus Trenino Turistico Alta Valle Camonica | Bs
© Andrey Burstein © Andrey AUTOBUS TRENINO TURISTICO ALTA VALLE CAMONICA | BS ORARI | ESTATE 2021 SERVIZIO AUTOBUS A SERVIZIO DELLA PISTA CICLABILE 2 10-11 / 17-18 LUGLIO • DAL 24 LUGLIO AL 22 AGOSTO • 28-29 AGOSTO 3 ORARI Ponte di Legno (P.le Cida) - Temù (partenza seggiovia Roccolo Ventura) - Stadolina bassa (campo sportivo) - Vezza d’Oglio (P.le Flayosc - Centro Eventi Adamello). PONTE DI LEGNO e FRAZIONI Ponte di Legno 11.30 15.30 16.30 17.30 Temù 11.36 15.36 16.36 17.36 LINEA A - B € 1,50 corsa semplice Stadolina bassa 11.40 15.40 16.40 17.40 Vezza d’Oglio 11.45 15.45 16.45 17.45 LINEA D Adulto + trasporto bike ........................................ 4,00 € € - fino a Pezzo 1,50 corsa semplice Bambino (fino a 12 anni) + trasporto bike ................ € 3,00 € - fino a Case di Viso 2,50 corsa semplice Vezza d’Oglio 12.00 16.00 17.00 18.00 - fino a Case di Viso (Under 14) € 1,50 corsa semplice Stadolina bassa 12.05 16.05 17.05 18.05 LINEA F € 2,00 corsa semplice Temù 12.09 16.09 17.09 18.09 Ponte di Legno 12.15 16.15 17.15 18.15 I biglietti si acquistano direttamente sull’autobus. INFO: Maroni Turismo tel. 0364 91045 - www.maroniturismo.it Bergamo, 29 giugno 2021 Avviso n. 9/2021 PONTE DI LEGNO - TEMÙ - VIONE VEZZA D’OGLIO - INCUDINE Oggetto: Servizio BICIBUS linea BS2 – tratta Edolo – Ponte di Legno. MONNO - EDOLO Si informa la Clientela che dal 1° luglio p.v., sulla tratta Edolo – Ponte di Legno e ritorno sarà attivato il servizio “BICIBUS” biciclette al seguito dell’autobus. -
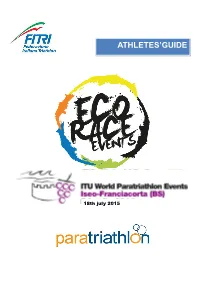
Athletes Guide
ATHLETES’GUIDE 18th july 2015 TABLE OF CONTENTS 1. GENERAL INFORMATION ................................................................................................................................. 1.1 Intoduction .............................................................................................................................................. 1.2 Key Dates ................................................................................................................................................. 1.3 Key Contacts ............................................................................................................................................ 1.4 Contact Details ......................................................................................................................................... 2. VENUE............................................................................................................................................................... 2.1 Venue ........................................................................................................................................................ 2.2 Elite Athletes Lounge ................................................................................................................................ 2.3 Doping Control .......................................................................................................................................... 2.4 Medical Services ...................................................................................................................................... -

Linea BS1 SESTO SAN GIOVANNI
ORARIO IN VIGORE dal 13 SETTEMBRE AL 12 GIUGNO 2022 Linea BS1 edizione 13 Settembre 2021 Contact center 035 289000 - Numero verde 800 139392 (solo da rete fissa) ANDATA www.bergamotrasporti.it | www.bergamo.arriva.it Sesto S.Giovanni - Bergamo Aeroporto Orio al Serio - Darfo Boario - Edolo - Ponte di Legno - Passo Tonale Stagionalità corsa FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER FEST FEST FEST FEST FEST FEST FEST FEST FEST Giorni di effettuazione 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 NOTE: A D E A D B D B D A D B D SESTO S.GIOVANNI (via Italia - Marelli) 8:50 13:50 18:25 8:50 13:50 18:25 SESTO S.GIOVANNI (rondò) 8:55 13:55 18:30 8:55 13:55 18:30 SESTO S.GIOVANNI (piazza I Maggio) 8:58 13:58 18:33 8:58 13:58 18:33 AGRATE (casello autostrada) 9:05 14:05 18:40 9:05 14:05 18:40 ORIO AL SERIO APT-IPER ORIO 9:40 14:40 19:15 9:40 14:40 19:15 BERGAMO - (Stazione P. n.9) - 09:35 I 14:30 I 19:05 I 8:45 I 14:30 I 18:35 I BERGAMO - via Borgo Palazzo (GS) 09:41 I 14:36 I 19:11 I 8:51 I 14:36 I 18:41 I SERIATE - via Italia, 45 (Municipio) 09:45 I 14:40 I 19:15 I 8:55 I 14:40 I 18:45 I PEDRENGO - via Nazionale, 6 09:48 I 14:43 I 19:18 I 8:58 I 14:43 I 18:48 I ALBANO S.Alessandro-Bar Big Ben 09:51 I 14:46 I 19:21 I 9:01 I 14:46 I 18:51 I S. -

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DOCUMENTO DI PIANO Ing
COMUNE di VIONE provincia di Brescia PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DOCUMENTO DI PIANO ing. Mauro Testini - Sindaco dott. Onofrio Caforio - Segretario comunale arch. Giovanni Cigognetti - Progettista arch. Lucia Massioli, cartog. Marco Bonezzi - collaboratori Livio Cassa - grafica RELAZIONE MODIFICATO A SEGUITO DELL’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI E DEL PARERE PROVINCIALE fase: APPROVAZIONE data: marzo 2013 aggiornamenti: dicembre 2013 ADOZIONE: Delibera consigliare n. 10 del 24 aprile 2013 ESAME OSSERVAZIONI: Delibera consigliare n. 42 del 13 dicembre 2013 APPROVAZIONE: Delibera consigliare n. 42 del 13 dicembre 2013 Studio associato arch. Giovanni Cigognetti • arch. Michele Piccardi • ing. Clara Vitale • Lonato d/G (Bs) località San Polo • tel. 030-9913807 • fax 030-9913682 • e-mail [email protected] Tutti i diritti di riproduzione e rielaborazione sono riservati. Comune di Vione provincia di Brescia RELAZIONE – DOCUMENTO DI PIANO INDICE 1. INTRODUZIONE 4 1.1. ATTIVITA’ PRELIMINARI 4 1.2. ATTIVITA’ DI ANALISI ED ELABORAZIONE E REDAZIONE 4 1.3. ADOZIONE E APPROVAZIONE 5 1.4. ATTUAZIONE E GESTIONE 6 2. IL TERRITORIO 7 2.1. INQUADRAMENTO GENERALE 7 2.2. IL CLIMA 10 2.3. SOGLIE STORICHE E STRUTTURA URBANA 10 2.4. IL PAESAGGIO AGRARIO 12 3. INDAGINE SUL SISTEMA SOCIO – ECONOMICO 13 3.1. DEMOGRAFIA 13 3.2. STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE 18 3.3 Istruzione 22 3.4. OCCUPAZIONE E ATTIVITA’ ECONOMICHE 23 3.5. IMPRESE E UNITA’ LOCALI 25 3.6. AGRICOLTURA 26 3.7. FAMIGLIE 27 3.8. USO DEL TERRITORIO 28 3.9. IL PATRIMONIO ABITATIVO 28 3.10. IL TURISMO 29 4. RILIEVO AEROFOTOGRAMMETRICO E S.I.T. 32 4.1. -
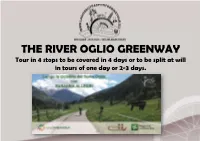
THE RIVER OGLIO GREENWAY Tour in 4 Stops to Be Covered in 4 Days Or to Be Split at Will in Tours of One Day Or 2-3 Days
THE RIVER OGLIO GREENWAY Tour in 4 stops to be covered in 4 days or to be split at will in tours of one day or 2-3 days. WHAT YOU’LL DISCOVER In these tours and stops you will cycle along a portion of the RIVER OGLIO GREENWAY: a route that will take you from the mountains of the upper Camonica Valley (2) along the shores of Lake Iseo (5) reaching the vineyards of Franciacorta (6). This greenway was awarded as the most beautiful cycle path in Italy at the Italian Green Road Awards 2019, it starts from the Tonale Pass at an altitude of 1883 and ends in the plain, in the province of Mantua, with an altitude difference of 1862mt, spread along its 280 km. The colors of the different areas will accompany you in the description of these stops. The tour can be cycled completely or can be split into 1- or 2-3-days tours. STOP N° 1 UPPER CAMONICA VALLEY You will set off from Tonale Pass riding along a dirt road, then reach Ponte di Legno, a nice high mountain town in Camonica Valley, where the two springs Frigidolfo and Narcanello merge and create the River Oglio. Tonale Pass, that marks the border between Lombardy and Trentino regions, is surrounded by the mountains where soldiers fought WW1 at the foot of Mount Adamello. We will cycle across part of Camonica Valley, stopping at a typical Italian trattoria if you wish. Then on to the land of the prehistoric Camuni, the first Italian Unesco World Heritage site: the rock engravings. -

The Valle Camonica National Prehistory and Proto-History Centre
OPENING TIMES Information Check on websites prior to visit; subject to modification. Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri (Tel. 0364.42140) HOW TO GET THERE: www.parcoincisioni.capodiponte.beniculturali.it www.lacittadina.it FROM THE SOUTH www.facebook.com/ParcoNaquane print: A4 Motorway/Freeway: exit at Seriate or Rovato; road SS42 (Tonale and Mendola), direction Passo del Tonale, exit Nadro-Ceto, Capo di Ponte, Open throughout the year from 8:30 until 13:30 Cimbergo-Paspardo - Rock art sites and follow signs for Capo di Ponte. Closed on Mondays ■ For Naquane locality Parco Archeologico Nazionale dei Massi di Cemmo After passing Capo di Ponte railway station, keep to the right at the www.parcoarcheologico.massidicemmo.beniculturali.it level crossing and take the road leading to the Chiesa delle Sante. Open throughout the year from 8:30 until 13:30 Closed on Mondays ■ For Cemmo locality At the first roundabout on the outskirts of Capo di Ponte, turn left and MUPRE (Tel. 0364.42403) follow signs for the Massi di Cemmo. www.mupre.capodiponte.beniculturali.it ■ For the Capo di Ponte museum (MUPRE) www.facebook.com/mupre.vallecamonica 7, Via S. Martino Open throughout the year from 14:00 until 19:00 1 Closed on Sundays FROM THE NORTH From the Aprica Pass or Tonale Pass, after reaching Edolo continue on road SS42 (Tonale and Mendola) direction Brescia; exit Capo di Ponte- TICKET PRICES Sellero direction Capo di Ponte. The ticket office shuts 30 minutes before closing time. E ■ For Naquane locality ADULTS: 4 (admittance to the Naquane National Rock Engravings Park After the second roundabout, turn left into Via Limit and follow signs and MUPRE; entry to the Cemmo National Archaeological Park is free). -

Mangiare a Pisogne Where To
1 2 3 4 5 6 7 8 1 TORRE DEL VESCOVO origini del paese. Ricostruita nel ‘400 con le caratteristiche prima tappa è quella dell’annuncio e dell’attesa; la seconda querce rosse americane, tassi, pini domestici, larici e cespugli incontro tra paesaggio, arte e storia. II viaggio è molto rupestre del “Bögn di Castro”. BISHOP’S TOWER forme della pieve rustica, ha al suo interno bellissimi affreschi campata allude alla caduta dell’umanità nel disordine di cedri penduli, falsi ginepri e un cipresso calvo della suggestivo, perché quasi sempre accompagnato dalla vista Starting from the hamlet of Toline, the route develops for 5 L’elegante piazza Corna Pellegrini, circondata da caratteristici tardo quattrocenteschi di Giovanni Pietro da Cemmo e religioso e quindi nell’eresia; la terza all’esaltazione della Florida o taxodium ed un abete rosso. A lato di una piccola del Lago d’Iseo e dei monti che lo circondano. II tracciato è km on the old coastal road, at a lower level than the Pisogne- portici, ospita la monumentale Torre del Vescovo. Costruita una Danza Macabra dipinta in controfacciata. È possibile Croce come cardine dell’intera storia umana. costruzione a torre si trovano tre esemplari di gingko biloba, indicato da cartelli informativi, frecce e da una V di colore Iseo coast road. Located at the water’s edge, with tunnels and con pietra locale nel 1250 e restaurata nel 2005 è di pianta scendere sotto il pavimento e visitare la cripta che prosegue Apertura: pianta assai rara risalente ai tempi della creazione del parco. giallo e marrone.