Studio Per La Valutazione D'incidenza Ambientale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Guarda Il PDF: Orari, Fermate E Percorso Linea
Orari e mappe della linea bus 20A 20A Arcidosso-Santa Fiora-Castell'Azzara Visualizza In Una Pagina Web La linea bus 20A (Arcidosso-Santa Fiora-Castell'Azzara) ha 12 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Amiata Stazione: 13:25 (2) Arcidosso Autostazione: 06:10 - 15:30 (3) Arcidosso Autostazione: 05:20 - 19:15 (4) Castel Del Piano Centrale: 07:10 - 18:00 (5) Castell'Azzara Centro: 08:05 - 19:29 (6) Largo Verdi: 05:46 - 06:40 (7) Piancastagnaio Centro: 06:10 (8) Santa Fiora Centrale: 14:30 - 15:50 (9) Seggiano C.Le: 05:50 - 15:05 (10) Seggiano Comune: 19:00 (11) Selvena Centro: 14:30 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus 20A più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus 20A Direzione: Amiata Stazione Orari della linea bus 20A 34 fermate Orari di partenza verso Amiata Stazione: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 13:25 martedì 13:25 Arcidosso Autostazione mercoledì 13:25 Arcidosso Centrale giovedì 13:25 Arcidosso Cimitero venerdì 13:25 Arcidosso Ponti sabato 13:25 Montoto domenica Non in servizio Arcidosso S.Lorenzo Castel Del Piano Campeggio Informazioni sulla linea bus 20A Castel Del Piano Hotel Impero Direzione: Amiata Stazione Fermate: 34 Durata del tragitto: 47 min Castel Del Piano Vittorio Veneto La linea in sintesi: Arcidosso Autostazione, Via Dalmazia, Castel del Piano Arcidosso Centrale, Arcidosso Cimitero, Arcidosso Ponti, Montoto, Arcidosso S.Lorenzo, Castel Del Castel Del Piano Centrale Piano Campeggio, Castel Del Piano Hotel Impero, Castel Del Piano Vittorio Veneto, Castel Del Piano Castel Del Piano Ospedale Centrale, Castel Del Piano Ospedale, Castel Del Piano Santucci, Castel Del Piano Santucci, Castel Del Piano Castel Del Piano Santucci Cimitero, Castel Del Piano Bivio Casella, Leccio, Pescina Bivio Sud, Pian Di Ballo, Tepolini, Podere La Castel Del Piano Santucci Lama, Bv. -

Aldobrandeschi.Pdf
Gli Aldobrandeschi. La grande famiglia feudale della Maremma toscana a cura di Mario Ascheri Lucio Niccolai Redazione: Consultacultura Viale Marconi 93, Santa Fiora e-mail: [email protected] Trascrizione e battitura testi: Maria Angela Iannelli Edizioni: C&P Adver effigi Via Roma, 14 - Arcidosso Stampa: Tipografia Ceccarelli, Gennaio 2002 Atti del convegno “Gli Aldobrandeschi. La grande famiglia feudale della Maremma toscana”, promosso da The international of Lions Club Distretto 108 “La Toscana” e realizzato a Santa Fiora il 26 maggio 2001, Organizzato dai Clubs Lions di: Alta Maremma, Amiata, Chianti, Chiusi, Grosseto Aldobrandeschi, Grosseto Host Orbello-I Presidi, Siena. In collaborazione e con il patrocinio di: Amministrazione provinciale di Grosseto, Comunità Montana Zona I1, Area grossetana, Azienda di promozione turistica (APT) Amiata, Comuni di Santa Fiora e di Arcidosso, Associazione Pro Loco di Santa Fiora, Associazione “Consultacultura” di Santa Fiora. Pubblicato dai Clubs Lions di: - Alta Maremma - Amiata - Chianti - Chiusi - Grosseto Aldobrandeschi - Grosseto Host - Orbetello I Presidi - Siena Collaborazione e patrocinio: Amministrazione Provinciale Grosseto Comunità Montana Amiata Ovest Azienda Promozione Turistica Amiata Comune di Santa Fiora Comune di Arcidosso Associazione Pro Loco di Santa Fiora Associazione Consultacultura di Santa Fiora In collaborazione con la Cassa di Risparmio di Firenze Realizzato grazie al contributo dell’azienda Tosti di Castel del Piano Immagini tratte da: G. CIACCI, Gli Aldobrandeschi nella storia e nella Divina Commedia, Roma 1934 e I. CORRIDORI, Gli Aldobrandeschi nella storia maremmana, Grosseto 1977. Genius Loci Storia e cultura locale Indice Rodolfo Fazzi, Presentazione p. 7 Saluti e interventi autorità p. 9 Lorenzo Maccari, L’importanza di questo convegno p. -

Viva Xpress Logistics (Uk)
VIVA XPRESS LOGISTICS (UK) Tel : +44 1753 210 700 World Xpress Centre, Galleymead Road Fax : +44 1753 210 709 SL3 0EN Colnbrook, Berkshire E-mail : [email protected] UNITED KINGDOM Web : www.vxlnet.co.uk Selection ZONE FULL REPORT Filter : Sort : Group : Code Zone Description ZIP CODES From To Agent IT ITAOD04 IT- 3 Days (Ex LHR) Cities & Suburbs CIVITELLA CESI 01010 - 01010 CELLERE 01010 - 01010 AZIENDA ARCIONE 01010 - 01010 ARLENA DI CASTRO 01010 - 01010 FARNESE 01010 - 01010 LATERA 01010 - 01010 MONTEROMANO 01010 - 01010 ONANO 01010 - 01010 PESCIA ROMANA 01010 - 01010 PIANSANO 01010 - 01010 TESSENNANO 01010 - 01010 VEIANO 01010 - 01010 VILLA S GIOVANNI IN TUSC 01010 - 01010 MUSIGNANO 01011 - 01011 CELLENO 01020 - 01020 CHIA 01020 - 01020 CASTEL CELLESI 01020 - 01020 CASENUOVE 01020 - 01020 GRAFFIGNANO 01020 - 01020 LUBRIANO 01020 - 01020 MUGNANO 01020 - 01020 PROCENO 01020 - 01020 ROCCALVECCE 01020 - 01020 SAN MICHELE IN TEVERINA 01020 - 01020 SERMUGNANO 01020 - 01020 SIPICCIANO 01020 - 01020 TORRE ALFINA 01020 - 01020 TREVIGNANO 01020 - 01020 TREVINANO 01020 - 01020 VETRIOLO 01020 - 01020 ACQUAPENDENTE 01021 - 01021 CIVITA BAGNOREGIO 01022 - 01022 BAGNOREGIO 01022 - 01022 CASTIGLIONE IN TEVERINA 01024 - 01024 GROTTE SANTO STEFANO 01026 - 01026 MAGUGNANO 01026 - 01026 CASTEL S ELIA 01030 - 01030 CALCATA 01030 - 01030 BASSANO ROMANO 01030 - 01030 FALERIA 01030 - 01030 FABBRICA DI ROMA 01034 - 01034 COLLEMORESCO 02010 - 02010 COLLI SUL VELINO 02010 - 02010 CITTAREALE 02010 - 02010 CASTEL S ANGELO 02010 - 02010 CASTEL SANT'ANGELO 02010 -
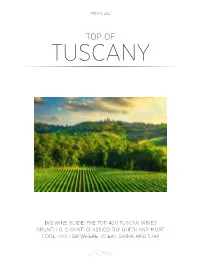
Top of Tuscany
SPECIAL 2021 TOP OF TUSCANY BIG WINE GUIDE: THE TOP 400 TUSCAN WINES BRUNELLO, CHIANTI CLASSICO, BOLGHERI AND MORE COOL TIPS FOR WHERE TO EAT, DRINK AND STAY Contents 05 Trends & facts 2020/2021 08 The three tenors Legends that have made history 14 The magnificent seven Talents of the year 19 Top 5 white wines The best white wines of the year 20 Top 10 red wines Editorial The best red wines of the year 22 Best buys 2020 10 wines offering top value for money ow that our lives are centred primarily on our own gardens and our own wine cellars (where time and finances allow), we have much more leisure 24 Vernaccia San Gimignano to do what we wish. COVID-19 has affected many things, including our N 28 Maremma view of ourselves as wine connoisseurs and quasi-globetrotters. The majority of our tours of Italy and Tuscany planned for spring and summer 32 Morellino die Scansano DOCG 2020 were limited to the works of Fruttero & Lucentini (especially their ’The Pal- io of Dead Riders’, the best Siena book of all) and to exploring the depths of var- 35 Montecucco ious bottles of mature Brunello, Chianti Classico, Vino Nobile or Bolgheri Supe- 38 Brunello di Montalcino riore. However, things will eventually change, and if you should find the time to flick through this edition of Top of Tuscany as you rekindle your wanderlust with 46 Vino Nobile die Montepulciano a glass of Tignanello or Masseto, we would be delighted. The following pages offer a colourful mix of wine stories, and above all a wealth 50 Chianti Classico DOCG of bottles tasted: we have selected more than 400 from all over Tuscany, with 145 granted the ’Top of Tuscany’ accolade. -

SANTA FIORA? I PROGRAMMI UNA MISTERIOSA DEI COMUNI SOMIGLIANZA AMIATINI Editoriale
cpadver-effigi.com – [email protected] VALLATI Periodico di informazione del comprensorio amiatino [email protected] Il Nuovo Corriere dell’Amiata Anno XIX n° 6 - Giugno - Agosto 2018, Euro 2 Spedizione in A.P. – 45% – AUT. 003 – ART. 2 comma 20/B legge 662/96 dc-Grosseto Seguiteci anche su www.ncamiata.it Estate ’18 SPECIALE LEONARDO ESTATE: DA VINCI TUTTI A SANTA FIORA? I PROGRAMMI UNA MISTERIOSA DEI COMUNI SOMIGLIANZA AMIATINI Editoriale Il nuovo corriere dell’Amiata Appuntamenti estivi Anno XIX, numero 6 Giugno - Agosto 2018 Mensile dell’Associazione culturale Paolo Benedetti omonima senza fini di lucro Associato al CRIC a montagna acquisisce in Produzione: C&P Adver estate un interesse particola- Mario Papalini re, sia per il clima mite che Edizioni: effigi 0564 967139 caratterizzaL i mesi di giugno luglio e Iscrizione al Tribunale agosto, sia per per gli eventi, moltepli- di Grosseto n. 9 ci ed eterogenei, che si svolgono alle depositata il 26.11.2001 sue pendici. Questo periodo è infatti Iscrizione al ROC n° 12763 caratterizzato da eventi culturali e da Direttore responsabile: Fiora Bonelli, appuntamenti tradizionali che da molti Via del Gallaccino, 58033 anni portano l’Amiata a essere meta di Castel del Piano, molti villeggianti. Feste medievali, ap- Tel. 0564 955044, puntamenti musicali e culturali, festival [email protected] eno-gastronomici, due palii, rendono la Segreteria di redazione: nostra montagna un luogo dove è piace- Paolo Benedetti 333 3652915 vole trascorrere l’estate, anche solo per Valeria Cenni 320 0404625 una passeggiata al fresco nei suoi bo- email [email protected]; schi. Abbiamo deciso di dedicare questo Redazione e sede: c/o numero a tutti, (o quasi), gli eventi che “Consultacultura” faranno parte di quest’estate amiatina, di Santa Fiora, Via Marconi 93, 58037 Santa Fiora sperando che sia di consiglio durante le e-mail: [email protected], calde serate di luglio e agosto. -

Montorsaio E Le Sue Famiglie
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI ARCHIVIO DI STATO DI GROSSETO AMMINISTRAZIONE DEGLI USI CIVICI DI MONTORSAIO MONTORSAIO E LE SUE FAMIGLIE TAMARA GIGLI SANESI Grosseto, 2007 MADDALENA CORTI : Coordinamento editoriale LUCIA GIUSTARINI : Revisione dell’impaginazione e grafica del testo VINCENZO CORTI : Stampa e rilegatura www.given.it : Realizzazione grafica della copertina Si ringraziano per la concessione del materiale iconografico i signori Aldo Ciabatti, Antonio Tosi e Franco Ballerini. Le immagini riguardanti gli stemmi del paese di Montorsaio sono state gentilmente concesse dall’Archivio di Stato di Siena su autorizzazione del 24 maggio 2007 prot.n. 2122/IX.2. Pr ese ntazione Il Comitato di Gestione della Amministrazione Usi Civici di Montorsaio, nelle persone degli attuali Consiglieri pro-tempore Riccardo Giovannini (Vice-Presidente), Belgrado Quadalti, Claudio Vagheggini, Stefano Ugolini, assistiti dal Tesoriere Rag. Luisa Saloni e dal Segretario Geom. Emilio Santucci, si è sentito onorato di poter fornire un proprio modestissimo contributo alla encomiabile iniziativa di Tamara Gigli Sanesi, che è riuscita con un laborioso e paziente lavoro di ricerca storica e archivistica a far rivivere nel lettore della sua opera antiche sensazioni, ancora più forti, poi, per i “vecchi” montorsaioli. Immagino, ad esempio, come avrebbe fatto piacere a mio padre Arcangelo sapere qualcosa di più di quel suo omonimo, morto nel 1917, di cui vedeva la lapide appesa al muro Est dell’antico Cimitero di Montorsaio e che, curiosità a parte, suscitava sempre in lui un’appena percettibile espressione di turbamento. Lasciandoci poi suggestionare dagli avvenimenti del nostro passato possiamo vedere il presente arricchito di nuovi particolari: forse solo sfumature, ma sempre significative e preziose. -

Orari E Percorsi Della Linea Bus
Orari e mappe della linea bus 0VA 0VA Abbadia S.S. Gorizia/Follonica Fs Visualizza In Una Pagina Web La linea bus 0VA (Abbadia S.S. Gorizia/Follonica Fs) ha 3 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Arcidosso Autostazione: 09:13 - 20:10 (2) Arcidosso Autostazione: 07:25 - 14:00 (3) Largo Verdi: 07:20 - 13:10 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus 0VA più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus 0VA Direzione: Arcidosso Autostazione Orari della linea bus 0VA 41 fermate Orari di partenza verso Arcidosso Autostazione: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 09:13 - 20:10 martedì 09:13 - 20:10 Paganico Piazzale mercoledì 09:13 - 20:10 Paganico Porta Gorella giovedì 09:13 - 20:10 Paganico Via Della Stazione venerdì 09:13 - 20:10 Paganico FS sabato 09:13 - 18:07 Paganico Consorzio domenica 09:13 San Luigi Terretello Ombrone Informazioni sulla linea bus 0VA Santa Petronilla Direzione: Arcidosso Autostazione Fermate: 41 Durata del tragitto: 40 min Ribugiano La linea in sintesi: Paganico Piazzale, Paganico Porta Gorella, Paganico Via Della Stazione, Paganico Santa Rita FS, Paganico Consorzio, San Luigi, Terretello Ombrone, Santa Petronilla, Ribugiano, Santa Rita, Podere Sant'Agostino Podere Sant'Agostino, Bivio Porrona, Cipressino, Sant'Angelo Bivio, Monte Salario, Mandrioni, 17+090, Bivio Porrona Molino, Montenero Bivio, Puccio, Coniella, Bivio Monticello, Ponte Zancona, Chiusina, Montegiovi Cipressino Bivio, Le Pergole, Case Rosse, Castel Del Piano San Processo, Castel Del Piano Gallaccino, Castel -

Provincia Di Pistoia
p_gr.AOOPGRO.REGISTRO UFFICIALE.U.0012615.06-05-2020 PROVINCIA di GROSSETO Area Viabilità e Trasporti Trasmissione Pec luogo e data come da protocollo Oggetto: AGGIORNAMENTO ELENCO STRADE DI PERTINENZA COMUNALE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO, PER L’ANNO 2020 - AUTOGRU /AUTOMEZZI con massa potenziale fino a t 60.00; - AUTOGRU / TRASPORTI con massa fino a t 72 con sagoma max di m 3.30 in Larg. e m 4.30 in H ; - Trasporti aventi dimensioni in altezza fino a m 4.30 con Larg. e Lung. regolari; - Automezzi trasportanti manufatti indivisibili eccedenti in Lung. il limite regolamentare; - Automezzi trasportanti PALI e TRALICCI con lunghezza fino a m 14.00; - Automezzi trasportanti macchine operatrici e manufatti ( Lung. m 20 / Larg. m 3 / H m 4.30 / Massa t 72 ) - MACCHINE AGRICOLE con larghezza fino a m. 4.50. Alle Amm/ni Prov/li della Regione Toscana Alla Città Metropolitana di Firenze Questa Amm.ne, allo scopo di snellire le procedure di rilascio delle autorizzazioni in oggetto, previste con Legge Reg. n^ 80/’82 e successive modifiche, onde venire incontro alle necessità operative degli utenti e degli Enti stessi, invia l’elenco delle Strade Comunali aggiornato per l’effettuazione dei transiti eccezionali per l’anno 2020 da autorizzare da parte di codesto Ente sulle strade che sono di competenza dei Comuni di questa Provincia, previa domanda degli utenti ed in conformità alle disposizioni di Legge. È possibile scaricare gli stessi alla pagina web della provincia al seguente link: https://tinyurl.com/y9426que Si allegano alla presente: - elenchi delle SS.CC. divise per ente di appartenenza. -

Programma Triennale Opere Pubbliche 2020-2022
SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 - CONSORZIO 6 TOSCANA SUD SCHEMA DI ELENCO TRIENNALE DEI LAVORI STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA a t a r t . n r E g o o i r c Cod. Amm.ne DESCRIZIONE INTERVENTO 2020 2021 2022 TOTALE p n ° a l N i B . f i R PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE ALLA CONFLUENZA DEL FIUME BRUNA - TORRENTE 1 2015 - 13/28 Lotto 018 FOSSA ED OPERE COMPLEMENTARI - POTENZIAMENTO IMPIANTO IDROVORO BACINO FOSSO BECCARELLO - Lavori di messa in sicurezza e opere complementari (ex Lotto 255-1 Str.A cbg) € 305.489,02 € - € - € 305.489,02 REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE ALLA CONFLUENZA DEL FIUME BRUNA - TORRENTE FOSSA ED OPERE 2 2013 - 13/12 Lotto 019 COMPLEMENTARI - già progetto Cod. 2012EGR0160 "Fiume Bruna. Cassa di espansione in loc. Castel di Pietra a seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012" (ex Lotto 284 cbg) € 2.341.236,03 € - € - € 2.341.236,03 2018 - 13/109 RECUPERO FUNZIONALE A SCOPI MULTIPLI DEL LAGO DI SAN FLORIANO AD USO PRIMARIO IRRIGUO IN COMUNE DI 3 Lotto 030 2012 - 7/1 CAPALBIO € 5.664.103,81 € - € - € 5.664.103,81 Lotto 032 - 1 PROGETTO PER L' AMPLIAMENTO DELLA SEDE DEL CONSORZIO 6 TOSCANA SUD ADIBITA AD USO UFFICI - COMUNE DI 4 2019 - 14/8-9 STR GROSSETO € 1.200.000,00 € - € - € 1.200.000,00 2015 - 13/72 INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'EQUILIBRIO SEDIMENTOLOGICO DEL FIUME ALBEGNA A SEGUITO DELL'EVENTO 5 Perizia 043 2019 - 13/112 ALLUVIONALE DEL 14 OTTOBRE 2014 € 509.756,22 € - € - € 509.756,22 INTERVENTI SUL FIUME OMBRONE PER LA RIDUZIONE DI RISCHIO IDRAULICO DELL'ABITATO DI ISTIA D'OMBRONE A 7 2013 - 25/44 Perizia 047 SEGUITO DELL’EVENTO ALLUVIONALE DEL 11 – 12 NOVEMBRE 2012 - COMUNE DI GROSSETO - (COD. -

Elenco Comuni Disagiati 2021
Comune Cap Provincia Descrizione Addebito ABBAZIA 21040 VA Zone Disagiate ABETINA VALLESANA 23035 SO Zone Disagiate ABETO 06040 PG Zone Disagiate ABETONE 51021 PT Zone Disagiate ABRIOLA 85010 PZ Zone Disagiate ACCADIA 71021 FG Zone Disagiate ACCARIA 88040 CZ Zone Disagiate ACCEGLIO 12021 CN Zone Disagiate ACCETTURA 75011 MT Zone Disagiate ACERENZA 85011 PZ Zone Disagiate ACERETO .AHORNACH. 00000 BZ Zone Disagiate ACQUACALDA 98050 ME Zone Disagiate ACQUACANINA 62035 MC Zone Disagiate ACQUAFORMOSA 87010 CS Zone Disagiate ACQUAFREDDA 25010 BS Zone Disagiate ACQUAFREDDA 85046 PZ Zone Disagiate ACQUARIA 41025 MO Zone Disagiate ACQUASANTA 16010 GE Zone Disagiate ACQUAVIVA 53040 SI Zone Disagiate ACQUAVIVA SM Zone Disagiate ACQUAVIVA D'ISERNIA 86080 IS Zone Disagiate ACQUAVIVA PLATANI 93010 CL Zone Disagiate ACRI 87041 CS Zone Disagiate ADAMI 88041 CZ Zone Disagiate ADRANO 95031 CT Zone Disagiate ADRARA SAN MARTINO 24060 BG Zone Disagiate ADRARA SAN ROCCO 24060 BG Zone Disagiate AFERS 39040 BZ Zone Disagiate AFFILE 00021 RM Zone Disagiate AFRICO 89030 RC Zone Disagiate AGAGGIO INFERIORE 18010 IM Zone Disagiate AGGIUS 07020 OT Zone Disagiate AGIRA 94011 EN Zone Disagiate AGLIENTU 07020 OT Zone Disagiate AGNINO 54010 MS Zone Disagiate AGNONE 86081 IS Zone Disagiate AGNOSINE 25071 BS Zone Disagiate AGORDO 32021 BL Zone Disagiate AGRA 21010 VA Zone Disagiate AGRANO 28020 NO Zone Disagiate AGRIANO 06040 PG Zone Disagiate AGROMONTE 85043 PZ Zone Disagiate AGROPOLI 84043 SA Zone Disagiate AHORNACH 39030 BZ Zone Disagiate AHRNTAL 39030 BZ Zone Disagiate -

Orari E Percorsi Della Linea Bus
Orari e mappe della linea bus 55A 55A Arcidosso - Abbadia Visualizza In Una Pagina Web La linea bus 55A (Arcidosso - Abbadia) ha 8 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Abbadia S.S. - I.T.I.S.: 12:35 (2) Arcidosso Autostazione: 07:10 - 17:15 (3) Castel Del Piano Centrale: 13:10 - 13:35 (4) Castel Del Piano Liceo: 06:55 (5) Castell'Azzara Centro: 13:35 (6) Largo Verdi: 07:20 - 18:50 (7) Santa Fiora Martiri Niccioleta: 14:35 (8) Santa Fiora Scuole Medie: 11:15 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus 55A più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus 55A Direzione: Abbadia S.S. - I.T.I.S. Orari della linea bus 55A 50 fermate Orari di partenza verso Abbadia S.S. - I.T.I.S.: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 12:35 martedì 12:35 Arcidosso Autostazione mercoledì 12:35 Arcidosso Centrale giovedì 12:35 Arcidosso Scoiattolo venerdì 12:35 Capenti sabato 12:35 Bv. Termini domenica Non in servizio Carrozieri Libero Informazioni sulla linea bus 55A Unibon Direzione: Abbadia S.S. - I.T.I.S. Fermate: 50 Durata del tragitto: 50 min Bagnore La linea in sintesi: Arcidosso Autostazione, Via della Chiesa, Santa Fiora Arcidosso Centrale, Arcidosso Scoiattolo, Capenti, Bv. Termini, Carrozieri, Libero, Unibon, Bagnore, Marconi Marconi, San Bastiano Marconi, San Bastiano, S.Fiora Cimitero, Santa Fiora Centrale, S.Fiora San Bastiano Marconi Stadio, Santa Fiora Scuole Medie, S.Fiora San Rocco, Marroneto Adorno, Marroneto Pacini, Marroneto, San Bastiano Marroneto Rettilineo, Fonte Spilli, Bagnolo, Bagnolo Bianchi, Faggia, Casa Fioravanti, Ponte Di Valle S.Fiora Cimitero Gelata, Saragiolo Zona Industriale, Saragiolo La Valle, Saragiolo Centro, Saragiolo Pinzuti, Santa Fiora Centrale Pietralunga, Capannucce, Tre Case, Piancastagnaio SP6, Santa Fiora Casa Eufemia, Piancastagnaio Bv. -

CAP Postali Ed Indirizzi Utili Della Provincia Di Grosseto (GR) - Regione Toscana
Alberghi, hotels, pensioni,campeggi www.soloprimi.com/Toscana/Toscana_turismo_vacanze_alberghi.php CAP postali ed indirizzi utili della Provincia di Grosseto (GR) - Regione Toscana CAP COMUNE FRAZIONE INDIRIZZO 58010 MANCIANO Marsiliana 58010 ORBETELLO Albinia 58010 ORBETELLO Fonteblanda 58010 ORBETELLO Polverosa 58010 ORBETELLO Santa_liberata 58010 ORBETELLO Talamone 58010 SORANO San_valentino 58010 SORANO San_quirico 58010 SORANO Pratolungo 58010 SORANO Montevitozzo 58010 SORANO Montebuono 58010 SORANO Sovana 58010 SORANO Castell'ottieri 58010 SORANO San_giovanni_delle_contee 58010 SORANO 58010 SORANO Elmo 58010 SORANO Montorio 58011 CAPALBIO Capalbio_stazione 58011 CAPALBIO Borgo_carige 58011 CAPALBIO 58011 CAPALBIO Chiarone 58012 ISOLA_DEL_GIGLIO Giglio_campese 58012 ISOLA_DEL_GIGLIO Giglio_castello 58012 ISOLA_DEL_GIGLIO Giglio_porto 58012 ISOLA_DEL_GIGLIO 58014 MANCIANO Montemerano 58014 MANCIANO San_martino_sul_fiora 58014 MANCIANO Poggio_murella 58014 MANCIANO Poderi_di_montemerano 58014 MANCIANO Cinema orari Multisala Spacecinema film in prima visione www.soloprimi.com/Toscana/cinema/Grosseto.php Farmacie di turno aperte o turni farmacie notturne comunali www.soloprimi.com/Toscana/farmacie/Grosseto.php CAP COMUNE FRAZIONE INDIRIZZO 58014 MANCIANO Saturnia 58014 MANCIANO Poggio_capanne 58015 ORBETELLO 58015 ORBETELLO Orbetello_scalo 58017 PITIGLIANO 58017 PITIGLIANO Il_casone 58018 MONTE_ARGENTARIO Porto_ercole 58019 ISOLA_DEL_GIGLIO Giannutri 58019 MONTE_ARGENTARIO 58019 MONTE_ARGENTARIO Porto_santo_stefano 58020 GAVORRANO Grilli