AVALLONE ANTONINO Campagna (SA) – Zona P.I.P
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
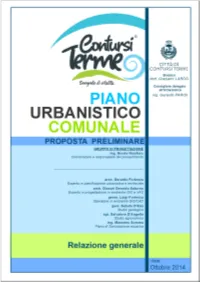
Relazione Generale
PIANO URBANISTICO COMUNALE DI CONTURSI TERME Relazione Generale 1/49 PIANO URBANISTICO COMUNALE DI CONTURSI TERME Relazione Generale Indice 1. Premessa pag.4 2. Introduzione pag.4 2.1 Finalità pag.4 2.2 Il quadro di riferimento normativo pag.4 2.3 Il processo di pianificazione pag.5 2.4 Obiettivi e contenuti del Puc pag.6 3. La forma del Piano pag.8 3.1 Il quadro conoscitivo pag.9 3.2 Il quadro strutturale pag.9 3.3 Il quadro programmatico pag.9 4. Il Quadro Conoscitivo pag.10 4.1 I Piani, le norme, i vincoli sovraordinati pag.10 4.1.1 Il Piano Territoriale Regionale (Ptr) pag.10 4.1.2 Carta dei paesaggi e Linee Guida per il Paesaggio pag.13 4.1.3 Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno pag.14 4.1.4 Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico pag.16 4.1.5 Le Norme di Salvaguardia della Riserva naturale Foce Sele e Tanagro pag.21 4.1.6 I Siti della Rete natura 2000 pag.22 4.1.7 I siti della Rete IBA (Important Bird Areas) pag.22 4.2 Inquadramento territoriale ed elementi descrittivi pag.23 4.2.1 Il territorio rurale ed aperto pag.23 4.2.2 Caratteri geomorfologici pag.24 4.3 Cenni storici pag.26 4.3.1 L’impianto urbanistico originario pag.26 4.3.2 Principali emergenze storiche, artistiche, architettoniche ed archeologiche pag.27 4.3.3 Il tessuto urbano del centro storico: caratteri tipo‐morfologici ed assetto pag.31 funzionale 4.4 Il sistema economico pag.32 4.4.1 Il sistema produttivo pag.32 4.4.2 Il turismo termale pag.33 4.4.3 L’agricoltura pag.34 4.5 Gli studi di settore pag.35 5. -

Provincia Di Salerno)
COMUNE DI CAMPAGNA (Provincia di Salerno) RIFERIMENTO DETERMINA N.G. 330 DEL 01/04/2020 N. AREA AMMINISTRATIVA 152 DEL 01/04/2020 ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE HANNO DATO LA DISPONIBILITA' AD ACCETTARE I BUONI SPESA ORDINANZA N. 658 DEL 29/03/202 AGGIORNATO ALLA DATA DEL 17/04/2020 ALLE ORE 09:45 Prot. Ragione Sociale Indirizzo Recapito N.ro data Telefonico 7175 01/04/2020 D.M.P. ITALIAN GROUP S.R.L. (SIGMA SUPERSTORE) VIA G. MAMELI N. 13 082844195 7181 01/04/2020 MILANESE GROUP S.R.L. VIA STARZA N. 4 828030243 7182 01/04/2020 LA MARGHERITA DA CIRO S.R.L.S. LOCALITA' PUGLIETTA 3316299420 7184 01/04/2020 MACELLERIE D'AMBROSIO S.R.L. VIA VALLEGRINI N. 28 082845860 7222 01/04/2020 ENNEA GROUP S.R.L. S.S. 91 PER EBOLI N. 23 082845459 - 3319035175 7231 01/04/2020 CAVALIERI ALFONSO & C. S.A.S. VIALE DELLA DEMOCRAZIA N. 146 082845511 - 3383138228 7232 01/04/2020 CAVALIERI GROUP S.R.L. VIALE DELLA DEMOCRAZIA N. 160 082846158 - 3383138228 7265 01/04/2020 LE DELIZIE DI SICILIA DI MANGANARO DANILO C.DA CASTRULLO S. PAOLO N.99 082845528 - 3355488347 7266 01/04/2020 IL TRIFOGLIO S.R.L. VIA STARZA N. 73 082845939 - 3472764703 7274 02/04/2020 SOCIETA' AGRICOLA LA BERSAGLIERA S.R.L. VIA PROV.LE PER CAMPAGNA N. 297 3347682161 7293 02/04/2020 MACELLERIA LUONGO SNC PIAZZA M. GUERRIERO N. 22 3333330956 - 3665218177 7297 02/04/2020 SUPER GI.MG. DI AMORUSO G. E FORLENZA I. -

Orari E Percorsi Della Linea Bus SITA
Orari e mappe della linea bus SITA SITA Batt.-Eboli -S.V. Aut Camp. - Contursi- Visualizza In Una Pagina Web Oliveto Z.I. -Sgm-Ricigliano-- La linea bus SITA (Batt.-Eboli -S.V. Aut Camp. - Contursi-Oliveto Z.I. -Sgm-Ricigliano--) ha 9 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Batt.-Eboli -S.V. Aut Camp. - Contursi-Oliveto Z.I. -Sgm-Ricigliano--: 12:50 (2) Buccino S. Vito - S. Gregorio Magno - Teglie: 13:10 (3) Buccino-Bv.Palom.-Contursi T.-Oliveto C.: 13:30 (4) Buccino-Sgm-Ol.Z.I. - Dogana - Oliveto C. -Camp. - Batt. - Bellizzi - Pont. - Salerno: 06:25 (5) Oliveto C.-Contursi T.-Bv.Palom.-Buccino: 07:10 (6) Oliveto C.-S.Gregorio M.- Ricigliano: 11:30 (7) Ricigliano-S.Gregorio M.-Oliveto C.: 12:30 (8) Ricigliano-Sgm-Contursi-S.V. Aut- Eboli - Aut. (Usc. Carmine) -Salerno: 07:10 (9) Teglie-S.Gregorio M.-Buccino S.Vito: 13:30 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus SITA più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus SITA Direzione: Batt.-Eboli -S.V. Aut Camp. - Contursi- Orari della linea bus SITA Oliveto Z.I. -Sgm-Ricigliano-- Orari di partenza verso Batt.-Eboli -S.V. Aut Camp. - 11 fermate Contursi-Oliveto Z.I. -Sgm-Ricigliano--: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 12:50 martedì 12:50 Battipaglia Belvedere mercoledì 12:50 Eboli giovedì 12:50 Sv. Autostrada Campagna venerdì 12:50 Sv. Autostr. Contursi sabato 12:50 Contursi domenica Non in servizio Piazza G. Garibaldi, Contursi Terme Ponte Oliveto Frazione Perazze Informazioni sulla linea bus SITA Direzione: Batt.-Eboli -S.V. -

Lista Località Disagiate - Ed
LISTA LOCALITÀ DISAGIATE Lo standard di consegna di Poste Delivery Express e Poste Delivery Box Express è maggiorato di un giorno per le spedizioni da/per le seguenti località: Regione Abruzzo Provincia L’Aquila ACCIANO COLLEBRINCIONI POGGETELLO SANTI AREMOGNA COLLELONGO POGGETELLO DI TAGLIACOZZO SANTO STEFANO SANTO STEFANO DI SANTE ATELETA COLLI DI MONTEBOVE POGGIO CANCELLI MARIE BALSORANO FAGNANO ALTO POGGIO CINOLFO SANTO STEFANO DI SESSANIO BARISCIANO FONTECCHIO POGGIO FILIPPO SCANZANO BEFFI GAGLIANO ATERNO POGGIO PICENZE SCONTRONE BUGNARA GALLO PREZZA SECINARO CALASCIO GALLO DI TAGLIACOZZO RENDINARA SORBO CAMPO DI GIOVE GORIANO SICOLI RIDOTTI SORBO DI TAGLIACOZZO CAMPOTOSTO GORIANO VALLI RIDOTTI DI BALSORANO TIONE DEGLI ABRUZZI CANSANO LUCOLI ROCCA DI CAMBIO TORNIMPARTE CAPESTRANO MASCIONI ROCCA PIA TREMONTI CAPPADOCIA META ROCCACERRO TUFO DI CARSOLI CARAPELLE CALVISIO MOLINA ATERNO ROCCAPRETURO VERRECCHIE CASTEL DEL MONTE MORINO ROCCAVIVI VILLA SAN SEBASTIANO VILLA SANTA LUCIA DEGLI CASTEL DI IERI OFENA ROSCIOLO ABRUZZI CASTELLAFIUME ORTOLANO ROSCIOLO DEI MARSI VILLA SANT’ANGELO CASTELVECCHIO CALVISIO PACENTRO SAN BENEDETTO IN PERILLIS VILLAVALLELONGA CASTELVECCHIO SUBEQUO PERO DEI SANTI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI VILLE DI FANO Lista Località Disagiate - Ed. -

Bollettino Movimenti
********************************************************************************** * SI-13-SM-PDO2B * * * * SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE * * * * * * SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO * * * * * * UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA * * * * * * UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : SALERNO * * * * * * ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO * * * * * * ANNO SCOLASTICO 2010/2011 * * * * * * ATTENZIONE: PER EFFETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY QUESTA STAMPA NON * * CONTIENE ALCUNI DATI PERSONALI E SENSIBILI CHE CONCORRONO ALLA * * COSTITUZIONE DELLA STESSA. AGLI STESSI DATI GLI INTERESSATI O I * * CONTROINTERESSATI POTRANNO EVENTUALMENTE ACCEDERE SECONDO LE MODALITA' * * PREVISTE DALLA LEGGE SULLA TRASPARENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. * * * * * ********************************************************************************** POSTI DI SOSTEGNO PER MINORATI PSICO-FISICI ***** TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL COMUNE 1. ALLEGRO FELICIA . 13/ 4/62 (SA) TIT. SU POSTI DI SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.) DA : SAMM06200Q - CAVA DE'TIRRENI"GIOVANNI XXIII" ( CAVA DE' TIRRENI ) A : SAMM285006 - CAVA DE'TIRRENI "BALZICO" ( CAVA DE' TIRRENI ) SOPRANNUMERARIO TRASFERITO A DOMANDA CONDIZIONATA PUNTI 210 2. ALVIGGI MAURIZIO . 15/ 6/60 (SA) TIT. SU POSTI DI SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.) DA : SAMM81802P - SALERNO - OGLIARA ( SALERNO ) A : SAMM18200T - SALERNO "TORRIONE ALTO" ( SALERNO ) PUNTI 174 3. BALDI CRISTINA . 8/ 1/67 (SA) TIT. SU POSTI DI SOSTEGNO (MIN. UDITO) DA : SAMM277018 - SMS CAVA T. S.PIETRO ( CAVA DE' TIRRENI ) A : SAMM285006 - CAVA DE'TIRRENI "BALZICO" ( CAVA DE' TIRRENI ) PUNTI 180 4. COLUCCI BRUNELLA . 8/ 2/56 (SA) TIT. SU POSTI DI SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.) DA : SAMM18200T - SALERNO "TORRIONE ALTO" ( SALERNO ) A : SAMM181002 - SALERNO "T.TASSO" ( SALERNO ) PUNTI 249 5. COPPOLA GIULIA . 29/ 1/70 (SA) TIT. SU POSTI DI SOSTEGNO (MIN. VISTA) DA : SAMM85901X - "LUIGI STAIBANO" ( MAIORI ) A : SAMM85901X - "LUIGI STAIBANO" ( MAIORI ) PRECEDENZA: UFF. NELLA SCUOLA SU ALTRA TIP. SOSTEGNO PUNTI 44 POSTI DI SOST. -

Brochure Progetto My Life
Chi Siamo Dove Siamo Associazione di Promozione Sociale con Associazione sede al Quadrivio di Campagna, promo- Unanimus tore del progetto e punto di riferimento Luogo di interesse: sul territorio per cittadini con bisogni speciali. Comuni di Campagna, Eboli e area Piano di Zona Organizzazione di Volontariato a carattere regiona- Sociale S3 ex S5 le, promotore del progetto; da 20 anni promuove i diritti delle PcD e loro famiglie, favorendo l’empo- Progetto werment delle persone e dell’intera comunità. Concessionario della struttura che sorge in una sua frazione (Puglietta). Responsabile della riqualica- MYMY LIFELIFE zione e valorizzazione del bene attraverso opere di manutenzione straordinaria. COMUNE DI CAMPAGNA Centro per la Cooperativa sociale di tipo A e B. Dalla sua costituzione si occupa di gestire a 360 gradi servizi di assistenza e supporto nel vasto VITA INDIPENDENTE panorama delle disabilità: dalla scuola, al lavoro; dal trasporto, alla domiciliarità, alla residenzialità, ai servizi per il tempo libero. Centro - Proge�o My Life Associazione di Promozione Sociale focalizzata su tutto ciò che riguarda l’assistente personale, a livello burocratico, di formazione e di gestione della libera scelta, perseguendo l’autodeterminazione e la piena autonomia delle PcD. Centro di Ricerca Interuniversitario - Come arrivare: Sapienza Università di Roma che coordina e partecipa a reti di eccellenza, a progetti Autostrada del Mediterraneo A2, Uscita Campagna (SA), di ricerca e attività di sviluppo locale a livello internazionale; studia soluzioni proseguire sulla SP38 in direzione Campagna. personalizzate per le aree della partecipa- Giunti al Quadrivio di Campagna, svoltare a destra e zione alla vita delle PcD, mediante l’utilizzo di tecnologie assistive. -

Località Disagiate Campania
Località disagiate Campania Tipo Regione Prov. Comune Frazione Cap previsti gg. Disagiata Campania AV ANDRETTA ALVANO 83040 4 Comune DisagiataCampania AV ANDRETTA ANDRETTA 83040 4 Disagiata Campania AV ANDRETTA CASADOGNA 83040 4 Disagiata Campania AV ANDRETTA MARGINE 83040 4 Disagiata Campania AV ANDRETTA MASSERIE GUGLIELMO 83040 4 Disagiata Campania AV ANDRETTA MASSERIE NIGRO 83040 4 Disagiata Campania AV ANDRETTA MATTINELLA 83040 4 Disagiata Campania AV ANDRETTA PISCIOLO 83040 4 Disagiata Campania AV ANDRETTA SCHIAVI 83040 4 Comune DisagiataCampania AV AQUILONIA AQUILONIA 83041 4 Disagiata Campania AV AQUILONIA CONTRADA MALEPASSO 83041 4 Comune DisagiataCampania AV BAGNOLI IRPINO BAGNOLI IRPINO 83043 4 Disagiata Campania AV BAGNOLI IRPINO LACENO 83043 4 Disagiata Campania AV BAGNOLI IRPINO ROSOLE 83043 4 Disagiata Campania AV BAGNOLI IRPINO VILLAGGIO LACENO 83043 4 Comune DisagiataCampania AV BISACCIA BISACCIA 83044 4 Disagiata Campania AV BISACCIA BISACCIA NUOVA 83044 4 Disagiata Campania AV BISACCIA CALAGGIO 83044 4 Disagiata Campania AV BISACCIA CALLI 83044 4 Disagiata Campania AV BISACCIA MACCHITELLA 83044 4 Disagiata Campania AV BISACCIA MASSERIA DI SABATO 83044 4 Disagiata Campania AV BISACCIA OSCATA 83044 4 Disagiata Campania AV BISACCIA PIANI SAN PIETRO 83044 4 Disagiata Campania AV BISACCIA PIANO REGOLATORE 83044 4 Disagiata Campania AV BONITO BEATRICE 83032 4 Disagiata Campania AV BONITO BEATRICE I 83032 4 Comune DisagiataCampania AV BONITO BONITO 83032 4 Disagiata Campania AV BONITO CINQUEGRANA 83032 4 Disagiata Campania -

Area Categoria Ditta Indirizzo Sede Legale Comune 1 Cilento Olivicoltore Azienda Agricola Benetollo Paola Bruna Via Ninio Bixio
Area Categoria Ditta Indirizzo sede legale Comune 1 Cilento Olivicoltore Azienda agricola Benetollo Paola Bruna Via Ninio Bixio, 15 Pollica 2 Cilento Olivicoltore Azienda agricola Caprarizzo Via Diagonale, 106 - Fraz. Patrivero (PD) Trivero 3 Cilento Olivicoltore Azienda agricola Cilento Aldo Via Serra, 30 San Mauro Cilento 4 Cilento Olivicoltore Azienda agricola Cilento Angelo Via Serra, 35 San Mauro Cilento 5 Cilento Olivicoltore Azienda agricola Cilento Franco Vicolo Roma, 16 San Mauro Cilento 6 Cilento Olivicoltore Azienda agricola Cilento Gennaro Via Piazza, 24 San Mauro Cilento 7 Cilento Olivicoltore Azienda agricola Cobellis G.Cobellis, 29 Vallo della Lucania 8 Cilento Olivicoltore Azienda agricola D'Agosto Francesco Via Roma San Mauro Cilento 9 Cilento Olivicoltore Azienda agricola D'Agosto Giuseppina Via Cappella San Mauro Cilento 10 Cilento Olivicoltore Azienda agricola D'Agosto Francesco Vicolo Piazza San Mauro Cilento 11 Cilento Olivicoltore Azienda agricola D'Angelo Crispino Via Ortali frazione S. Barbara,34 Ceraso 12 Cilento Olivicoltore Azienda agricola De Bellis Nicola Via Fontana Medina, 24 Casalvelino 13 Cilento Olivicoltore Azienda agricola Del Mastro Modesto Via S.Teodoro Serramezzana 14 Cilento Olivicoltore Azienda agricola Di Gregorio Romano Via Roma, 2 San Mauro Cilento 15 Cilento Olivicoltore Azienda agricola Feo Ottavio Via Sorrentini, 29 San Mauro Cilento 16 Cilento Olivicoltore Azienda agricola Ferolla Albertina Via Ferolla, 3 Ceraso 17 Cilento Olivicoltore Azienda agricola Fusco Enrica Via Fuschi Ceraso 18 Cilento Olivicoltore Azienda agricola Galotto Franco Via Velina, 99 Castelnuovo Cilento 19 Cilento Olivicoltore Azienda agricola Granito di Belmonte Angelo Vai Ferolla, 3 Ceraso 20 Cilento Olivicoltore Azienda agricola Guariglia Aldo Lisbona, 7 Padova 21 Cilento Olivicoltore Azienda agricola Guariglia Florinda C.da Sala San Mauro Cilento 22 Cilento Olivicoltore Azienda agricola Guariglia Rosa Via Sorrentini San Mauro Cilento 23 Cilento Olivicoltore Azienda agricola Iannuzzi Raffaele Via Porta la Terra , 5 fraz.Bosco S. -

Relazione Inaugurale Anno 2013
MATTEO CASALE Presidente della Corte di Appello di Salerno RELAZIONE SULL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NELL’ANNO 2012 Salerno, 26 gennaio 2013 Sommario Introduzione ...................................................................................................... 5 Profili rilevanti dell’Amministrazione della giustizia in generale nel distretto .......................................................... 9 La Giustizia Penale nel distretto, con particolare riferimento all’attività di tutti gli uffici requirenti .......................................... 27 La Giustizia Penale nel distretto, con particolare riferimento agli uffici giudicanti ..................................................................... 39 - Corte di Appello ............................................................................................... 39 - Corte di Assise di Appello e Sez. Penale Minorenni ........................................ 40 - Tribunale di Sorveglianza ................................................................................ 41 La Giustizia Civile nel distretto di Salerno .................................................... 43 - Corte di Appello Civile ..................................................................................... 43 - Corte di Appello Lavoro ................................................................................... 45 La Giustizia Penale e Civile ............................................................................ 47 - Tribunale di Salerno ....................................................................................... -

Elenco Priorita' B Aggiornato Anno 2011
ELENCO SOGGETTI CON DOMANDA PRESENTATA ENTRO IL 30/06/1988 AVENTI DIRITTO ALLA PRIORITA' ART. 3, COMMA 2, LETTERA B LEGGE 32/92 COMUNE: CAMPAGNA ( PROV. SALERNO) Prot. Verifica Dichiar. unicità causalità danno- di abitaz. ed Data Domanda di Data Presentazione Importo aggiornato Ditta Intestataria Data di Nascita Ubicazione Fabbricato sisma (Art.3 esigenza abit. N. Pratica Luogo di Nascita Contributo Progetto Contributo Richiesto (Cognome Nome) (gg/mm/aa) Danneggiato comma 1 (Art. 3 c. 2, lett. (gg/mm/aa) (gg/mm/aa) (Euro) N. L.32/92) b L. 32/92) d'ordin SI o NO SI o NO e 47/BIS Moscato Attilio e Gennaro Campagna 21/01/1916-25/05/1946 PUGLIETTA 31/12/1987 1934 13/02/1989 ¤ 133.826,69 SI SI 1 2 75/bis Glielmi Gerardo Campagna 26/10/1923 SERRADARCE 31/12/1987 1962 29/09/1988 ¤ 89.230,74 SI SI 81/bis NAIMOLI LUCIA Campagna 19/12/1953 SERRADARCE 31/12/1987 1968 30/6/1988 SI SI 3 ¤ 168.555,14 4 81/bis NAIMOLI GIUSEPPE Campagna 28/4/1970 SERRADARCE 31/12/1987 1968 30/6/1988 SI SI 5 87/bis AVALLONE VITO ORA ANTONIO Campagna 11/3/1934 SERRADARCE 31/12/1987 1968 30/6/1988 ¤ 219.180,04 SI SI 6 101/bis FASANO EMIDDIO (ORA DE LUNA MARGHERITA) Campagna 22/12/1921 SERRADARCE 04/05/1988 1125 31/3/1989 ¤ 101.017,65 SI SI MADONNA DELLE 105/bis MARATEA LIBERATO Campagna 5/10/1947 11/03/1988 622 11/3/1988 ¤ 118.277,75 SI SI 7 GRAZIE 8 1 BUSILLO CARMINE (ORA EREDI) Campagna 5/1/1949 RUFIGLIANO 22/03/1988 754 13/4/1989 ¤ 63.124,10 SI SI 9 2 DE LUNA ANGELO Campagna 1/4/1961 SERRADARCE 22/03/1988 755 22/3/1988 ¤ 112.147,33 SI SI 4 BUSILLO BIAGIO Campagna 26/8/1932 AUSELLA 24/03/1988 775 28/3/1989 ¤ 84.423,00 SI SI 10 11 5 MIRRA COSIMO Campagna 11/12/1936 S. -

POLYMNIA Studi Di Archeologia 7 Polymnia Collana Di Scienze Dell’Antichità Fondata E Diretta Da Lucio Cristante ______
POLYMNIA Studi di archeologia 7 Polymnia Collana di Scienze dell’antichità fondata e diretta da Lucio Cristante _____________________________________________________________ Studi di archeologia a cura di Federica Fontana - 7 - COMITATO SCIENTIFICO Elisabetta Borgna (Udine), Irene Bragantini (Napoli), Giuliana Cavalieri Manasse (Verona), Michel Fuchs (Lausanne), Jana Horvat (Ljubljana), John Scheid (Paris), Christopher Smith (The British School at Rome), Dirk Steuernagel (Regensburg), Franca Taglietti (Roma), Cinzia Vismara (Cassino) *Sacrum facere : atti del 3. Seminario di Archeologia del sacro Lo spazio del sacro: ambienti e gesti del rito, : Trieste, 3-4 ottobre 2014 / a cura di Federica Fontana, Emanuela Murgia. – Trieste : EUT Edizioni Università di Trieste, 2016. – XII, 491 p- : ill. ; 24 cm. – (Polymnia : studi di archeologia ; 7) Autori: Seminario di archeologia del sacro <3. ; Trieste ; 2014> Fontana, Federica ; Murgia, Emanuela Soggetti: Luoghi sacri – Roma antica – Atti di congressi WebDewey: 292.35093763.. RELIGIONE CLASSICA (GRECA E ROMANA) – LUOGHI SACRI – ROMA ANTICA ISBN 978-88-8303-679-8 (print) ISBN 978-88-8303-680-4 (online) I testi pubblicati sono liberamente disponibili su: http://www.openstarts.units.it © Copyright 2016 – EUT EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE Proprietà letteraria riservata I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale di questa pubblicazione, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, le fotocopie o altro), sono riservati per tutti i Paesi I contributi sono sottoposti, nella forma del doppio anonimato, a peer review di due esperti, esterni al Comitato Scientifico o alla Direzione. Sacrum facere Atti del III Seminario di Archeologia del Sacro Lo spazio del ‘sacro’: ambienti e gesti del rito Trieste, 3-4 ottobre 2014 a cura di Federica Fontana Emanuela Murgia Edizioni Università di Trieste 2016 Con il contributo di Fondazione Filantropica Ananian INDICE Premessa VII Federica Fontana Spazi e gesti del ‘sacro’. -

Relazione Illustrativa Progetto Esecutivo
Comune di Campagna - Messa in sicurezza di infrastrutture stradali comunali– Progetto Esecutivo 1 Sommario 1. Premessa ................................................................................................................................ 2 2. Inquadramento generale .......................................................................................................... 3 3. Rete stradale ........................................................................................................................... 5 4. Zone interessate dall’intervento ............................................................................................. 6 Zona Centro Storico .................................................................................................................... 6 Zona Quadrivio ............................................................................................................................ 8 5. Stato di fatto rete stradale ...................................................................................................... 10 Stato di fatto – tronco stradale località Centro Storico ............................................................... 10 Stato di fatto – tronco stradale località Quadrivio ....................................................................... 17 6. Interventi di progetto .............................................................................................................. 19 Interventi tronco stradale Centro Storico...................................................................................