Edizioni Dell'assemblea 70
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Divine Comedy Inferno • Purgatory • Paradise • a Life of Dante POETRY Read by Heathcote Williams with John Shrapnel Inferno
Dante The Divine Comedy Inferno • Purgatory • Paradise • A Life of Dante POETRY Read by Heathcote Williams with John Shrapnel Inferno 1 Canto I 7:43 2 Canto II 7:27 3 Canto III 7:45 4 Canto IV 8:02 5 Canto V 8:16 6 Canto VI 6:55 7 Canto VII 7:44 8 Canto VIII 7:28 9 Canto IX 7:34 10 Canto X 7:29 11 Canto XI 5:51 12 Canto XII 7:03 13 Canto XIII 7:21 14 Canto XIV 7:50 15 Canto XV 5:58 16 Canto XVI 7:39 2 17 Canto XVII 6:30 18 Canto XVIII 7:36 19 Canto XIX 6:35 20 Canto XX 6:29 21 Canto XXI 6:18 22 Canto XXII 7:11 23 Canto XXIII 8:00 24 Canto XXIV 7:45 25 Canto XXV 7:17 26 Canto XXVI 7:36 27 Canto XXVII 6:21 28 Canto XXVIII 7:43 29 Canto XXIX 7:10 30 Canto XXX 7:57 31 Canto XXXI 7:55 32 Canto XXXII 6:35 33 Canto XXXIII 8:34 34 Canto XXXIV 8:30 Time: 4:10:30 3 Purgatory 35 Canto I 8:16 36 Canto II 8:01 37 Canto III 8:24 38 Canto IV 8:45 39 Canto V 8:23 40 Canto VI 9:01 41 Canto VII 7:35 42 Canto VIII 8:11 43 Canto IX 9:00 44 Canto X 8:20 45 Canto XI 8:14 46 Canto XII 7:54 47 Canto XIII 9:07 48 Canto XIV 8:05 49 Canto XV 8:31 50 Canto XVI 8:11 4 51 Canto XVII 8:13 52 Canto XVIII 7:53 53 Canto XIX 8:17 54 Canto XX 8:28 55 Canto XXI 8:11 56 Canto XXII 8:12 57 Canto XXIII 7:44 58 Canto XXIV 8:55 59 Canto XXV 8:06 60 Canto XXVI 8:28 61 Canto XXVII 8:09 62 Canto XXVIII 7:47 63 Canto XXIX 7:20 64 Canto XXX 7:55 65 Canto XXXI 7:58 66 Canto XXXII 8:32 67 Canto XXXIII 8:59 Time: 4:33:28 5 Paradise 68 Canto I 8:42 69 Canto II 8:36 70 Canto III 6:38 71 Canto IV 7:48 72 Canto V 7:47 73 Canto VI 7:44 74 Canto VII 8:12 75 Canto VIII 7:41 76 Canto IX 7:48 -

Dante and Giovanni Del Virgilio : Including a Critical Edition of the Text
Digitized by the Internet Archive in 2007 with funding from IVIicrosoft Corporation http://www.archive.org/details/dantegiovannidelOOdantuoft DANTE AND GIOVANNI DEL VIEGILIO. W^ Dante and Giovanni del Virgilio Including a Critical Edition of the text of Dante's " Eclogae Latinae " and of the poetic remains of Giovanni del Virgilio By Philip H. Wicksteed, M.A. and Edmund G. Gardner, M.A. Solatur maesti nunc mea fata senis Westminster Archibald Constable & Company, Ltd. 1902 GLASGOW: PRINTED AT THE UNIVERSITY PRESS BV ROBERT MACLEHOSB AND CO. TO FRANCIS HENRY JONES AND FRANCIS URQUHART. PREFACE. Our original intention was merely to furnish a critical edition, with a translation and commentary, of the poetical correspondence between Dante and Del Virgilio. But a close study of Del Virgilio's poem addressed to Mussato, with a view to the discovery of matter illustrative of his correspondence with Dante, convinced us that Dante students would be glad to be able to read it in its entirety. And when we found ourselves thus including the greater part of Del Virgilio's extant work in our book, the pious act of collecting the rest of his poetic remains naturally sug- gested itself; and so our project took the shape of an edition of Dante's Latin Eclogues and of the poetic remains of Del Virgilio, The inclusion in our work of the Epistle to Mussato made some introductory account of the Paduan poet necessary ; and his striking personality, together with the many resemblances and contrasts between his lot and that of Dante, encouraged us to think that such an account would be acceptable to our readers. -

Dante's Hidden
Dominican Scholar Graduate Master's Theses, Capstones, and Culminating Projects Student Scholarship 5-2016 Dante’s Hidden Sin - Wrath: How Dante Vindictively Used The Inferno Against Contemporaries Michael J. Rupers Dominican University of California https://doi.org/10.33015/dominican.edu/2016.hum.01 Survey: Let us know how this paper benefits you. Recommended Citation Rupers, Michael J., "Dante’s Hidden Sin - Wrath: How Dante Vindictively Used The Inferno Against Contemporaries" (2016). Graduate Master's Theses, Capstones, and Culminating Projects. 214. https://doi.org/10.33015/dominican.edu/2016.hum.01 This Master's Thesis is brought to you for free and open access by the Student Scholarship at Dominican Scholar. It has been accepted for inclusion in Graduate Master's Theses, Capstones, and Culminating Projects by an authorized administrator of Dominican Scholar. For more information, please contact [email protected]. Dante’s Hidden Sin: Wrath How Dante Vindictively Used The Inferno Against Contemporaries by Michael Rupers A culminating thesis submitted to the faculty of Dominican University of California in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Humanities San Rafael, California May 2016 This thesis, written under the direction of the candidate’s thesis advisor and approved by the department chair, has been presented to and accepted by the Department of Humanities in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts. The content and research presented in this work represent the work of the candidate alone. Michael Rupers May 2016 Candidate Joan Baranow, Ph.D. May 2016 MAH Program Director Sister Aaron Winkelman, Ph.D., Professor Emerita (English) May 2016 Thesis Advisor Leslie Ross, Ph.D., Professor (Art History) May 2016 Secondary Thesis Advisor "II Copyright @ 2016 by Michael Rupers All Rights Reserved "III Table of Contents Introduction: Contemporaries of Dante in The Inferno ……………….……… 1 Pope Celestine V ………………………………………………………………. -

La Destinataria Del Congedo E Un'ipotesi Di Contestualizzazione
LA DESTINATARIA DEL CONGEDO E UN’IPOTESI DI CONTESTUALIZZAZIONE UMBERTO CARPI Su questo tema mi sono già soffermato altrove e il mio contributo non potrà andar molto oltre la ripresa di quanto già ho detto1, salvo qualche ulteriore osservazione suggerita soprattutto dalle acquisizioni nel frattempo intervenute sull’ordinamento delle canzoni dopo la capitale edizione De Robertis e alla luce delle conseguenze che ne sono state tratte in particolare da Natascia Tonelli (sviluppate anche nel nostro convegno dell’anno scorso su Tre donne). La strutturazione infatti come ‘libro delle canzoni’ e l’ipotesi che tale strutturazione risalga proprio a questa fase e sia legata al noto invio a Moroello della ‘montanina’ inducono a leggere le tre canzoni conclusive in modo fortemente sistematico anche dal punto di vista delle prospettive politiche e dell’elaborazione concettuale, e ciò non solo in quanto legate alla medesima fase biografica, ma anche perché concepite appunto nel mentre che quella strutturazione era in corso e dunque ad essa in qualche modo funzionalmente (analoga funzionalità al ‘libro’, del resto, andrà riscontrata nelle attualizzanti reinterpretazioni ‘conviviali’ di canzoni risalenti ad altra epoca e a diversissimo contesto e nella stessa teorizzazione del genere canzone abbozzata nel De vulgari). Che in Tre donne Venere e Drittura siano scoperte e enfatizzate sorelle mi pare essenziale ad intendere l’inscindibilità del nesso tra Virtù e Bellezza in Doglia mi reca; l’esilio dato a Drittura e alle sue figlie – esilio non solo fiorentino -

From the Divine Comedy
DANTE POETRY UNABRIDGED Infernofrom The Divine Comedy Read by Heathcote Williams ABANDON ALL HOPE YOU WHO ENTER HERE (Lasciate ogne speranza voi ch’intrate) Dante’s Hell is one of the most remarkable visions in Western literature. An allegory for his and future ages, it is, at the same time, an account of terrifying realism. Passing under a lintel emblazoned with these frightening words, the poet is lead down into the depths by Virgil and shown those doomed to suffer eternal torment for vices exhibited and sins committed on earth. The Inferno is the first part of the long journey which continues through redemption to revelation – through Purgatory and Paradise – and, in this translation prepared especially for audiobook, his images are as vivid as when the poem was first written in the early years of the 14th century. Heathcote Williams, poet, playwright and actor, has made a significant contribution to many fields. He is best known for his extended poems Total running time: 4:10:30 on environmental subjects: Whale Nation, Falling for a Dolphin, Sacred Elephant and Autogeddon. His plays have also won acclaim, notably AC/DC 4 CDs produced at London’s Royal Court, and Hancock’s Last Half Hour. As an View our catalogue online at actor he has been equally versatile – taking memorable roles in Orlando, n-ab.com/cat Wish You Were Here and Derek Jarman’s The Tempest, in which he played Prospero. He also reads Purgatory and Paradise from The Divine Comedy for Naxos AudioBooks. = Downloads (M4B chapters or MP3 files) = CDs (disc–track) 1 1-1 Canto -

Inferno00dant 2.Pdf Download
Signet (lassies. 'jw THE IN Translated by John Ciardi Digitized by the Internet Archive in 2013 http://archive.org/details/inferno00dant_2 "Fresh and sharp. ... I think [Ciardi'sl version of Dante will be in many respects the best we have seen." —John Crowe Ransom Considered Italy's greatest poet, Dante Alighieri (1265-1321) was the scion of a Florentine family who mastered the art of lyric poetry at an early age. His first major work, La Vita Nuova ( 1 292), was a tribute to Beatrice Portinari, the great love of his life. Dante's political activism resulted in his being exiled from Florence, and he eventually settled in Ravenna. It is be- lieved that The Divine Comedy—comprising three canticles, The Inferno, The Purgatorio, and The Paradiso—was writ- ten between 1 308 and 1320. John Ciardi (1916-86), a distinguished poet and professor, taught at Harvard and Rutgers universities and served as po- etry editor of the Saturday Review. He was a Fellow of the American Academy of Arts and Sciences and the National Institute of Arts and Letters. In 1955, he won the Harriet Monroe Memorial Award and the Prix de Rome in 1956. Archibald T. MacAHister (1905-66) taught at Yale and at Brown University before joining the Princeton faculty in 1940, where he taught the advanced course in the Divine Comedy. He was chair of the Italian section of the Department of Ro- mance Languages at Princeton, and contributed many arti- cles on Dante to scholarly publications, including the entry on Dante in A Dictionary ofMoral Philosophy. -

Historical Characters in Dante's Divine Comedy
University of Pennsylvania ScholarlyCommons Publicly Accessible Penn Dissertations 2019 Uncovering The Sources: Historical Characters In Dante's Divine Comedy Vanessa Dimaggio University of Pennsylvania, [email protected] Follow this and additional works at: https://repository.upenn.edu/edissertations Part of the Italian Literature Commons, Medieval History Commons, and the Medieval Studies Commons Recommended Citation Dimaggio, Vanessa, "Uncovering The Sources: Historical Characters In Dante's Divine Comedy" (2019). Publicly Accessible Penn Dissertations. 3486. https://repository.upenn.edu/edissertations/3486 This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/edissertations/3486 For more information, please contact [email protected]. Uncovering The Sources: Historical Characters In Dante's Divine Comedy Abstract A lack of citation of Dante’s specific source material for historical characters who appear in the Divine Comedy is widespread throughout the commentary tradition. I performed a close textual analysis of the Divine Comedy’s historical characters, comparing them with the chronicles, annals and histories of Dante’s time, using both archival research and secondary histories to do so, and interpreted those primary historical texts as potential sources consulted by Dante. The historical characters I focused on fell into three categories: 1) characters involved in the battles of Montaperti and Colle Val d’Elsa, 2) characters belonging to or associated with the Norman, Swabian and Aragonese dynasties of Sicily, 3) characters embroiled in sensational or newsworthy events during Dante’s lifetime. The first two categories analyzed historical events that mostly occurred before Dante was born, and thus focused more heavily on written testimony, while the third category analyzed the news of Dante’s adulthood, and thus focused more on oral tradition. -

Dante Alighieri
DANTE ALIGHIERI PoR J. Rrcsnno DuEÑAs, V. S. ADVERTENCIA GENERAL Con una o dos excepciones, los versos que en este estudio apa, ecen en italiarw, han sido tomados, con absoluta fidelidad, de la obra: ''LA COMMEDIA", di Dante Alighie1i -Novamente riveduta nel Testo, e dichiarata da BRUNONE BIANCHI". La edición es de 1868 y per- teneció originalmente al Ilustrísimo Arzobispo de San Salvador, Mon· señor Belloso y Sánchez, en los tiempos en que aún era Cura Párroco. En la primera página aparece su firma, y la fecha de "Nov. 1884''. Las traducciones al Castellano han sido tomadas con igual [ide- lidad-también con una o dos excepciones- de "LA DIVINA COME- DIA", traducción en verso de Bartolomé Mitre. Edíción Sopena. EL AUTOR. 120 La Universidad PALABRAS PRELIMINARES "Leggere Dante é dooet e Rileggei e é bisogno Sentirlo é un principio de gt andezzo"; Releyendo un viejo libio, una de esas antiguas ediciones finamente encuadernadas de la "Divina Comedia", llena de anotaciones y subraya- dos trazados p01 una mano sabia y entendida y comprada por nosotros poi unos cuantos centavos en una de esas ventas de libios viejos que poi fortuna todavía existen en algunas de las grandes ciudades de Eiu opa y Estados Unidos, nos enconn amos con las reflexiones que sil ven de epígrafe a estas "Palahi as Preliminares". El pequeño volumen está poblado de acotaciones y comentar ios, de subrayados y llamadas, de citas y reíerencias, todas ellas escritas poi una mano de mujer, De una mujer joven y evidentemente bella, inteligente y espiritual. Acaso una nueva Beatriz. -

Catalogue of the Medici Archives, Consisting of Rare Autograph Letters, Records and Documents, 1084-1770
ru im ! m MEDICI ARCHIVES THE PROPERTY OF THE MARQUIS COSIMO DE' MEDICI AND THE MARQUIS AVERARDO DE' MEDICI On MONDAY, FEBRUARY. 4, 1918 AND THREE FOLLOWING DAYS t df tfakntnt.,. t^ ^rM'perlnJLf^ df^- J ' * J^ fl J f f J* / Jf / A '' ' ~ Frontispiece 239 OF THE MEDICI ARCHIVES Consisting of RARE AUTOGRAPH LETTERS Records and Documents 1084-1770 Including ONE HUNDRED AND SIXTY-SIX HOLOGRAPH LETTERS OF LORENZO THE MAGNIFICENT The Property of THE MARQUIS COSIMO DE' MEDICI and THE MARQUIS AVERARDO DE' MEDICI WHICH Mill be Sotfc b Huction by MESSRS. CHRISTIE, MANSON & WOODS (L, HANNEN, W. B. ANDERSON, AND V. C. W. AGNEW) AT THEIR GREAT ROOMS 8 KING STREET, ST. JAMES'S SQUARE LONDON On MONDAY, FEBRUARY 4, 1918 AND THREE FOLLOWING DAYS AT ONE O'CLOCK PRECISELY May be viewed Thursday and Friday preceding, and Cata- logues had, at Messrs. CHRISTIE, MANSON AND WOODS' Offices, 8 Kiny Street. St. James s Square, London, S. W. 1 CONDITIONS OF SALE. I. Bidder to be the and if arise THE highest Buyer ; any dispute between two or more Bidders, the Lot so in dispute shall be immediately put up again and re-sold. less than Is. above Five 5s. and II. No person to advance ; Pounds, ; so on in proportion. III. In the case of Lots upon which there is a reserve, the Auctioneer shall have the right to bid on behalf of the Seller. IV. The Purchasers to give in their Names and Places of Abode, and to pay down 5s. in the Pound, or more, in part of payment, of in default or the whole the Purchase-Money, if required ; of which, the Lot or Lots so purchased to be immediately put up again and re-sold. -
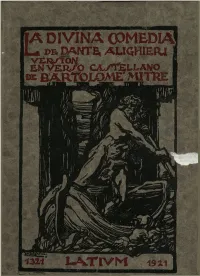
La Divina Comedia
LA DIVINA COMEDIA La Divina Comedia de Dante Aliglüeri Traducción en verso ajustada al original por Bartolomé Mitre Sueva edición, definitiva, autorizada, dirigida por Nicolás Besio Moreno Buenos Aires Centro cultural "Latiunt" 1922 IXDICE CASTOS I-IV INFIERNO I n di c e Prefacio Pág. I Teoría del traductor VII II Bibliografía de la traducción: Ediciones ante ñores XVII III La presente edición XXI ]V Correcciones de Mitre a su edición de 1897. XXV Fe de erratas XLI Primera parte El infierno PROEMIO GENERAL: La selva oscura Canto primero: El extravío, la falsa vía y el guía seguro PROEMIO DEL INFIERNO: El viaje pavoroso. Canto segundo: Terror humano y consuelo divino; las tres mujeres benditas VESTÍBULO : Cobardía y pereza. Canto tercero: La puerta infernal; el vestíbulo de los cobardes y el paso del Aqueronte 15 CIRCULO PRIMERO: Limbo. Canto cuarto: Párvulos inocentes, patriarcas y hombres ilustres 505 CANTOS V-XV Pág. CIRCULO SEGUNDO: Lujuria. Canto quinto: Niños; pecadores camales; Francesca da Rimini 27 CIRCULO TERCERO: Gula. Canto sexto: Cerbero; Ciaceio y su profecía .... 33 CIRCULO CUARTO: Avaricia y prodigalidad. Canto sétimo: Pluto; pena de los avaros y pródigos; la fortuna 38 CIRCULO QUISTO: Ira. Canto sétimo: Suplicio de los iracundos ..... 41 Canto octavo: Flegias; Argenti; muro y puerta de Dite ; oposición de los demonios 42 PUERTAS DE DÍTE: La entrada a la ciudad. Canto noveno: Angustia; las tres furias; el mensajero celeste 48 CIRCULO SEXTO: Herejía. Canto noveno: La región de los heresiareas y sus se cuaces 52 Canto décimo: Farinata; Cavalcante Cavalcanti; Fede rico II; el Cardenal 54 Canto undécimo: Tumba del papa Anastasio; distribu ción de los condenados en el infierno 60 CIRCULO SÉTIMO: Violencia. -

The Divine Comedy by Dante Alighieri (1265-1321)
The Divine Comedy By Dante Alighieri (1265-1321) http://www.cummingsstudyguides.net/Guides2/DivineCom.html Original Title . Originally La commedia di Dante Alighieri (The Comedy of Dante Alighieri). In 1555, when a special edition of the poem was published in Venice, admirers of the great work added the word "Divina" ("Divine") to call attention to its greatness. Thus, it became known as La Divina Commedia (The Divine Comedy) and the author's name was dropped from the title. In the original title, "di" ("of") appears to have a double meaning. On the one hand, it means Dante wrote the work. On the other, it means Dante experienced what took place in the work. Study Questions and Short/Long Answer Topics • Why does The Divine Comedy remain one of the world's most popular literary classics, appearing in college curriculums around the world? • To what extent did Dante intend his description of the afterlife to be taken literally? To what extent was it to be taken figuratively or allegorically? • Identify TDC passages/quotes and additional research summarizing TDC as seen through the Forces of Literature perspective: o the effects of prior literature, and influence on future literature o the historical/the cultural/religious context of the day o the author’s personal background . background . beliefs o the author’s worldview and themes Author Information . The author of The Divine Comedy was Dante Alighieri, Italy's greatest poet, who was born to a middle- class family in Florence, Italy, in 1265. After his mother died when he was an adolescent, his father remarried and had two more children, a boy and a girl. -

Dante Alighieri
iir»^^:«y».>i.».. ....««»»««»»»««*«».«»»««»«»»»»»»»»«»«««.......»»» »...........»^, ThE: LIFE OF DmTE I •H or JUL uiiiuii.im... ....... ...,.. -/^ THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES To CA\yylS>ty}K^L^ f^(V2, DANTE ALIGHIERI DANTE ALIGHIERI BY PAGET TOYNBEE WITH TWELVE ILLUSTRATIONS METHUEN & CO. 36 ESSEX STREET W.C LONDON 1902 Second Edition, Revised and Enlarged "the grete poete of Ytaille That highte Dant." Chaucer, Monk''s Tale. p^"^ PREFACE little book lays no claim to originality, THISand makes no pretence to learning or research. It is addressed rather to the so-called general reader than to the serious Dante student. The narrative is taken largely from the pages of Villani, Boccaccio, and from other similar sources. The reader will find fiction (at any rate from the critic's point of view) as well as fact in these pages, but he will, I hope, be at no loss to distinguish between the two. The legends and traditions which hang around the name of a great personality are a not unimportant element in his biography, and may sometimes serve to place him as well as, if not better than, the more sober estimates of the serious historian. I have not, therefore, thought it outside the scope of this sketch of Dante's life to include some of the anecdotes which at an early date began to be associated with his name, though certain of them demonstrably belong to a far eai-lier period. Again, when a thing has been well said by a previous writer, I have been content to let him 2052138 6 PREFACE less well speak, instead of saying the same thing in my own words.