Fiumicino - Roma
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
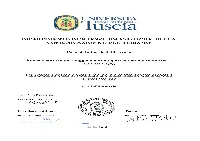
Echiatti Tesid.Pdf
20 05 2 Chi antepone ad ogni altro piacere quello d’un pranzo al “Café de Paris” ed una passeggiata sul “boulevard”, non dovrebbe viaggiare mai. Su tutto avrebbe da ridire. Ovunque andasse, nemmeno in cambio di pochi spiccioli, potrebbe assicurarsi migliori piacevolezze e sentirsi al sicuro da ogni inconveniente. […] è l’ignoranza di questa stessa verità che fa scontenti tanti viaggiatori che mandano volentieri al diavolo il capriccio che li ha stimolati, ad esempio, a venire in Italia. […] I viaggiatori […] vengono da Roma a Corneto per cercare delle attestazioni d’arte che al tempo dei Tarquini avrebbero potuto avere valore archeologico se fin da allora fossero state conosciute. Stendhal 3 RINGRAZIAMENTI Ringrazio quanti mi sono stati d’aiuto fornendomi, insieme alla loro disponibilità, indicazioni utili a reperire il materiale necessario alle mie ricerche: il personale degli archivi e delle biblioteche comunali del viterbese, della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, della Biblioteca di Arte e Archeologia a Roma, dell’Archivio di Stato di Viterbo e tutti coloro che si sono resi disponibili a fornire materiale utile alla ricerca; un ricordo e un grazie particolare al professor Domenico Mantovani che gentilmente mi ha reso partecipe delle sue memorie e della sua personale esperienza letteraria circa la vita e l’opera di George Dennis e della sua traduzione italiana. Ringrazio inoltre il prof. Valerio Viviani per avermi assistito, con scrupolo, attenzione e competenza, durante la preparazione e la stesura di questo lavoro; il prof. Gaetano Platania che per me è stato un esempio e una guida durante questa mia esperienza nel mondo dell’odeporica. -

Map 44 Latium-Campania Compiled by N
Map 44 Latium-Campania Compiled by N. Purcell, 1997 Introduction The landscape of central Italy has not been intrinsically stable. The steep slopes of the mountains have been deforested–several times in many cases–with consequent erosion; frane or avalanches remove large tracts of regolith, and doubly obliterate the archaeological record. In the valley-bottoms active streams have deposited and eroded successive layers of fill, sealing and destroying the evidence of settlement in many relatively favored niches. The more extensive lowlands have also seen substantial depositions of alluvial and colluvial material; the coasts have been exposed to erosion, aggradation and occasional tectonic deformation, or–spectacularly in the Bay of Naples– alternating collapse and re-elevation (“bradyseism”) at a staggeringly rapid pace. Earthquakes everywhere have accelerated the rate of change; vulcanicity in Campania has several times transformed substantial tracts of landscape beyond recognition–and reconstruction (thus no attempt is made here to re-create the contours of any of the sometimes very different forerunners of today’s Mt. Vesuvius). To this instability must be added the effect of intensive and continuous intervention by humanity. Episodes of depopulation in the Italian peninsula have arguably been neither prolonged nor pronounced within the timespan of the map and beyond. Even so, over the centuries the settlement pattern has been more than usually mutable, which has tended to obscure or damage the archaeological record. More archaeological evidence has emerged as modern urbanization spreads; but even more has been destroyed. What is available to the historical cartographer varies in quality from area to area in surprising ways. -

Discovering a Roman Resort-Coat: the Litus Laurentinum and The
DISCOVERING A ROMAN RESORT-COAST: THE LITUS LAURENTINUM AND THE ARCHAEOLOGY OF 1 OTIUM* Nicholas Purcell St John's College, Oxford I. Introductory Otium - the concept of leisure, the elaborate social and cultural definer of the Roman elite away from its business of political and military power - is famous. We can see in Roman literary texts how the practice of otium patterned everyday experience, and how it was expressed in physical terms in the arrangement, on a large and on a small scale, of all aspects of Roman space. The texts likewise show that much of what we would regard as social life, and nearly all of what we think of as economic, belonged in the domain of otium. The complexities and ambiguities of this material have been much studied.2 Roman archaeology equally needs to be an archaeology of otium, but there has been little attempt to think systematically about what that might entail. Investigating the relationship between a social concept such as otium and the material culture that is the primary focus of archaeology must in the first place involve describing Roman culture in very broad terms. The density of explicit or implicit symbolic meaning, the organisation of space and time, degrees of hierarchy of value or prestige: it is at that level of generalisation that the archaeologist and the cultural historian will find the common denominators that enable them to share in the construction of explanations of Roman social phenomena. In this account, which is based on research into a particular locality, we shall have to limit ourselves to one of these possibilities. -

The Cities and Cemeteries of Etruria
Universitäts- und Landesbibliothek Tirol The cities and cemeteries of Etruria Dennis, George 1883 Contents of Volume I urn:nbn:at:at-ubi:2-12107 CONTENTS OF VOLUME I. INTRODUCTION. PAGI Kecent researches into the inner life of the Etruscans —Nature of the docu¬ ments whence our knowledge is acquired —Monumental Chronicles—Object of this work to give facts, not theories—Geographical position and extent of Etruria —Its three grand divisions—Etruria Proper , its boundaries and geological features —The Twelve Cities of the Confederation—Ancient and modern condition of the land—Position of Etruscan cities —Origin of the Etruscan race—Ancient traditions —Theories of Niebuhr , Muller , Lepsius, and others—The Lydian origin probable —Oriental character of the Etrus¬ cans—Analogies in their religion and customs to those of the East —Their language still a mystery —The Etruscan alphabet and numerals —Govern¬ ment of Etruria —Convention of her princes—Lower orders enthralled-1— Religion of Etruria , its effects on her political and social state—Mytho¬ logical system—The Three great Deities—The Twelve Dii Consentes—The shrouded Gods—The Nine thunder -wielding Gods—Other divinities —Fates —Genii—Lares and Lasas—Gods of the lower world—Extent and nature of Etruscan civilization —Literature —Science—Commerce—Physical con¬ veniences—Seweiage—Roads—Tunnels—Luxury —The Etruscans superior to the Greeks in their treatment of woman—Arts of Etruria —Architecture —To be learned chiefly from tombs—Walls of cities—Gates—The arch in Italy worked out by the Etruscans -

Before There Was the Empire, There Was the Republic
Before there was the Empire, there was the Republic. THE RISE OF ROME LECTURE I KINGS, THE FOUNDATION OF ROME LECTURE II THE REPUBLIC, AN INFANT DEMOCRACY LECTURE III THE ROAD TO EMPIRE LECTURE IV POLITICIANS, GENERALS, AND THE MOB LECTURE V CONQUEST AND IMMIGRATION LECTURE VI WHY THE DEMOCRACY FAILED Copyright © 2011 by Dr. William J. Neidinger, Stylus Productions and The Texas Foundation for Archaeological & Historical Research KINGS, THE FOUNDATION OF ROME I. INTRODUCTION - history of the Roman Republic studied by Founding Fathers of the American Revolution, French Revolution, Renaissance Italian city-states - case study in the failure of democracy - Roman Republic as a case study since Polybius (ca. 200- ca. 115 BC) - analysis of Rome’s rise to power - strength of the Roman “constitution” > empire - ancient Roman authors of Empire theorized about what went wrong with Roman Republic 1. historical narrative 2. ever-changing machinery of the democracy of Roman Republic 3. compatibility of democracy and empire 4. changes Roman Republic underwent as Republic conquered, absorbed and was changed by her subjects 5. reasons for the failure of the democracy of the Roman Republic II. ITALY IN THE 8TH CENTURY BC - Italy < Italia < Itali = people inhabiting Cape of Bruttium when Greeks arrived - ever-expanding geographical scope of “Italy” - ca. 1000 BC “invasion” / “migration” of Italic peoples into Italy - Italic peoples settled from Alps to Apulia and Calabria - various Italic peoples distantly related linguistically (IE), culturally, racially -

The Via Aurelia in the Tarquinia Area: New Results from an Aerial
The Via Aurelia in the Tarquinia Area: New Results from an Aerial Photograph Study by the Matlab Image Processing Program Giuliano Pelfer Dipaitimento Scienze dell'Antichità. Università di Firenze. Italy Abstract The object of the present study is to search, on the aerial photograph, for latent traces having archaeological meaning attributable to the context of ancient settlements and roads (Roman Via Aurelia and other roads) in the coastal plain of Tarquinia. For this purposes the techniques from the MATLAB image processing program have been used. The analyzed territory.having archaeological sites previously recognized by traditional photointerpretation (ancient roads, towns, rural villas, harbors, etc.), allows calibration of the methodology of image processing. In fact, image processing ameliorates the visibility of previously recognized traces, and reveals latent traces, not observable on the un treated photo. The results of the search seem to confirm the Pasqui hypothesis of a Roman Via Aurelia on the coastal plain of Tarquinia, pointing in the direction ofGraviscae (Aurelia Vetus) and constructed before the upside straightaway tract (Aurelia Nova). Introduction Graviscae colony, as demonstrated by its castrum structure, The coastal plain of Tarquinia, bordered by the Mignone with its orthogonal centuriations. river to the south and the Marta river to the north, was only a The Tarquinia coastal plain was subjected to environmental small portion of the territory assembled by Tarquinia in the variations and became marshy, perhaps as early as the historical age. It was interest of ancient settlements from the Roman Republican Age. oldest age, and during the historical age, it was under the sphere of influence (political, economical and maritime) of In fact, materials carried back by the two main rivers, along Etruscan Tarquinia. -
The Mixed People of Etruscans
The Mixed People of Etruscans Giampietro Fabbri+× +Eubios Study Centre, Bologna, Italy ×Alma Mater Studiorum, University of Bologna, Italy [email protected] ABSTRACT – In this work the Etruscan people is studied as a confederation of tribes having different origins. Ancient and modern geographical names and historical people names of Italy are analysed in order to distinguish the main Etruscan lienages. Some migration hypotheses are introduced. KEYWORDS – Etruscans, Confederations, Name analysis, Migrations. INTRODUCTION In a recent study1 introducing a new diffusion theory, Etruscans have been presented as a mixed people composed of tribes speaking different languages and descending from two disticnt lineages. The aim of this work is to develop and validate that theory by finding traces of the two lineages in ancient and modern geographical names of Italy. By observing the time and space distributions of ancient Euro-Asian ethnonyms, toponyms, and eponyms, it is possible to distinguish some migration waves departing from Central Asia. Among the migrating peoples, some tribes can be individuated, whose name can be derived from those of two distinct ancestors: *Thyrgwaunas and *Gwaulgwaunas (Fig. 1). According to the cited study, these two lineages were originally opposite and fighting each other, but successively interacted and joined into a confederation of peoples. In the west direction, these peoples started to move in the second half of the III millennium BC and settled around the Aegean area mainly during the period from the great migration of the XIX-XVIII century BC to that of the XIII-XII century. In course of the latter, they were pressed towards Central Europe and whence they spread to the peripheral areas of the continent. -

The Intricacies of Rome's Subjugation and Assimilation of Etruria Master's Thesis Presented to the Faculty of the Graduate S
The Intricacies of Rome’s Subjugation and Assimilation of Etruria Master’s Thesis Presented to The Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences Brandeis University Graduate Program in Ancient Greek and Roman Studies Dr. Cheryl Walker, Advisor In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts in Ancient Greek and Roman Studies by Michael Lundberg February 2020 Copyright by Michael Lundberg © 2020 ABSTRACT The Intricacies of Rome’s Subjugation and Assimilation of Etruria A thesis presented to the Graduate Program in Ancient Greek and Roman Studies Graduate School of Arts and Sciences Brandeis University Waltham, Massachusetts By Michael Lundberg Etruscan history is scant and accounts of their own history essentially nonexistent, resulting in their origins being fiercely debated amongst scholars. Etruscologists’ primary arguments are whether Etruscan culture developed primarily in Italy or Asia Minor. Although historical accounts from Herodotus and Dionysius of Halicarnassus and archaeological evidence primarily from mitochondrial DNA studies have been to used try to establish their origins, nothing definite has been ascertained. Etruria’s fall to the Romans is one of the few definitive facts known about Etruscan history. The means by which they fell, however, are another debate amongst scholars. While the Roman conquest of Etruria is often depicted as a straightforward military annex, it was actually done by means of diplomacy, establishment of colonies, military strategy, and the thorough implementation of Roman administration. Rome was able to siege and sack the Etruscan city of Veii with minimal assistance from other Etruscan city-states, taking advantage of the ire of other Etruscan cities felt towards Veii because of Veii’s appointment of a king. -

Contributi Per La Storia Di Brindisi
CONTRIBUTI PER LA STORIA DI BRINDISI Giacomo Carito www.hdlibrary.it 2 3 2 3 4 5 Comitato promotore e organizzativo Società di Storia Patria per la Puglia Sezione di Brindisi Scritto da Giacomo Carito Copyright © 2019 Tutti i diritti riservati History Digital Library - Brindisi Finito di stampare nel mese di settembre 2019 da History Digital Library - APS Vola Alto ETS Vola Alto 4 5 CONTRIBUTI PER LA STORIA DI BRINDISI Giacomo Carito INDICE 7 Un brindisino alla corte di perseo di macedonia: Lucio Ramnio 11 Tra Roma e Gerusalemme Brindisi e i porti pugliesi negli itinerari medievali di pellegrinaggio 11 Brindisi nell’età di Carlo III 11 Itinerari ebraici fra XIX e XX secolo. Attraverso Brindisi verso una nuova speranza 8 Giacomo Carito Un brindisino alla corte di perseo di macedonia: Lucio Ramnio 9 Giacomo Carito Un brindisino alla corte di Perseo di Macedonia: Lucio Ramnio "Id quod nostri caelum memorant, Grai perhibent aethera" A ciò che i nostri chiamano cielo, i greci danno il nome di etere (Marco Pacuvio, Chryses)1 Rilevò Pilar Jiménez Gazapo: “Pacuvio (220-130) es el mejor de los trágicos si valoramos la opinión de Cicerón. Emparentado quizás con Ennio y originario de Brindisi, cultivó en Roma la amistad de Lelio y posiblemente tuvo contactos de maestro a discípulo con el joven Accio en los comienzos de su pioducción literaria. Unos quinientos versos escasos quedan de su corta producción: doce fabulae palliatae y una praetexta, a cuya composición dedicó toda su vida. Eurípides, Esquilo, Sófocles y autores posteriores fueron recogidos en obras como: Antiopa, Armorum iudicium, Dulorestes, Niptra. -

Storia Dell'agricoltura Italiana
Georgofili Accademia dei Georgofili Accademia dei Georgofili STORIA DELL’AGRICOLTURA ITALIANA I** Elenco degli autori STORIA DELL’AGRICOLTURA STORIA Gaetano Forni DELL’AGRICOLTURA Paolo Giulierini ITALIANA ITALIANA Elio Lo Cascio Arnaldo Marcone Massimo Nafissi L’ETÀ ANTICA Su iniziativa della Marinella Pasquinucci «Rivista di storia dell’agricoltura» Antonio Saltini Giusto Traina Comitato scientifico dell’opera Giovanni Cherubini Presidente Reginaldo Cianferoni Zeffiro Ciuffoletti Gaetano Forni Arnaldo Marcone Giuliano Pinto Carlo Poni Leonardo Rombai Franco Scaramuzzi Ugo Tucci Paolo Nanni Coordinatore Italia romana L’ETÀ ANTICA 2 L’ETÀ ISBN 978-88-596-0764-9 In copertina: I lavori campestri (part.) € 40,00 Edizioni Polistampa Cherchell, Musée Archéologique, III sec. Accademia dei Georgofili STORIA DELL’AGRICOLTURA ITALIANA I L’ETÀ ANTICA 2. ITALIA ROMANA a cura di Gaetano Forni e Arnaldo Marcone Edizioni Polistampa Comitato scientifico dell’opera Giovanni Cherubini (Presidente) - Reginaldo Cianferoni Zeffiro Ciuffoletti - Gaetano Forni - Arnaldo Marcone Giuliano Pinto - Carlo Poni - Leonardo Rombai - Franco Scaramuzzi Ugo Tucci - Paolo Nanni (Coordinatore) FIRENZE, 2001 - 2002 Con il contributo di © 2002 EDIZIONI POLISTAMPA Sede legale: Via Santa Maria, 27/r - 50125 Firenze Tel. 055.233.7702 - Fax 055.229.430 Stabilimento: Via Livorno, 8/31 - 50142 Firenze Tel. 055.7326.272 - Fax 055.7377.428 http: www.polistampa.com ISBN 978-88-596-0764-9 INDICE L’ETÀ ANTICA - ITALIA ROMANA ARNALDO MARCONE Introduzione ........................................................... 11 ARNALDO MARCONE Popolazione, popolamento, sistemi colturali, spazi coltivati, aree boschive ed incolte .............................................................. 17 L’età arcaica .......................................................... 17 Dalla conquista dell’Italia all’egemonia mediterranea ....................... 32 La crisi del III secolo e l’età tardoantica ................................... 53 GAETANO FORNI Colture, lavori, tecniche, rendimenti ................................... -
Direzione Generale I Comuni Costieri Dell'hinterland Romano: Aspetti
Direzione Generale Ufficio Studi, Ricerche e Statistica I comuni costieri dell’hinterland romano: aspetti demografici ed economici Coordinamento progetto di Aldo Santori e Teresa Ammendola. Elaborazioni e testo di Marianna Giordano Società e territorio N°18 - Settembre 2007 Provincia di Roma - I Working Paper dell’Ufficio Studi - n°18 – Giugno 2007 INDICE Introduzione pag. 2 1. I comuni costieri pag. 2 2. Il profilo storico pag. 3 3. La popolazione pag. 9 3.1. Il movimento naturale pag. 12 3.2. La popolazione straniera pag. 23 4. Le dinamiche economiche e sociali del litorale romano pag. 31 4.1. Il mercato immobiliare pag. 31 4.2. La struttura del reddito e dei consumi pag. 37 4.3. Il sistema delle imprese. Gli addetti pag. 43 4.4. Il turismo nel litorale romano pag. 54 4.5. Infrastrutture e mobilità pag. 57 Riferimenti bibliografici e banche dati pag. 63 Indice delle tabelle pag. 64 Indice dei grafici pag. 65 Provincia di Roma - I Working Paper dell’Ufficio Studi - n°18 – Giugno 2007 Introduzione L’obiettivo di questo lavoro è quello di fornire i dati essenziali sulla rilevan- za socio-economica dei comuni del litorale romano. Il documento va letto come una sintesi ragionata degli indicatori del territorio costiero che ha da sempre rappresenta- to una area particolarmente attiva sotto il profilo demografico ed estremamente di- namica sotto il profilo economico. Infatti negli ultimi anni questa porzione di territo- rio ha attratto la localizzazione di quote crescenti di imprese e investitori che inten- devano sfruttare le economie di sistema che si possono sviluppare nei territori litora- nei. -

The Sanctuary at Grasceta Dei Cavallari As a Case-Study of the E-L-C Votive Tradition in Republican Italy
Actors and Agents in Ritual Behavior: The Sanctuary at Grasceta dei Cavallari as a Case-Study of the E-L-C Votive Tradition in Republican Italy by Kevin D‘Arcy Dicus A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Classical Art and Archaeology) in The University of Michigan 2012 Doctoral Committee: Professor Nicola Terrenato, Chair Professor Elaine K. Gazda Professor Carla M. Sinopoli Professor Janet E. Richards © Kevin D‘Arcy Dicus 2012 Alla gente di Tolfa e ai miei genitori che potrebbero essere bravi tolfetani ii Acknowledgements The acknowledgements are conventionally the final addendum to the dissertation. These opening lines signal the closure of the magnum opus which has been defended, revised, formatted; it is primed for its formal inclusion in the high society of academic discourse, as if being presented at the dissertation debutante ball. The passage to this ultimate stage, from the incipient twinkle in the author‘s cerebral cortex, is littered with the corpses of euthanized chapters and passages, made blurry by sleepless nights and paludal from sweat and tears. All of the struggles make the conclusion of the labor that much more rewarding. The acknowledgments allow for what William Wordsworth called ―emotion recollected in tranquility.‖ I would not consider tranquility to be a defining characteristic of the dissertation process. Its completion, however, has allowed me to find some refuge in this unfamiliar state where I am able to reflect back on the past years and recollect not only the struggles but also the people and experiences that made this project the most valuable and memorable time of my life.