Relazione Preliminare Al Piano Del Parco
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Piano Di Previsione, Prevenzione E Lotta Attiva Contro Gli Incendi Boschivi Per Le Riserve Naturali Statali 2012 -2016
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali CORPO FORESTALE DELLO STATO UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITA’ DI POTENZA PIANO DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI PER LE RISERVE NATURALI STATALI 2012 -2016 RISERVA NATURALE ORIENTATA GROTTICELLE (PZ) D.M. 11.09.1971 RISERVE NATURALI ANTROPOLOGICHE AGROMONTE SPACCIABOSCHI COSTE CASTELLO I PISCONI (PZ) D.M. 29.03.1972 RISERVA NATURALE ANTROPOLOGICA MONTE CROCCIA (MT) D.M. 11.09.1971 RISERVA FORESTALE DI PROTEZIONE METAPONTO (MT) D.M. 29.03.1972 IL CAPO DELL’UFFICIO -V.Q.A.F. Angela MALASPINA- Redatto da Op. LUCIA Vito Donato V.Q.A.F. MALASPINA Angela TABELLA DI SINTESI 1. ELEMENTI GENERALI: NORMATIVI, TEMPORALI, INFORMATIVI. 1.1. Riferimento normativi statali. 1.2 Estremi delle vigenti leggi regionali di diretto interesse per l’A.I.B. 1.3 Estremi del Piano AIB regionale e di eventuali accordi fra enti interessati all’AIB 1.4. Referenti A.I.B. 1.5. Estremi di Articoli di Decreti, Piani, Regolamenti, etc. pertinenti il territorio della Riserva Naturale Statale che interessano la gestione AIB del territorio protetto e limitrofo. 1.6. Elenco di eventuali siti web per l’A.I.B. dell’area protetta. 2. PIANIFICAZIONE E PREVENZIONE (DESCRIZIONE DEL TERRITORIO – BANCHE DATI TERRITORIALI – CARTOGRAFIA DI BASE E TEMATICA – OBIETTIVI PRIORITARI). 2.1. Descrizione del territorio: aspetti geomorfologici, topografici, idrografici, vegetazionali, climatici, storici e socioeconomici. 2.1.1 RISERVA NATURALE ORIENTATA GROTTICELLE 2.1.2 RISERVA NATURALE ANTROPOLOGICA AGROMONTE SPACCIABOSCHI 2.1.3 RISERVA NATURALE ANTROPOLOGICA COSTE CASTELLO 2.1.4 RISERVA NATURALE ANTROPOLOGICA I PISCONI 2.1.5 RISERVA NATURALE ANTROPOLOGICA MONTE CROCCIA 2.1.6. -

Scarica Il Documento
OGGETTO PROGETTO EOLICO “Melfi – Sant’Alessandro“ COMUNE MELFI (PZ) COMMITTENTE Via Trento, 64, 20871 - Vimercate (MB) WINDERG S.r.l. Tel. 039.60.26.270, Fax. 039.60.26.222 RESPONSABILE Ing. A. Bartolazzi PROGETTISTA Ing. A. Bartolazzi TAVOLA DESCRIZIONE A.17 Studio di Impatto Ambientale DATA 13.10.2010 TIMBRO E FIRMA REVISIONE B FORMATO A4 SCALA - DISEGNO MLF-SIA INDICE 1. INTRODUZIONE ............................................................................................... 5 1.1. Presentazione del progetto ............................................................................................................................ 5 1.2. Inquadramento normativo ............................................................................................................................ 6 1.2.1. Normativa nazionale di riferimento per la produzione di energia ................................................................. 6 1.2.2. Normativa sulla Valutazione d'Impatto Ambientale ..................................................................................... 7 2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO ....................................................... 9 2.1. Programmazione energetico-Ambientale a livello comunitario ................................................................. 9 2.2. Programmazione energetico-Ambientale a livello Nazionale ................................................................... 10 2.3. Normativa regionale, provinciale, comunale ............................................................................................ -

Valutazione Ambientale Del Piano Di Sviluppo 2009
Valutazione Ambientale del Piano di Sviluppo 2009 Rapporto Ambientale Volume REGIONE BASILICATA Rapporto Ambientale del PdS 2009 Regione Basilicata Pag. 1 INDICE 1 MODALITÀ DI COLLABORAZIONE ATTIVATE PER LA VAS ................................................................ 3 2 CONTESTO E POLITICHE......................................................................................................................... 4 2.1 INTRODUZIONE....................................................................................................................................... 4 2.1.1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE .................................................................................................................. 4 2.1.2 CARATTERIZZAZIONE GEOGRAFICA ............................................................................................................ 5 2.2 TERRITORIO............................................................................................................................................ 7 2.2.1 POPOLAZIONE .......................................................................................................................................... 7 2.2.2 USO DEL SUOLO ....................................................................................................................................... 7 2.3 AMBIENTE E PAESAGGIO ..................................................................................................................... 9 2.3.1 BIODIVERSITÀ ED AREE PROTETTE............................................................................................................ -
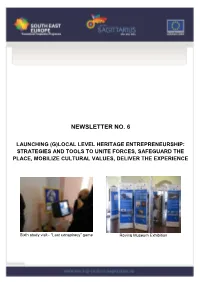
Newsletter No. 6
NEWSLETTER NO. 6 LAUNCHING (G)LOCAL LEVEL HERITAGE ENTREPRENEURSHIP: STRATEGIES AND TOOLS TO UNITE FORCES, SAFEGUARD THE PLACE, MOBILIZE CULTURAL VALUES, DELIVER THE EXPERIENCE Sixth study visit– “Last conspiracy” game Roving Museum Exhibition This is the sixth and also the last number of Sagittarius Newsletter. The project will finish at the end of May 2014. This means the conclusion of all project partners’ activities. In the latest newsletter we would like to present you the most important results that partners from 8 countries of South Eastern Europe have prepared and achieved in the three-year of implementation period of the Sagittarius project. 1. FIFTH TRANSNATIONAL PROJECT MEETING AND SIXTH STUDY VISIT IN PTUJ Sagittarius project partners have meet the fifth time in Slovenia on 4th and 5th of November 2013. The host of the project meeting was E-institution Ptuj and it took place in Grand Hotel Primus in Ptuj. 1.1 Fifth Transnational Project Partners Meeting (Ptuj) The representatives of all project partners came to the project meeting, and together we were 30 participants. All present were welcomed by Darko Ferčej the director of E- Institute Ptuj. Then the official program of the meeting started. We discussed several topics, as the project moved into the final implementation phase, where all project partners should demonstrate their partial project results and integrate them into common project outputs. First, we examine the so far results and physical indicators of the project. The review and discussion was moderated by the project manager Dorothea Papathanasiou - Zuhrt. The focal point of the discussion was Roving museum. -

S Italy Is a Contracting Party to All of the International Conventions a Threat to Some Wetland Ibas (Figure 3)
Important Bird Areas in Europe – Italy ■ ITALY FABIO CASALE, UMBERTO GALLO-ORSI AND VINCENZO RIZZI Gargano National Park (IBA 129), a mountainous promontory along the Adriatic coast important for breeding raptors and some open- country species. (PHOTO: ALBERTO NARDI/NHPA) GENERAL INTRODUCTION abandonment in marginal areas in recent years (ISTAT 1991). In the lowlands, agriculture is very intensive and devoted mainly to Italy covers a land area of 301,302 km² (including the large islands arable monoculture (maize, wheat and rice being the three major of Sicily and Sardinia), and in 1991 had a population of 56.7 million, crops), while in the hills and mountains traditional, and less resulting in an average density of c.188 persons per km² (ISTAT intensive agriculture is still practised although land abandonment 1991). Plains cover 23% of the country and are mainly concentrated is spreading. in the north (Po valley), along the coasts, and in the Puglia region, A total of 192 Important Bird Areas (IBAs) are listed in the while mountains and hilly areas cover 35% and 41% of the land present inventory (Table 1, Map 1), covering a total area of respectively. 46,270 km², equivalent to c.15% of the national land area. This The climate varies considerably with latitude. In the south it is compares with 140 IBAs identified in Italy in the previous pan- warm temperate, with almost no rain in summer, but the north is European IBA inventory (Grimmett and Jones 1989; LIPU 1992), cool temperate, often experiencing snow and freezing temperatures covering some 35,100 km². -

Sentiero Del Ventennale (Parziale) Dal Quadrivio Al Monte Volturino
Club Alpino Italiano Domenica 21 giugno 2020 Appennino lucano Sentiero del Ventennale (parziale) Dal Quadrivio al Monte Volturino Vincenzo Telesca (388 1641 435), Vincenzo De Palma (320 4777 910), Antonpiero Russo (333 1163 061) Iscrizione Comunicare le adesioni a Vincenzo Telesca con messaggio telef. Se le condizioni metereologiche lo permetteranno, i responsabili saranno anche davanti la sede dalle ore 19.30 alle 20.30 di venerdì 19 giugno per fornire ogni ulteriore chiarimento e prendere le adesioni. o di partecipanti, con precedenza ai Soci. modulo e la relativa informativa sono scaricabili dal sito della Sezione al link: http://www.caipotenza.it/documenti-e-regolamenti/iscrizioni Quota di partecipazione Soci CAI: 2.00 - N 8.00 Pe La località di partenza sarà raggiunta con auto proprie, con non più di un passeggero a bordo, oltre autista. Equipaggi più numerosi solo per componenti dello stesso nucleo familiare. Appuntamento e partenza Appuntamento ore 6.30 nel parcheggio antistante la Stazione ferroviaria FAL Potenza Inferiore (tra il passaggio a livello e il ponte Musmeci). Partenza ore 6.45. Partendo da Potenza imboccare la SP 5 della Sellata, dopo cirva 27 km, alla fine della C/da Pierfaone, svoltare a sinistra e imboccare la SP/16 Marsicana in direzione Marsicovetere e procedere escursione, fino all area parcheggio. Caratteristiche te Andata e ritorno, con brevi variazioni Lunghezza ca. 10 km Dislivello in salita ca. 750 m Tempo percorrenza ca. 4,00 h (escluse le soste) Difficoltà E per Escursionisti, di media difficoltà). Il percorso non presenta passaggi esposti, ma prevede alcuni tratti su pietra e roccia su ripidi pendii. -

Lista Beneficiari PO-FESR 2007-2013
01-GEN-07 14-FEB-18 LISTA BENEFICIARI PO FESR BASILICATA 20072013 PERIODO: 01-GEN-07 al 14-FEB-18 Nome dei beneficiari OPERAZIONE FONDI PUBBLICI ASSEGNATI / PAGATI AL BENEFICIARIO Progetto Titolo progetto Asse Linea di Tipo Anno di Anno di Ammontare Totale importo intervento Operaz. assegnazione pagamento Assegnato pagato alla fine finanaziamento finale dell'operazione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 19/2015/23 SP EX SS 175 LAVORI I I.1.1.A OO.PP. 2015 2016 360.000,00 322.796,97 DI MATERA COMPLEMENTARI DI SALVAGUARDIA DEL CORPO STRADALE E DI REGIMENTAZIONE DEL FOSSO PERITO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 76/2008/26 Adeguamento SP ex SS 175 (Innesto ex I I.1.1.A OO.PP. 2008 2016 6.561.067,10 4.462.252,55 DI MATERA SS 380-SS 106 Jonica): Progetto per la realizzazione di svincoli e complanari - I stralcio - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 76/2008/27 Lavori di adeguamento della S.P. ex S.S. I I.1.1.A OO.PP. 2008 2017 3.350.000,00 1.973.036,57 DI MATERA 175 - Innesto ex SS 380 - SS 106 Jonica. Progetto per lo spostamento delle condotte irrigue - 4° stralcio funzionale - Tratto compreso tra il Bivio di Bernalda e la SS Jonica AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 76/2009/1 Adeguamento SP ex SS 175 (Innesto ex I I.1.1.A OO.PP. 2009 2017 26.271.553,25 25.273.553,25 DI MATERA SS 380 - SS 106 Jonica). AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 76/2009/6 STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA I I.1.1.A OO.PP. 2009 2016 12.500.000,00 9.499.272,92 DI POTENZA S.S.V. -
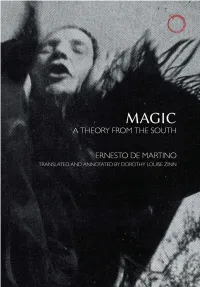
Magic: a Theory from the South
MAGIC Hau BOOKS Executive Editor Giovanni da Col Managing Editor Sean M. Dowdy Editorial Board Anne-Christine Taylor Carlos Fausto Danilyn Rutherford Ilana Gershon Jason Throop Joel Robbins Jonathan Parry Michael Lempert Stephan Palmié www.haubooks.com Magic A THEORY FROM THE SOUTH Ernesto de Martino Translated and Annotated by Dorothy Louise Zinn Hau Books Chicago © 2001 Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano (First Edition, 1959). English translation © 2015 Hau Books and Dorothy Louise Zinn. All rights reserved. Cover and layout design: Sheehan Moore Typesetting: Prepress Plus (www.prepressplus.in) ISBN: 978-0-9905050-9-9 LCCN: 2014953636 Hau Books Chicago Distribution Center 11030 S. Langley Chicago, IL 60628 www.haubooks.com Hau Books is marketed and distributed by The University of Chicago Press. www.press.uchicago.edu Printed in the United States of America on acid-free paper. Contents Translator’s Note vii Preface xi PART ONE: LUcanian Magic 1. Binding 3 2. Binding and eros 9 3. The magical representation of illness 15 4. Childhood and binding 29 5. Binding and mother’s milk 43 6. Storms 51 7. Magical life in Albano 55 PART TWO: Magic, CATHOliciSM, AND HIGH CUltUre 8. The crisis of presence and magical protection 85 9. The horizon of the crisis 97 vi MAGIC: A THEORY FROM THE SOUTH 10. De-historifying the negative 103 11. Lucanian magic and magic in general 109 12. Lucanian magic and Southern Italian Catholicism 119 13. Magic and the Neapolitan Enlightenment: The phenomenon of jettatura 133 14. Romantic sensibility, Protestant polemic, and jettatura 161 15. The Kingdom of Naples and jettatura 175 Epilogue 185 Appendix: On Apulian tarantism 189 References 195 Index 201 Translator’s Note Magic: A theory from the South is the second work in Ernesto de Martino’s great “Southern trilogy” of ethnographic monographs, and following my previous translation of The land of remorse ([1961] 2005), I am pleased to make it available in an English edition. -

Piano Del Parco
PARCO REGIONALE GALLIPOLI COGNATO PICCOLE DOLOMITI LUCANE PIANO DEL PARCO 2 Coordinatore gruppo di lavoro: Arch. Vincenzo FOGLIANO Consulente ambientale: Geol. Tommaso SANTOCHIRICO Responsabile del Procedimento: Dr. Marco DELORENZO Piano del Parco | 1 REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI 1 OSSERVAZIONI A seguito della attivazione della procedura di VAS per l’approvazione del Piano del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane istituito ai sensi della L.R. 47 del 24 novembre 1997., si è provveduto all’inoltro della documentazione di piano alle seguenti autorità: REGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO AMBIENTE, T.P. S. Ufficio Ciclo dell’Acqua Via Vincenzo Verrastro, 5 – 85100 Potenza (PZ) REGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO AMBIENTE, T.P. S. Ufficio Foreste e Tutela del Territorio Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza (PZ) REGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO AMBIENTE, T.P. S. Ufficio Geologico e Attività Estrattive Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza (PZ) REGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO AMBIENTE, T.P. S. Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza (PZ) REGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO AMBIENTE, T.P. S. Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza (PZ) REGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, S. R. E. M. Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio Rurale Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 Potenza (PZ) REGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, S. R. E. M. Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni Via Vincenzo Verrastro, 10 85100 Potenza (PZ) REGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, O.P. e M. – Ufficio Difesa del suolo C.So Garibaldi, 139 - 85100 Potenza (Pz) Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane Piano del Parco | 2 REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI REGIONE BASILICATA – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, O.P. -

Studio Di Incidenza - Allegati 1
ALLEGATO A - SCHEDE DEI SITI NATURA 2000 Il sito natura2000.eea.europa.eu riporta tutte le informazioni più aggiornate relative ai siti della Rete Natura a livello europeo. Nelle seguenti tabelle vengono riepilogate le informazioni più importanti relative ai siti della Basilicata, associati ai relativi codici di identificazione e ad una lettera che ne qualifica la tipologia: ZPS (A), SIC (B) e compresenza di SIC e ZPS (C). L’asterisco indica che il SIC è stato designato come ZSC. Codice Tipo Nome IT9210005 B* Abetina di Laurenzana IT9210010 B* Abetina di Ruoti IT9210015 B Acquafredda di Maratea IT9210020 C* Bosco Cupolicchio IT9210025 B Bosco della Farneta IT9210035 B* Bosco di Rifreddo IT9210040 B Bosco Magnano IT9210045 B* Bosco Mangarrone (Rivello) IT9210070 B Bosco Vaccarizzo IT9210075 B Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di S.Francesco IT9210105 C* Dolomiti di Pietrapertosa IT9210110 B* Faggeta di Moliterno IT9210115 B* Faggeta di Monte Pierfaone IT9210120 B La Falconara IT9210125 B Timpa dell'Orso-Serra del Prete IT9210130 B Bosco di Chiaromonte-Piano Iannace IT9210135 B Piano delle Mandre IT9210140 B* Grotticelle di Monticchio IT9210141 B* Lago La Rotonda IT9210142 C* Lago Pantano di Pignola IT9210143 B Lago Pertusillo IT9210145 B Madonna del Pollino Località Vacuarro IT9210146 B Pozze di Serra Scorzillo IT9210150 C Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive IT9210155 B Marina di Castrocucco IT9210160 B Isola di S. Ianni e Costa Prospiciente IT9210165 B Monte Alpi - Malboschetto di Latronico IT9210170 B Monte Caldarosa IT9210175 B Valle Nera-Serra di Lagoforano IT9210180 B Monte della Madonna di Viggiano IT9210185 B Monte La Spina, Monte Zaccana IT9210190 C* Monte Paratiello Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) STUDIO DI INCIDENZA - ALLEGATI 1 IT9210195 B Monte Raparo IT9210200 B Monte Sirino IT9210201 C Lago del Rendina IT9210205 B Monte Volturino IT9210210 C* Monte Vulture IT9210215 B* Monte Li Foi IT9210220 B* Murge di S. -

A Bespoke Tour for Explorers of Beauty BASILICATA BASILICA Pollino National Park
POLLINO NATIONAL PARK Itineraries and enchantment in the secret places of a land to be discovered A bespoke tour for explorers of beauty BASILICATA BASILICA Pollino National Park Credits ©2019 Agenzia di Promozione Territoriale BASILICATA Via del Gallitello, 89 - 85100 POTENZA Concept and Design Vincenzo Petraglia Editorial planning and direction Maria Teresa Lotito Graphic design and layout Vincenzo Petraglia in partnership with Xela Art Image search and selection Maria Teresa Lotito English translation of the Italian original Global Voices - Milano Photographs Basilicata Tourist Board Archive Basilicata Archaeological Heritage Department Archive Printed by Alfagrafica Volonnio - Lavello (PZ) Thanks to: The Basilicata Archaeological Heritage Department, all the Municipalities, Associations, and Pro Loco organisations which provided the photographic material. Distributed free of charge The Tourist Board has published the information in this booklet for information purposes only. The utmost care has been taken in checking the information provided in this booklet. Printing errors or involuntary omissions excluded. 3 BASILICATA BASILICAPOLLINO Pollino National Park MATERA POTENZA da non perdere anche... NOEPOLI LATRONICO CASTELSARACENO CALVERA CARBONE TEANA the itinerary FARDELLA EPISCOPIA CASTRONUOVO S.ANDREA CHIAROMONTE CERSOSINO FRANCAVILLA IN SINNI SAN GIORGIO LUCANO S.COSTANTINO Start E S.PAOLO ALBANESE CASTELLUCCIO S.SEVERINO INF. E SUP. VIGGIANELLO ROTONDA TERRANOVA DI POLLINO 4 BASILICATA Pollino National Park BASILICA The Lucan Olympus Pollino is a giant from all points of view. On account of the massif after which it is named, it being the tallest in the region, the fact that it is Italy's largest national park, and because it being home to a true botanical rarity, the centuries-old Bosnian Pine. -

Rivista Di Storia E Storie Dell'emigrazione
CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA 29 | 2017 RIVISTA DI STORIARIVISTA ESTORIE DELL’EMIGRAZIONE 31/32 | 2018 SOMMARIO archivio ufficio stampa Consiglio regionale della Basilicata Foto di Maria Teresa Quinto, Teresa Foto di Maria 2 PRIMO PIANO | 126 SCAFFALE | # IdentItalia, lucani per scelta Marcella Continanza in viaggio con la Sibilla a cura di: Alessandra Dagostini Loredana Costanza, Rosaria Nella, Raffaella Bisceglia, Domenico Torriello Lucani insigni 2017 132 PAROLANDO | 4 a cura di: Il mondo dei bambini tra bavaglinë Eva Bonitatibus, Angela Di Maggio, e camësèdda Roberta Nardacchione, Gina Tancredi Patrizia Del Puente Annaemilia Colucci, Rosanna Santagata Sara Lorusso, Francesco Caputo 138 SAGGIO | Miseria, violenza ed emigrazione 60 REPORTAGE | 5 Cristoforo Magistro Soc. M. S. San Rocco-Montescaglioso, 90 anni di storia 144 RITRATTO | a cura di: Vincenzo Marinelli Maria Andriulli Angela Castronuovo 80 PERISCOPIO | 150 PERCORSI D’ARTE | % Festival della Divulgazione Scultura tra enigma e concettualità a cura di: Piero Ragone Pierluigi Argoneto, Pietro Greco, Giuliana De Donno, Vania Cauzillo, Alessia Colaianni, l’arpa la mia migliore amica Guido Masiello, Cristina Da Rold, Margherita Romaniello Francesco Mastrorizzi, Mara Salvatore 120 RACCONTO | Vito Marcantonio, i diritti civili come faro di una straordinaria vita politica Saverio Romeo 1 Loredana Costanza Foto di Marco Fasanella, Giuseppe Lavano e storie familiari con le quali noi tutti ci siamo, a vario titolo, confrontati ci insegnano che negli anni del dopoguerra a emigrare erano incoscienti e “Lspauriti padri di famiglia che, in possesso di null’altro che della buona volontà e della forza delle propria braccia, riempivano la misera valigia di cartone dei sogni di una vita migliore per sé e per i propri cari.