Quaderni 2007-V
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
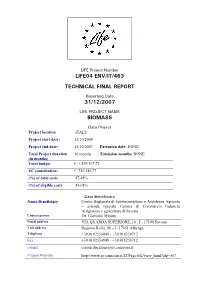
Technical Interim / Final Report Life-Environment 2005
LIFE Project Number LIFE04 ENV/IT/463 TECHNICAL FINAL REPORT Reporting Date 31/12/2007 LIFE PROJECT NAME BIOMASS Data Project Project location ITALY Project start date: 15/10/2004 Project end date: 15/10/2007 Extension date: NONE Total Project duration 36 months Extension months: NONE (in months) Total budget € 1.529.367,73 EC contribution: € 726.146,73 (%) of total costs 47,48% (%) of eligible costs 49,68% Data Beneficiary Name Beneficiary Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola – azienda speciale Camera di Commercio Industria Artigianato e agricoltura di Savona Contact person Dr. Giovanni Minuto Postal address VIA QUARDA SUPERIORE, 16 , I - 17100 Savona Visit address Regione Rollo, 98 – I -17031 Albenga Telephone +39.0182554949 - +39.018250712 Fax: +39.0182554949 - +39.018250712 e-mail [email protected] Project Website http://www.sv.camcom.it/IT/Page/t02/view_html?idp=567 1. LIST OF CONTENTS 1. LIST OF CONTENT 2 2. LIST (I) KEY-WORDS AND (II) ABBREVIATIONS 3 3. EXECUTIVE SUMMARY 4 4. INTRODUCTION 6 5. LIFE-PROJECT FRAMEWORK 7 6. TECHNOLOGY 9 7. PROGRESS, RESULTS 12 Task 1 – management 12 Task 2 – sensibilizzazione e coinvolgimento 13 Task 3 - iniziative dimostrative per la riduzione dei rifiuti in 15 agricoltura e nel turismo Task 4 - creazione e funzionamento dello “sportello regionale 19 del biologico” – rete di servizi Task 5 – divulgazione 23 8. DISSEMINATION ACTIVITIES AND DELIVERABLES 26 8.1. Pubblicazioni 26 8.2. Passaggi televisivi 27 8.3. Corsi di formazione diretti ad operatori del settore 27 agricolo 8.4. Partecipazione a convegni e workshop in ambito locale, 27 nazionale ed internazionale 8.5. -

(US) 38E.85. a 38E SEE", A
USOO957398OB2 (12) United States Patent (10) Patent No.: US 9,573,980 B2 Thompson et al. (45) Date of Patent: Feb. 21, 2017 (54) FUSION PROTEINS AND METHODS FOR 7.919,678 B2 4/2011 Mironov STIMULATING PLANT GROWTH, 88: R: g: Ei. al. 1 PROTECTING PLANTS FROM PATHOGENS, 3:42: ... g3 is et al. A61K 39.00 AND MMOBILIZING BACILLUS SPORES 2003/0228679 A1 12.2003 Smith et al." ON PLANT ROOTS 2004/OO77090 A1 4/2004 Short 2010/0205690 A1 8/2010 Blä sing et al. (71) Applicant: Spogen Biotech Inc., Columbia, MO 2010/0233.124 Al 9, 2010 Stewart et al. (US) 38E.85. A 38E SEE",teWart et aal. (72) Inventors: Brian Thompson, Columbia, MO (US); 5,3542011/0321197 AllA. '55.12/2011 SE",Schön et al.i. Katie Thompson, Columbia, MO (US) 2012fO259101 A1 10, 2012 Tan et al. 2012fO266327 A1 10, 2012 Sanz Molinero et al. (73) Assignee: Spogen Biotech Inc., Columbia, MO 2014/0259225 A1 9, 2014 Frank et al. US (US) FOREIGN PATENT DOCUMENTS (*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this CA 2146822 A1 10, 1995 patent is extended or adjusted under 35 EP O 792 363 B1 12/2003 U.S.C. 154(b) by 0 days. EP 1590466 B1 9, 2010 EP 2069504 B1 6, 2015 (21) Appl. No.: 14/213,525 WO O2/OO232 A2 1/2002 WO O306684.6 A1 8, 2003 1-1. WO 2005/028654 A1 3/2005 (22) Filed: Mar. 14, 2014 WO 2006/O12366 A2 2/2006 O O WO 2007/078127 A1 7/2007 (65) Prior Publication Data WO 2007/086898 A2 8, 2007 WO 2009037329 A2 3, 2009 US 2014/0274707 A1 Sep. -

A Catalogue of the Vespidae of the Malagasy Subregion (Insecta, Hymenoptera)
© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at Linzer biol. Beitr. 41/2 1871-1935 18.12.2009 A Catalogue of the Vespidae of the Malagasy Subregion (Insecta, Hymenoptera) 1 J.M. CARPENTER & M. MADL A b s t r a c t : We record 120 species and four subspecies of the family Vespidae from the Malagasy Subregion. The subfamily Eumeninae is represented by 44 species and four subspecies in 21 genera and the subfamily Polistinae by 67 species in three genera. The generic position of nine species is still unknown. New records for the islands of the southwest Indian Ocean are provided. Odynerus farquharensis CAMERON 1907 is transferred to the genus Knemodynerus BLÜTHGEN 1940 and Epiodynerus grandidieri limbatulus GIORDANI SOIKA 1991 to the genus Anterhynchium de SAUSSURE 1863, new combinations. K e y w o r d s : Vespidae, Malagasy Subregion, catalogue, taxonomy, new records. Introduction The Malagasy Subregion consists of a number of islands of quite different origins. Madagascar and the Seychelles (Inner Seychelles) are continental, while other islands are oceanic islands of volcanic (Comoros, Mayotte, Réunion, Mauritius, Rodrigues) or coralline origin (e. g. Aldabra, Amirantes, Agalega). These islands moreover show a greater range of ages than most other island regions. This diversity of islands, and the complex effects of land separation, emergence and habitat isolation, is responsible for an extraordinary biodiversity in the region, which is both largely endemic and highly threatened (habitat loss, invasive species). Inventory of the biota is an urgent priority, but is hampered by the scattered literature in many taxa. The wasp family Vespidae exemplifies these points. -

1 Ornamental Palms
1 Ornamental Palms: Biology and Horticulture T.K. Broschat and M.L. Elliott Fort Lauderdale Research and Education Center University of Florida, Davie, FL 33314, USA D.R. Hodel University of California Cooperative Extension Alhambra, CA 91801, USA ABSTRACT Ornamental palms are important components of tropical, subtropical, and even warm temperate climate landscapes. In colder climates, they are important interiorscape plants and are often a focal point in malls, businesses, and other public areas. As arborescent monocots, palms have a unique morphology and this greatly influences their cultural requirements. Ornamental palms are over- whelmingly seed propagated, with seeds of most species germinating slowly and being intolerant of prolonged storage or cold temperatures. They generally do not have dormancy requirements, but do require high temperatures (30–35°C) for optimum germination. Palms are usually grown in containers prior to trans- planting into a field nursery or landscape. Because of their adventitious root system, large field-grown specimen palms can easily be transplanted. In the landscape, palm health and quality are greatly affected by nutritional deficien- cies, which can reduce their aesthetic value, growth rate, or even cause death. Palm life canCOPYRIGHTED also be shortened by a number of MATERIAL diseases or insect pests, some of which are lethal, have no controls, or have wide host ranges. With the increasing use of palms in the landscape, pathogens and insect pests have moved with the Horticultural Reviews, Volume 42, First Edition. Edited by Jules Janick. 2014 Wiley-Blackwell. Published 2014 by John Wiley & Sons, Inc. 1 2 T.K. BROSCHAT, D.R. HODEL, AND M.L. -

Tesi Giuseppe Parlavecchio.Pdf
DOTTORATO DI RICERCA IN TECNOLOGIE FITOSANITARIE (XXIII ciclo: 2007-2010) Dipartimento di Scienze e Tecnologie Fitosanitarie Sezione Patologia vegetale UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA GIUSEPPE PARLAVECCHIO Valutazione e messa a punto del metodo endoterapico in piante ornamentali TESI DI DOTTORATO Coordinatore: Tutor: Chiar.ma Prof.ssa Gabriella Cirvilleri Chiar.mo Prof. Giancarlo Polizzi INDICE PARTE GENERALE 1 – ENDOTERAPIA…………………………..…………………….. pag. 7 1.1 – Introduzione……………………………………………… » 7 1.2 – Evoluzione storica………………………………………... » 9 1.3 – Metodi e mezzi utilizzati in endoterapia……......………... » 12 1.4 - Iniezione per assorbimento naturale ……………............... » 13 1.5 – Iniezione per pressione…………………………………… » 14 1.6 – Apparati per trattamenti endoterapici…….……………….» 17 1.7 – Il ruolo dei solventi………………………………………. » 21 1.8 –Applicazioni pratiche………………………….………….. » 21 1.9 –Aspetti positivi e negativi dell’endoterapia………………. » 26 1.10 – Risposta dei tessuti e movimento delle soluzioni nelle Cycadales e nelle Palmae……………………………………….» 31 2 – LE CYCADALES…………………...…………………………... » 36 2.1 – Inquadramento botanico ………………………………….» 36 2.2 – Caratteristiche morfologiche……………………………...» 37 2.3 – Coltivazione………………………………………………» 38 2.4 – Principali malattie…………………………….…………...» 40 2.5 – Carenza di manganese……………………………………. » 42 3 – LE PALMAE……………………...…………….……………… » 46 3.1 – Inquadramento botanico ………………………………….» 46 3.2 – Caratteristiche morfologiche……………………………...» 46 3.3 – Coltivazione……………………………………………….» 47 3.4 – Principali malattie…………………………….…………...» -

A Catalogue of the Eumeninae (Hymenoptera: Vespidae) of the Ethiopian Region Excluding Malagasy Subregion
© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at Linzer biol. Beitr. 42/1 95-315 31.7.2010 A Catalogue of the Eumeninae (Hymenoptera: Vespidae) of the Ethiopian Region excluding Malagasy Subregion. Part II: Genera Delta de SAUSSURE 1885 to Zethus FABRICIUS 1804 and Species Incertae Sedis J.M. CARPENTER, J. GUSENLEITNER & M. MADL A b s t r a c t : The genera in alphabetical order from Delta de SAUSSURE 1885 to Zethus FABRICIUS 1804 and species incertae sedis are catalogued. Several taxonomic changes are proposed. K e y w o r d s : Vespidae, Eumeninae, Ethiopian Region, catalogue, taxonomy. Introduction This is the second part of a catalogue of the Eumeninae of the Ethiopian Region excluding Malagasy Subregion. The first part was published by CARPENTER et al. (2009) consisting of the genera in alphabetical order from Aethiopicodynerus GUSENLEITNER 1997 to Cyrtolabulus van der VECHT 1969, as well as a key to the genera. That paper should also be consulted for explanation of conventions we have followed. This second part deals with all the remaining genera and the species incertae sedis and thus brings the alphabetical catalogue to an end. As CARPENTER & MADL (2009: Linzer biologische Beiträge 41 (2): 1871-1935) recently published a catalogue of the Vespidae of the Malagasy Subregion, the Eumeninae of the whole Ethiopian Region have now been treated. The third part will include additions, corrections, an index and a systematic review. Abbreviations app................................appendix biol ................................. biology cat................................ catalogue distr .......................... distribution ed. (eds)...............editor (editors) fig. (figs) ............ figure (figures) pl. (pls)...................plate (plates) © Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at 96 sen. -

Host Range, Geographical Distribution and Current Accepted Names of Cercosporoid and Ramularioid Species in Iran
Current Research in Environmental & Applied Mycology (Journal of Fungal Biology) 9(1): 122–163 (2019) ISSN 2229-2225 www.creamjournal.org Article Doi 10.5943/cream/9/1/13 Host range, geographical distribution and current accepted names of cercosporoid and ramularioid species in Iran Pirnia M Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran Pirnia M 2019 – Host range, geographical distribution and current accepted names of cercosporoid and ramularioid species in Iran. Current Research in Environmental & Applied Mycology (Journal of Fungal Biology) 9(1), 122–163, Doi 10.5943/cream/9/1/13 Abstract Comprehensive up to date information of cercosporoid and ramularioid species of Iran is given with their hosts, geographical distribution and references. A total of 186 taxa belonging to 24 genara are listed. Among them, 134 taxa were belonged to 16 Cercospora and Cercospora-like genera viz. Cercospora (62 species), Cercosporidium (1 species), Clypeosphaerella (1 species), Fulvia (1 species), Graminopassalora (1 species), Neocercospora (1 species), Neocercosporidium (1 species), Nothopassalora (1 species), Paracercosporidium (1 species), Passalora (21 species), Pseudocercospora (36 species), Rosisphaerella (1 species), Scolecostigmina (2 species), Sirosporium (2 species), Sultanimyces (1 species) and Zasmidium (1 species); and 52 taxa were belonged to 8 Ramularia and Ramularia-like genera viz. Cercosporella (2 species), Microcyclosporella (1 species), Neoovularia (2 species), Neopseudocercosporella (1 species), Neoramularia (2 species), Ramularia (42 species), Ramulariopsis (1 species) and Ramulispora (1 species). Key words – anamorphic fungi – biodiversity – Cercospora-like genera – Ramularia-like genera – west of Asia Introduction Cercosporoid and ramularioid fungi are traditionally related to the genus Mycospharella Johanson. Sivanesan (1984) investigated teleomorph-anamorph connexions in bitunicate ascomycetes and cited that Mycosphaerella is related to some anamorphic genera viz. -

Characterising Plant Pathogen Communities and Their Environmental Drivers at a National Scale
Lincoln University Digital Thesis Copyright Statement The digital copy of this thesis is protected by the Copyright Act 1994 (New Zealand). This thesis may be consulted by you, provided you comply with the provisions of the Act and the following conditions of use: you will use the copy only for the purposes of research or private study you will recognise the author's right to be identified as the author of the thesis and due acknowledgement will be made to the author where appropriate you will obtain the author's permission before publishing any material from the thesis. Characterising plant pathogen communities and their environmental drivers at a national scale A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy at Lincoln University by Andreas Makiola Lincoln University, New Zealand 2019 General abstract Plant pathogens play a critical role for global food security, conservation of natural ecosystems and future resilience and sustainability of ecosystem services in general. Thus, it is crucial to understand the large-scale processes that shape plant pathogen communities. The recent drop in DNA sequencing costs offers, for the first time, the opportunity to study multiple plant pathogens simultaneously in their naturally occurring environment effectively at large scale. In this thesis, my aims were (1) to employ next-generation sequencing (NGS) based metabarcoding for the detection and identification of plant pathogens at the ecosystem scale in New Zealand, (2) to characterise plant pathogen communities, and (3) to determine the environmental drivers of these communities. First, I investigated the suitability of NGS for the detection, identification and quantification of plant pathogens using rust fungi as a model system. -

Lista De Plagas No Cuarentenarias En Nicaragua Versión Vi-Mayo 2021
INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y SANIDAD AGROPECUARIA DIRECCIÓN SANIDAD VEGETAL Y SEMILLAS LISTA DE PLAGAS NO CUARENTENARIAS EN NICARAGUA VERSIÓN VI-MAYO 2021 Versión: VI El presente trabajo constituye una recopilación de información sobre plagas reportadas en Nicaragua. En el se listan plagas de tipo ácaros, insectos, arvenses, nematodos, hongos, bacterias y virus, abarcando su taxonomía, sinonimia y cultivos que afecta. Para la realización de este listado se tomó en cuenta resultados de diagnósticos fitosanitarios, a través de las visitas a campo, muestreo, revisión de literatura y consultas en bases de datos. El IPSA (Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria), pone a disposición la versión VI del listado de plagas reportadas en Nicaragua, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo III, numerales 9 y 16 del Artículo 9 de la Ley No. 1020 "Ley de Protección Fitosanitaria de Nicaragua; así como lo estipulado en el Nuevo Texto Revisado de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) en el Artículo VIII, numeral 1a. NOMBRE ACTUAL SINÓNIMOS CULTIVOS ÁCAROS Brevipalpus californicus (Banks, 1904) Brevipalpus australis Baker, 1949 Cítricos, Palma Africana Brevipalpus browningi Baker, 1949 Brevipalpus confusis Baker, 1949 Brevipalpus woglumi McGregor, 1949 Hystripalpus californicus Mitrofanov & Strunkova, 1979 Tenuipalpus australis Tucker, 1926 Tenuipalpus californicus Banks, 1904 Tenuipalpus vitis Womersley, 1940 Brevipalpus obovatus Donnadieu Brevipalpus bioculatus Chile, Chiltoma, Cocotero Brevipalpus inornatus (Banks) -

Tropical Fruit - Chap 00 7/5/03 12:59 PM Page I
Tropical Fruit - Chap 00 7/5/03 12:59 PM Page i Diseases of Tropical Fruit Crops Tropical Fruit - Chap 00 7/5/03 12:59 PM Page ii Tropical Fruit - Chap 00 7/5/03 12:59 PM Page iii Diseases of Tropical Fruit Crops Edited by Randy C. Ploetz University of Florida, IFAS, Tropical Research and Education Center Homestead, Florida, USA CABI Publishing Tropical Fruit - Chap 00 7/5/03 12:59 PM Page iv CABI Publishing is a division of CAB International CABI Publishing CABI Publishing CAB International 44 Brattle Street Wallingford 4th Floor Oxon OX10 8DE Cambridge, MA 02138 UK USA Tel: +44 (0)1491 832111 Tel: +1 617 395 4056 Fax: +44 (0)1491 833508 Fax: +1 617 354 6875 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] Web site: www.cabi-publishing.org © CAB International 2003. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means, electronically, mechani- cally, by photocopying, recording or otherwise, without the prior permis- sion of the copyright owners. A catalogue record for this book is available from the British Library, London, UK. A catalogue record for this book is available from the Library of Congress, Washington, DC, USA. ISBN 0 85199 390 7 Typeset in 9/11 pt Palatino by Columns Design Ltd, Reading, UK Printed and bound in the UK by Cromwell Press, Trowbridge Tropical Fruit - Chap 00 7/5/03 12:59 PM Page v Contents Contributors vii Dedication ix R.C. Ploetz and J.A. -

Plant Pest Diagnostics Center Annual Report 2010
Plant Pest Diagnostics Center Annual Report 2010 Tribulus terrestris L. or puncturevine (Zygophyllaceae) is a C-rated noxious weed pest and Restricted Noxious Weed Seed in California. The fruit consists of five seed-bearing segments that break apart at maturity. Each segment contains 3 to 5 seeds and has two stout spines that can inflict painful injury to humans and animals. The foliage contains saponin compounds that can be toxic to livestock when ingested in sufficient quantity. The plant is native to the Mediterranean region and is considered a noxious weed in most western states. 2010 Plant Pest Diagnostics Center Annual Report 1 Contents Introduction 3 Diagnostics 4 Research 4 Seminar Series 5 California State Collection Of Arthropods: 2010 Report 6 Plant Pest Diagnostics Center 2010 Highlights & Accomplishments 7 Staffing Changes 12 2010 Annual Report of the Botany Laboratory 14 2010 Annual Report of the Entomology Laboratory 23 Taxonomy & Systematics of Coleoptera 24 Mealybug, Scale & Whitefly Research 25 Dipterological Research Activities in 2010 27 The European Grape Vine Moth NOT Found In California: Eupoecilia ambiguella (Hübner) 32 2010 Annual Report of the Nematology Laboratory 35 2010 Annual Report of the Plant Pathology Laboratory 39 Fungal Rust Disease & Selected Profiles of Unique Detections 40 Plum Pox Virus Survey & Citrus Tristeza Virus Detection 45 2010 Asian Citrus Psyllid & Huanglongbing Recap 46 Seed Health Testing 2010 48 The Nursery Annual Survey of Deciduous Fruit Tree, Nut Tree and Grapevine for 2010 49 HLB & Other Testing Activities 2010 50 2010 Annual Report of the Seed Science Laboratory 52 PPDC Scientist Editorial Responsibilities & Scientific Service 60 Publications 62 Presentations 65 Credits Editors: Timothy Tidwell & Megan O’Donnell Layout: Megan O’Donnell All articles were written by PPDC Staff unless otherwise noted. -

Index of Plant Diseases in South Carolina
INDEX OF PLANT DISEASES IN SOUTH CAROLINA Third Edition James H. Blake, Ed.D. State Coordinator SC Master Gardener Program SC Master Naturalist Program Meg Williamson, M.S. Plant Disease Diagnostician PREFACE The first edition of the Index of Plant Diseases in South Carolina published in 2008 listed the plant diseases occurring on cultivated and native plants in SC as reported from plant samples submitted to the Clemson University Plant Problem Clinic between 1972 and 2006, with the addition of disease reports from Extension and research plant pathologists across SC. The second edition included data from 2007 through 2011, adding 85 new host plants and 634 new diagnoses. This third edition includes disease reports from 2012 through 2014, adding 54 new host plants and 350 new diagnoses. The Index now contains 1,041 genera and species of plants from 124 plant families with 1,573 common names. There are 5,727 disease reports with 4,712 diseases being caused by fungi, 442 diseases caused by nematodes, 380 diseases caused by bacteria, 247 diseases caused by viruses, 20 diseases caused by algae, 3 diseases caused lichens, 1 disease caused by a phytoplasma, and 1 disease caused by a viroid. No attempt has been made to update the binomial nomenclature of either plants or plant pathogens listed in this publication. This index lists the plants and their pathogens as taken from the sample submission forms and the reports generated by the various Clemson University plant pathologists. This index does not imply that it is a complete list of the diseases of plants in South Carolina.