La Strategia Della Tensione E La Teoria Del Doppio Stato
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Interrogato Daj Giudici L'ex Capo Del SID Grave Offensiva Contro L
r Unità 7 venerdì 8 novembre 1974 PÀG. 5 / cronache u » t Otto nuovi provvedimenti firmati dal giudici che Indagano sul tentativo di Borghese Nuovi mandati di cattura per il golpe Tra gli arrestati esponenti del MSI Cinque sono finiti in carcere, tre sono riusciti a fuggire - Tra questi il consigliere regionale missino della Valle d'Aosta, Parisi - Manette a Zanelli dirigente provinciale alla Spezia del partito neofascista - Spiccati una ventina di avvisi di reato e oltre cinquanta comunicazioni giudiziarie Altri otto mandati di cattura, di cui cinque eseguiti Ieri mattina, una ventina di avvisi di reato e 50 comunicazioni giudiziarie sono il bilancio della nuova e tornata » di Indagini della magistratura romana sul golpe Borghese del dicembre 1970. Il • giudice istruttore Filippo Fiore, su richiesta del PM Claudio Vltalone, ha fatto arrestare dagli agenti del Processo al commando nero di Varese nucleo di polizia giudiziaria Benito Guadagni, romano, che fu uno dei più stretti collabo VARESE, 7 vanni, di 21 anni, esponente delle SAM, un ratori di Borghese, costruttore edile; Tommaso Adami Rock, fiorentino, ingegnere, già se- • Con la concessione di meno di ventlquat- • « sambabillno », colpito da mandato di cat ; ; . gretario provinciale e candi . tr'ore di tempo a favore della difesa, si è tura del giudice istruttore di Rieti «per in dato al consiglio comunale conclusa stamane, in poco più di un'ora e surrezione armata contro lo Stato, attentato per il MSI; Adriano Mon ' mezza, la prima udienza del procedimento alla Costituzione, associazione sovversiva e ti medico di Rieti, Giuseppe < per direttissima nel confronti del quattro Zanelli di La Spezia, dirigen • neofascisti arrestati a Varese il 27 ottobre ricostituzione del dlsclolto partito fascista ». -

Contemporary Italy: Literature, Cinema, Politics and Culture SRISA Course Number: POLI 3102 Maryville Course Number: PSCI 370 Credits: 3, Contact Hours: 45
Lecture Course Santa Reparata International School of Art Course Syllabus Semester Course Course Title: History of Contemporary Italy: Literature, Cinema, Politics and Culture SRISA Course Number: POLI 3102 Maryville Course Number: PSCI 370 Credits: 3, Contact Hours: 45 1. COURSE DESCRIPTION In this course students will study the history of Contemporary Italy from WWII (the 1940’s and the birth of the Italian Republic) and continue on through to the development and the radical change of the country during the 1960’s, the long Anni Settanta and the so called “years of lead”, contemporary Italian politics up through most recent historical events. Introduction to major literary, cinematographic and artistic movements are covered as well as social aspects of Italian life including topics such as the Italian political system; the development of the Italian educational system; the roots and influence of the Italian Mafia; and the changing role of women in Italian society. 2. CONTENT INTRODUCTION This course introduces students to the history and politics of contemporary Italy from the time of WWII to the present. The course is divided into five parts, with the first part focusing on the transformation of the country and its eventual industrialization. We will study the reconstruction and economic boom of the 1950s and 1960s, social post-war conflict, and the year 1968 - with the student and worker protests - and the final changing of Italian social geography. Great importance will be given to internal migration, from south to north and to the development of the Mafia. The second part of the course focuses on the history of the 1970s, later called the “Years of Lead”, because of terrorist escalation culminating with the assassination of MP Aldo Moro in May 1978 by the Red Brigades. -

Gli Anni Di Piombo Nella Letteratura E Nell'arte Degli Anni Duemila
Facultad de Filología Departamento de Filología Moderna Área de Estudios italianos Gli anni di piombo nella letteratura e nell’arte degli anni Duemila TESIS DOCTORAL AUTORA: LILIA ZANELLI DIRECTORA: CELIA ARAMBURU SÁNCHEZ SALAMANCA 2018 II Esta Tesis Doctoral ha sido realizada bajo la dirección de la Profesora Celia Aramburu Sánchez Fdo. III IV Non posso terminare questo lavoro senza ringraziare, in primo luogo, la professoressa Celia Aramburu Sánchez, per gli insegnamenti ed il tempo che mi ha dedicato fin dall’inizio di questa ricerca, per la pazienza nel rispondere ai tanti dubbi che le sottoponevo, per la passione con la quale abbiamo condiviso questo tema, per avermi saputo orientare, consigliare, correggere, e non ultimo incoraggiare durante questi anni. Grazie anche a tutti i professori dell’Área de Estudios italianos dell’Università di Salamanca i cui insegnamenti spero di essere riuscita a plasmare nell’elaborazione di questa tesi. Un ringraziamento speciale anche alla professoressa Alessandra Zanobetti che è stata mia tutor durante il mio soggiorno presso l’università di Bologna e che ho ritrovato con piacere dopo tanti anni, senza la quale la ricerca riguardante la parte giuridica di questa tesi non sarebbe stata possibile. Grazie alla mia famiglia e poi agli amici più cari che hanno sopportato le assenze, le preoccupazioni ed incertezze e in particolare a mio cugino Maurizio Morini, testimone diretto degli “anni di piombo” e fonte di ispirazione. Grazie, Javier e Paola, per il vostro amore, per l’aiuto enorme che mi avete prestato e per avere sempre creduto in me. V VI Indice ABBREVIATURE IMPIEGATE XIII INTRODUZIONE 1 1. -

Italy and Its Traumatic Past
How to Transform a ‘Place of Violence’ into a ‘Space of Collective Remembering’: Italy and its Traumatic Past Anna Lisa Tota* Abstract: This paper seeks to analyse cultural trauma theories and their consequences as well as their potential applicability to cases of collective trauma where access to the legal arena in the rehabilitation process is not possible. When ‘state terror’ occurs, such as in Latin America, or, more arguably Italy, access to the legal arena is systematically denied through a variety of criminal strategies. In these cases, the cultural working through of trauma takes place on the aesthetic level. What are the consequences of this process both for the inscription of the crucial event in public discourse and for its relationship with justice? Moreover, how do aesthetic codes affect the public definition of justice and a collective understanding of what happened? Introduction1 A new wave of international terrorism has emerged in the wake of the attacks of September 11, March 11 and July 7 affecting our common perceptions of risk, justice and everyday life. These attacks challenged existing ideas about the state, war, torture, prison, human rights and presented a host of new questions for intellectuals, social scientists, artists, politicians and common citizens to consider. The question of how to locate terror in the public space is a complex question but it can be analysed by considering the nature itself of the aesthetic codes used to transform a place of violence into a space of collective remembering. This process of transforming place is shaped by the performative nature of the narratives used in the different national contexts. -

La Violenza Politica Che L'italia Democratica Deve Affrontare A
La violenza politica che l'Italia democratica deve affrontare a partire dagli anni Settanta, ha due punti di riferimento, seppure non sempre facilmente identificabili: il lascito psicologico, culturale e politico del fascismo repubblicano di Salò da un lato, e quello della Resistenza dall'altro. In ambedue i casi, I'irriducibilità di queste estreme minoranze muove da un presupposto mitico. Per gli eredi di Salò si tratta delI'onore della patria tradito dal re e da Badoglio. E’ per riscattare il disonore che tanti giovani, cresciuti nella scuola fascista, si impegnano nell’ultima disperata militanza a Salò. Dai ranghi della Repubblica Sociale viene il nucleo fondante della destra neofascista nel II dopoguerra; e agli ideali del fascismo di Salò vanno riportati mentalità e propositi di quella base missina movimentista in cui viene reclutata la manovalanza per golpe e stragi . A questa sempre più lontana e generica matrice fascista, si aggiungeranno, col passare del tempo altri miti, quelli dell'arianesimo e del nazionalsocialismo hitleriano o addirittura quelli della ritualità celtica come espressione di una Europa forte, pura, e superiore, da contrapporre all'Est comunista e al capitalismo occidentale, soprattutto americano. Proprio una Europa vista come terza potenza mondiale, ma vissuta come rivincita sulla guerra perduta dal nazifascismo darà il nome “Terza posizione” ad una delle più importanti organizzazioni dell'eversione nera che sarà poi il serbatoio di reclutamento dei gruppi di fuoco dei NAR. Prevalentemente di segno operaio e studentesco, con diffuso reclutamento nell'emarginazione, è invece lo spazio sociale delI'eversione rossa; essa si radicalizzerà con il crescere di quella nera fino a riempire la scena intorno alla metà degli anni Settanta, quando si scatenerà il terrorismo rosso. -

Italy to California Italian Immigration
CONTENTS Letter from Nancy Pelosi 2 Foreword by Mark D. Schiavenza 3 The Italians Who Shaped California by Alessandro Baccari 4 Introduction 6 THE FIRST WAVE: Working Life IN CERCA DI Agriculture & Food Processing 7 UNA NUOVA VITA Winemakers 7 ITALY TO CALIFORNIA Inventors & Entrepreneurs 8 Making A Living 8 ITALIAN IMMIGRATION: 1850 TO TODAY Story of a Sicilian Fisherman 10 Organized Labor 10 OCT. 16, 2009 – JAN. 17, 2010 Women Workers 10 Story of a Pioneer Woman 12 MUSEO ItaloAmericano Gold Country: The Miners 12 Fort Mason Center, Building C, San Francisco, CA 94123 Teresa’s Place 12 Gold Country: The Boardinghouses 13 THE FIRST WAVE: City Life The Italian District: North Beach 14 Italian Opera 14 Italian Language Press 16 Scavenging 16 Business & Banking 17 The Earthquake 17 THE FIRST WAVE: Social Life Family & Community 19 Church & School 19 THE SECOND WAVE: A Different Kind of Immigrant The Middle Class Immigration 20 Starting Over 20 Escaping Racial Laws 21 Displaced Persons 21 PHOTOS: FRONT COVER Photo: FIRST WAVE – Italian Immigrants THE THIRD Wave on Ferry from Ellis Island, 1905. Photo by Lewis W. Hine. Courtesy The Third Wave by Paolo Pontoniere 22 of George Eastman House Third Wave Immigrants: 22 THIS PAGE: SECOND WAVE – Papa Gianni Giotta (on the left) and Marco Vinella at opening day of Caffe Trieste, 1956. Courtesy A Global Tribe of Artists, Scientists, of the Giotta family Entrepreneurs, & Explorers INSIDE COVER Photo: THIRD WAVE – TWA’s First Flight from From Social Unrest to Technological 25 Fiumicino International Airport to JFK with a Boeing 747. -

L'altra Italia
Dipartimento di Scienze Politiche Cattedra di Storia dei partiti e dei movimenti politici L'altra Italia Prof. Vera Capperucci Enrico Compalati (084852) RELATORE CANDIDATO Anno Accademico 2019/2020 INDICE Introduzione ..................................................................................................................................................... 3 Capitolo primo: IL DOPPIO STATO ............................................................................................................. 5 1.1 La crisi istituzionale italiana .................................................................................................................... 5 1.2 La strage di Piazza Fontana ..................................................................................................................... 7 1.3 Il ruolo delle forze armate ....................................................................................................................... 9 1.4 La guerra rivoluzionaria anti-comunista ................................................................................................ 11 1.5 I servizi segreti e la P2 ........................................................................................................................... 12 Capitolo secondo: PROPAGANDA 2 ............................................................................................................ 14 2.1 L’ascesa del “burattinaio” .................................................................................................................... -
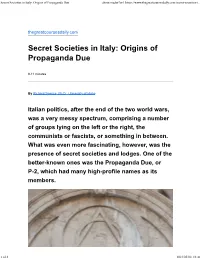
Secret Societies in Italy: Origins of Propaganda Due About:Reader?Url=
Secret Societies in Italy: Origins of Propaganda Due about:reader?url=https://www.thegreatcoursesdaily.com/secret-societies-i... thegreatcoursesdaily.com Secret Societies in Italy: Origins of Propaganda Due 9-11 minutes By Richard Spence, Ph.D., University of Idaho Italian politics, after the end of the two world wars, was a very messy spectrum, comprising a number of groups lying on the left or the right, the communists or fascists, or something in between. What was even more fascinating, however, was the presence of secret societies and lodges. One of the better-known ones was the Propaganda Due, or P-2, which had many high-profile names as its members. 1 of 8 2021/05/02, 13:41 Secret Societies in Italy: Origins of Propaganda Due about:reader?url=https://www.thegreatcoursesdaily.com/secret-societies-i... Propaganda Due, or P2, had its roots in masonic lodges, but ran much deeper in reality. It had complex political connections, and was believed to be the secret government of Italy. (Image: Cris Foto/Shutterstock) The Discovery of the P-2 Roster On March 17, 1981, in the Tuscan town of Arezzo, a special anti- corruption force stormed the home of a local mattress manufacturer, Licio Gelli, suspected to have connections to two fugitive bankers: Roberto Calvi and Michele Sindona. Rumored to be members of the secretive Masonic lodge, Propaganda Due, or P-2, Gelli’s papers were expected to hold information about the fugitives. Instead, however, the police found a membership roster for the lodge, consisting of an astounding 962 names. Even more surprising was that the Italian law enforcement agency Guardia di Finanza’s own commander, Orazio Giannini, was also on the list. -

Intelligence Gathering in Postwar Austria P
MASTERARBEIT / MASTER´S THESIS Titel der Masterarbeit / Title of the Master´s Thesis US-led stay behind networks in Austria A tale from the Cold War: shady deals, dubious loyalties, and underground arms caches. verfasst von / submitted by Lorenzo Cottica, BA angestrebter akademischer Grad / in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master (MA) Wien, 2017 / Vienna 2017 Studienkennzahl lt. Studienblatt / A 066 805 degree program code as it appears on the student record sheet: Studienrichtung lt. Studienblatt / Masterstudium Globalgeschichte degree program as it appears on the student record sheet: Betreut von / Supervisor: Uni.-Prof. Mag. DDr. Oliver Rathkolb “A pensar male degli altri si fa peccato, ma spesso ci si indovina.1” (Thinking ill of others is a sin, but it often turns out good guesses.) 1 One of the most famous aphorisms credited to Giulio Andreotti, [undated], cited from ilsole24ore.com. Link. II Acknowledgments First and foremost, I want to express my sincere gratitude to the supervisor of this project, Prof. Oliver Rathkolb who, aside from assisting me throughout the research process, also granted me access to his private archive of copied source-material. Almost a third of all primary sources on which this thesis is founded upon, were thereby sponsored by prof. Rathkolb. I likewise want to thank General Horst Pleiner, for granting me the possibility to conduct and record an interesting interview of over an hour, thereby enriching the research with his expert perspective. III Abstract After dealing with a handful of editorial notes in chapter one, in chapter two, the thesis moves on to a description of the technical and methodological elements of the research itself, such as the terminology used, a critique of the main sources and an overview of the current state of research in this particular field. -

Commissione Parlamentare D'inchiesta Sul Terrorismo in Italia E Sulle Cause Della Mancata Individuazione Dei Responsabili Delle Stragi
SENATO DELLA REPUBBLICA CAMERA DEI DEPUTATI X LEGISLATURA Doc. XXIII n. 36 COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI (istituita con legge 17 maggio 1988, n. 172) (composta dai senatori: Gualtieri, Presidente; Battello, Bertoldi, Boato, Bosco, De Cinque, Ferrara Salute, Granelli, Graziani, Greco, Leonardi, Lipari, Macis, Manieri, Pasquino, Rastrelli, Sanna, Signori, Toth, Visca, Vitale; e dai deputati: Casini Pierferdinando, Bellocchio, Vice Presidenti; Nicotra, Buffoni, Segretari; Binetti, Biondi, Cicciomessere, Cipriani, De Julio, Orlandi, Pacetti, Piccirillo, Pietrini, Sanese, Scovacricchi, Serra, Sinesio, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Tortorella, Zamberletti) Prerelazione sull'inchiesta condotta dalla Commissione in ordine alle vicende connesse all'operazione Gladio, con annessi gli atti del dibattito svoltosi sul documento stesso trasmessa dal Presidente della Commissione Gualtieri alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in conformità all'ordine del giorno approvato dalla Commssione nella seduta del 20 giugno 1991 Comunicata alle Presidenze 9 luglio 1991 10-PAR-INC-0036-0 TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900) Senato della Repubblica - 3 - Camera dei deputati X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI SENATO DELU REPUBBLICA ■ CAMERA DEI DEPUTATI COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA Roma, 9 luglio 1991 SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI Prot. n. 2-1*7^/£ ^ RESPONSABILI -

Modern Italy SRISA Course Number: HIST 4301 Maryville Course Number: HIST 343 Credits: 3, Contact Hours: 45
Lecture Course Santa Reparata International School of Art Course Syllabus Semester Course Course Title: The History of Modern Italy SRISA Course Number: HIST 4301 Maryville Course Number: HIST 343 Credits: 3, Contact Hours: 45 1. COURSE DESCRIPTION This course will study the history of Modern Italy from the Risorgimento and continue on through the development and decline of the liberal Italian state; Mussolini and Italian Fascism; World War II; and post World War II Italy; up through recent historical events. Introduction to major literary, cinematographic and artistic movements are covered as well as social aspects of Italian life including topics such as the Italian political system; the development of the Italian educational system; the roots and influence of the Italian Mafia; and the changing roll of the woman in Italian society. 2. CONTENT INTRODUCTION This course introduces students to the history and politics of modern Italy from the time of its political Unification to the present. The major topics covered throughout the course include the process of political unification in the mid-late 1800s; the birth and growth of Fascism in Italy (1922-1943); the Second World War (1940-45); the workings of governing institutions in the post-war period (1946-48); the role of the Church; political parties and movements; the process of massive industrialization (1950-60’s); political terrorist events (1960-80’s); as well as political corruption and political conspiracy. There will also be an in-depth analysis of the political crisis and transformation of the Italian democratic system in the early 1990s. 3. PREREQUISITES As this course is an introduction to modern and contemporary Italian history, there are no special requirements to attend. -

Tanti Sospetti Sullo 007 Di Andreotti Radunato Durante I 55 Giorni Fosse Colmabile, Invece Non Lo È
POLITICA INTERNA K «Cossiga porta I misteri Un rapporto Sid del 74 indica il «colonnello D'Ambrosio» il peso delle cose tra gli «aderenti» al golpe del principe Borghese non fatte per Aldo Moro» della Repubblica Parla Bellocchio, vicepresidente della commissione Stragi: dice Maria Fida •Credo che ogni cittadino italiano, ed in particolare il presi «È lui l'uomo che si vuole alla guidadel Sismi?» dente della Repubblica che li rappresenta tutti, porterà per sempre il peso delle cose che si potevano fare durante il ca • ' ; / ' < \ so Moro». Lo afferma la figlia MarwFlda (nella foto), sena trice de, nel corso di un'intervista alla rubrica di Canale S •Parlamento in». Smentita ancora una volta l'ipotesi di una denuncia sua e di sua madre contro Andreotti e Cossiga, la senatrice conferma di voler lasciare la De. «Credevo in buo na fede che questo enorme quantitativo di dolore che si era Tanti sospetti sullo 007 di Andreotti radunato durante i 55 giorni fosse colmabile, invece non lo è. E le parole di mio padre che avrebbe lasciato questo parti Dagli atti della Camera spunta un rapporto del Sid De Lorenzo (altro tentato gol stragi debba acquisire imme carte: vediamo quel che c'è nel 72. L'altro giorno alla Ca depistaggio? to, in questo momento mi suonano troppo forte nella men pe, il «piano Solo»), con la di diatamente tutta la documen scritto esattamente nel proto mera ha invece ammesso che Ammesso e non concesso te» Circa le responsabilità della De nella vicenda. Maria Fida che indica tra gli uomini «aderenti» al golpe Borghe sponibilità di armi ed esplosivi tazione relativa alla «operazio collo, dov'erano le sedi territo esiste ancora.