Modena E Motori: Gli Anni Cinquanta Visti Da Lontano
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
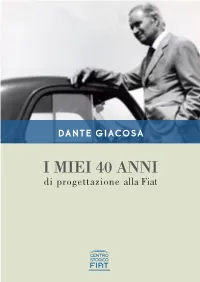
I MIEI 40 ANNI Di Progettazione Alla Fiat I Miei 40 Anni Di Progettazione Alla Fiat DANTE GIACOSA
DANTE GIACOSA I MIEI 40 ANNI di progettazione alla Fiat I miei 40 anni di progettazione alla Fiat DANTE GIACOSA I MIEI 40 ANNI di progettazione alla Fiat Editing e apparati a cura di: Angelo Tito Anselmi Progettazione grafica e impaginazione: Fregi e Majuscole, Torino Due precedenti edizioni di questo volume, I miei 40 anni di progettazione alla Fiat e Progetti alla Fiat prima del computer, sono state pubblicate da Automobilia rispettivamente nel 1979 e nel 1988. Per volere della signora Mariella Zanon di Valgiurata, figlia di Dante Giacosa, questa pubblicazione ricalca fedelmente la prima edizione del 1979, anche per quanto riguarda le biografie dei protagonisti di questa storia (in cui l’unico aggiornamento è quello fornito tra parentesi quadre con la data della scomparsa laddove avve- nuta dopo il 1979). © Mariella Giacosa Zanon di Valgiurata, 1979 Ristampato nell’anno 2014 a cura di Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. Logo di prima copertina: courtesy di Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. … ”Noi siamo ciò di cui ci inebriamo” dice Jerry Rubin in Do it! “In ogni caso nulla ci fa più felici che parlare di noi stessi, in bene o in male. La nostra esperienza, la nostra memoria è divenuta fonte di estasi. Ed eccomi qua, io pure” Saul Bellow, Gerusalemme andata e ritorno Desidero esprimere la mia gratitudine alle persone che mi hanno incoraggiato a scrivere questo libro della mia vita di lavoro e a quelle che con il loro aiuto ne hanno reso possibile la pubblicazione. Per la sua previdente iniziativa di prender nota di incontri e fatti significativi e conservare documenti, Wanda Vigliano Mundula che mi fu vicina come segretaria dal 1946 al 1975. -

Altbüron LU 16
Altbüton LU Altbüron LU 16. August 2009 4. Bergprüfung für historische Sport- und Rennwagen Für Sie am Start: Infos unter: Biland! Waltisperg www.race-inn.ch 09.00 bis 17.00 Markus Eintrit't: Fr. 12.- Kinder bis 14 Jahre gratis Bösiger Jacques Cornu Robert Grogg Nee! Jani- Porsche ZenblJm Schil\ll1ach Bad Herzlich willkommen in Altbüron liebe Besucherinnen und Besucher liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer Als hätten w ir das stürmische Gewitter vorausgesehen, das unsere Wirtschaft gerade durchschüttelt, planten wir schon früh die Umstellung des bisherigen Zweijahrestaktes für unsere Veranstaltung. Und damit bekommt das Jahr 2009 einen willkommenen EriebnisbonU5, welcher d"e vi elen Unsicherheiten und Sorgen für ein paar Stunden ver- gessen lässt. Denn schon zum vierten Mal dürfen wir im schönen Altbüron einzigartige Rennwagen und von einst vorführen und geniessen. Dafür bedanken wir uns bei den Gemeindebehörden und den Einwohnerinnen und Einwohnern von Altbür0 . Wir hören oft von den Teilnehmenden, wie gastfreundlich und nett sie in Altbüro rn aufgenommen worden sind, und wie sehr sie sich freuen, ein nächstes Mal wieder hie dabei zu sein. Genauso erleben wir es als Organisatoren, man spürt richtig, dass wir mit nserer Szene hier willkommen sind. Unser Dank geht aber aue an die zuständigen Kantonsbehörden. Insbesondere an das Amt für Umwelt und E ergie (uwe) und an die Kantonspolizei Luzern, Bei ihnen haben wir für alle Veranstaltungen nicht nur die alles entscheidende Zustimmung erhalten, nein, wir durften stet auf echte Unterstützung zählen. Ein Dank gehört aUCh\ ns.er. n Helfern und Gästen, welche dann die bewilligte Vera I Wir brauchen sie geoau so wie di.e Fahrerinnen und mit ihrEm frisch aufpolierten Rennfahr· zeugen aller Ma und"beleben, Erneut haben wir die Ehre, I und 'I lebe KolleginnenI und Kolle- gen, zu begrüSSen. -

Porsche Panamera
n. 35 - 27 aprile 2009 Porsche Panamera Ma questo chi lo ferma? GP Bahrain Per la terza volta sul gradino più alto del podio Button è sempre più l’uomo da battere. Trulli illude in prova Vettel si conferma al top La foto della settimana Il rally nella Pampa I ragazzi aspettano i big del Mondiale, poco lontano l’Asado è già in cottura 2 Registrazione al tribunale Civile di Bologna con il numero 4/06 del 30/04/2003 Direttore responsabile: Massimo Costa ([email protected]) Redazione: Stefano Semeraro Marco Minghetti Marco Cortesi Collaborano Velocità: Carlo Baffi Leopoldo Canetoli Antonio Caruccio Marco Cortesi Valerio Faccini Alfredo Filippone Alessio Morgese Francesco Satta Produzione: Nicola Desiderio Marco Marelli Fotografie: Photo4 Actualfoto Photo Pellegrini MorAle Realizzazione: Inpagina srl Via Giambologna, 2 40138 Bologna Tel. 051 6013841 Fax 051 5880321 [email protected] 3 GP Bahrain - Il commento Dopo la vittoria-sorpresa ottenuta a Melbourne e il successo a metà dopo monsone malese, Jenson Button ha colto nel deserto del Bahrain una vittoria netta 4 Lo strano caso di Jenson ButtonHa dominato sul circuito cittadino di Melbourne. E’ emerso vin- citore nella pioggia dirompente di Sepang. Ha grintosamente conquistato il primo posto e il successo finale in mezzo all’afa di Al Sakhir. Jenson Button non teme nulla. Gli manca di vin- cere sul ghiaccio, in mezzo alla nebbia, su un circuito ovale, poi le ha provate tutte. E con lui la Brawn BGP001, una mono- posto che si adatta con facilità ad ogni condizione climatica, ad ogni tipologia di pista. Non può essere solo merito del dif- fusore. -

1° Porsche Festival Monza 2015
REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356 356 N. 27 - FEBBRAIO 2016 1° Porsche Festival Monza 2015notizieWinter Marathon 2016 3 Giro Valli Biellesi 14° Rally of Tests Fiera di Padova Cena degli auguri, Napoli 2015 PORSCHE 356 CONCORSO ELEGANZA EXPO - 356NOTIZIE STORY - L’ANGOLO DELLA TECNICA Porsche consiglia Per realizzare i vostri desideri, scegliete Porsche Financial Services Italia. Porsche Italia Spa, Padova corso Stati Uniti 35, Telefono 049/8292911. www.porsche.it Per chi crede nell’amore eterno. Porsche Classic. Ci sono auto di cui ci s’innamora per sempre. ll loro fascino ha bisogno di attenzioni, ma ricambia con emozioni senza tempo. Perché la vostra Porsche merita la cura, la conoscenza e la passione profonda di chi, come voi, sa amarla davvero. Venite a conoscere l’amore eterno dai Partner Porsche Classic, dove tecnici specializzati in vetture d’epoca sapranno coltivare la vostra storia per sempre: Centro Porsche Milano Est - Porsche Haus S.r.l. - Via Rubattino 94, Milano - Tel. 02 21080000 Centro Assistenza Porsche Padova Est - Verardini S.r.l. - Via IX Strada, 24 - Z.I., Padova - Tel. 049 773616 Cari Amiche ed Amici del Registro Italiano Porsche 356, dopo aver festeggiato il Natale con una indimenticabile Cena degli Auguri a Napoli grazie all'impegno dei Soci campani Michele Gagliardi, Stefano De Stefano, Luigi La Bella e Anita Salzano, auguro un Buon Anno Nuovo a tutti Voi. Il tempo vola e così pure procedono a spron battuto le iniziative e le nuove idee di tutto lo staff che continua ad impegnarsi orientando il lavoro su precise scelte di qualità per soddisfare le aspettative dei Soci. -

The Last Road Race
The Last Road Race ‘A very human story - and a good yarn too - that comes to life with interviews with the surviving drivers’ Observer X RICHARD W ILLIAMS Richard Williams is the chief sports writer for the Guardian and the bestselling author of The Death o f Ayrton Senna and Enzo Ferrari: A Life. By Richard Williams The Last Road Race The Death of Ayrton Senna Racers Enzo Ferrari: A Life The View from the High Board THE LAST ROAD RACE THE 1957 PESCARA GRAND PRIX Richard Williams Photographs by Bernard Cahier A PHOENIX PAPERBACK First published in Great Britain in 2004 by Weidenfeld & Nicolson This paperback edition published in 2005 by Phoenix, an imprint of Orion Books Ltd, Orion House, 5 Upper St Martin's Lane, London WC2H 9EA 10 987654321 Copyright © 2004 Richard Williams The right of Richard Williams to be identified as the author of this work has been asserted by him in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. A CIP catalogue record for this book is available from the British Library. ISBN 0 75381 851 5 Printed and bound in Great Britain by Clays Ltd, St Ives, pic www.orionbooks.co.uk Contents 1 Arriving 1 2 History 11 3 Moss 24 4 The Road 36 5 Brooks 44 6 Red 58 7 Green 75 8 Salvadori 88 9 Practice 100 10 The Race 107 11 Home 121 12 Then 131 The Entry 137 The Starting Grid 138 The Results 139 Published Sources 140 Acknowledgements 142 Index 143 'I thought it was fantastic. -

Eccellenze Meccaniche Italiane
ECCELLENZE MECCANICHE ITALIANE. MASERATI. Fondatori. Storia passata, presente. Uomini della Maserati dopo i Maserati. Auto del gruppo. Piloti. Carrozzieri. Modellini Storia della MASERATI. 0 – 0. FONDATORI : fratelli MASERATI. ALFIERI MASERATI : pilota automobilistico ed imprenditore italiano, fondatore della casa automobilistica MASERATI. Nasce a Voghera il 23/09/1887, è il quarto di sette fratelli, il primo Carlo trasmette la la passione per la meccanica ALFIERI, all'età di 12 anni già lavorava in una fabbrica di biciclette, nel 1902 riesce a farsi assumere a Milano dalla ISOTTA FRASCHINI, grazie all'aiuto del fratello Carlo. Alfieri grazie alle sue capacità fa carriera e alle mansioni più umili, riesce ad arrivare fino al reparto corse dell'azienda per poi assistere meccanicamente alla maccina vincente della Targa FLORIO del 1908, la ISOTTA lo manda come tecnico nella filiale argentina di Buenos Aires, poi spostarlo a Londra, e in Francia, infine nel 1914 decide, affiancato dai suoi fratelli. Ettore ed Ernesto, di fondare la MASERAT ALFIERI OFFICINE, pur rimanendo legato al marchio ISOTTA-FRASCHINI, di cui ne cura le vetture da competizione in seguito cura anche i propulsori DIATTO. Intanto però, in Italia scoppia la guerra e la sua attività viene bloccata. Alfieri Maserati, in questo periodo, progetta una candela di accensione per motori, con la quale nasce a Milano la Fabbrica CANDELE MASERATI infine progetta un prototipo con base telaio ISOTTA- FRASCHINI, ottenendo numerose vittorie, seguirà la collaborazione con la DIATTO, infine tra il 1925/26, mesce la mitica MASERATI TIPO 26, rivelandosi poi, un'automobile vincente. Il 1929 sarà l'anno della creazione di una 2 vettura la V43000, con oltre 300 CV, la quale raggiungerà i 246 Km/ h, oltre ad altre mitiche vittorie automobilistiche. -

The Mexican Grand Prix 1963-70
2015 MEXICAN GRAND PRIX • MEDIA GUIDE 03 WELCOME MESSAGE 04 MEDIA ACCREDITATION CENTRE AND MEDIA CENTRE Location Maps Opening Hours 06 MEDIA CENTRE Key Staff Facilities (IT • Photographic • Telecoms) Working in the Media Centre 09 PRESS CONFERENCE SCHEDULE 10 PHOTOGRAPHERS’ SHUTTLE BUS SCHEDULE 11 RACE TIMETABLE 15 USEFUL INFORMATION Airline numbers Rental car numbers Taxi companies 16 MAPS AND DIAGRAMS Circuit with Media Centre Media Centre layout Circuit with corner numbers Photo positions map Hotel Maps 22 2015 FIA FORMULA ONE™ WORLD CHAMPIONSHIP Entry List Calendar Standings after round 16 (USA) (Drivers) Standings after round 16 (USA) (Constructors) Team & driver statistics (after USA) 33 HOW IT ALL STARTED 35 MEXICAN DRIVERS IN THE WORLD CHAMPIONSHIP 39 MÉXICO IN WORLD CHAMPIONSHIP CONTEXT 40 2015 SUPPORT RACES 42 BACKGROUNDERS BIENVENIDO A MÉXICO! It is a pleasure to welcome you all to México as we celebrate our country’s return to the FIA Formula 1 World Championship calendar. Twice before, from 1963 to 1970 and from 1986 to 1992, México City has been the scene of exciting World Championship races. We enjoy a proud heritage in the sport: from the early brilliance of the Rodríguez brothers, the sterling efforts of Moisés Solana and Héctor Rebaque to the modern achievements of Esteban Gutíerrez and Sergio Pérez, Mexican drivers have carved their own names in the history of the sport. A few of you may have been here before. You will find many things the same – yet different. The race will still take place in the parkland of Magdalena Mixhuca where great names of the past wrote their own page in Mexican history, but the lay-out of the 21st-century track is brand-new. -

ACES WILD ACES WILD the Story of the British Grand Prix the STORY of the Peter Miller
ACES WILD ACES WILD The Story of the British Grand Prix THE STORY OF THE Peter Miller Motor racing is one of the most 10. 3. BRITISH GRAND PRIX exacting and dangerous sports in the world today. And Grand Prix racing for Formula 1 single-seater cars is the RIX GREATS toughest of them all. The ultimate ambition of every racing driver since 1950, when the com petition was first introduced, has been to be crowned as 'World Cham pion'. In this, his fourth book, author Peter Miller looks into the back ground of just one of the annual qualifying rounds-the British Grand Prix-which go to make up the elusive title. Although by no means the oldest motor race on the English sporting calendar, the British Grand Prix has become recognised as an epic and invariably dramatic event, since its inception at Silverstone, Northants, on October 2nd, 1948. Since gaining World Championship status in May, 1950 — it was in fact the very first event in the Drivers' Championships of the W orld-this race has captured the interest not only of racing enthusiasts, LOONS but also of the man in the street. It has been said that the supreme test of the courage, skill and virtuosity of a Grand Prix driver is to w in the Monaco Grand Prix through the narrow streets of Monte Carlo and the German Grand Prix at the notorious Nürburgring. Both of these gruelling circuits cer tainly stretch a driver's reflexes to the limit and the winner of these classic events is assured of his rightful place in racing history. -

* 1:20 Lotus 88 * Bugatti T18 Kit * Maserati A6GCS * 1:24 Mk1 Escorts
* 1:20 Lotus 88 * Bugatti T18 Kit * Maserati A6GCS * 1:24 Mk1 Escorts * 2015 LM Ferraris 04-2016 NEWS Spark diecast Late Season MP4-30s Spark were the pioneers of what we now refer to as resincast models and have certainly contributed to significant changes in the model market since they first arrived on the scene some fifteen or so years ago. The tooling for resin production allows for far smaller quantities than traditional diecast metal and so we see many subjects that may not otherwise be viable due to potential sales figures. The lower numbers do mean higher prices however and for some subjects with more mass appeal, die-casting can still be the effective way of making a model and Spark have recognised this and are adding a new series to their catalogue (see forthcoming supplement), with much lower pricing (£27.95) than the resin production and innovative packaging to help them stand out. We saw the first test samples at Nurnberg in February and they are now approaching release. Ebbro’s 1:20 plastic kit of the mid-season McLaren from 2015 (EBB20014) has proved very popular and many builders are now eagerly awaiting the early season car (EBB20013). There’s another to add to the wish list now as, in ad- dition to the livery charge, the McLaren had a significant nose redesign from Austria and this will be represented by another new kit for the Japanese GP (EBB20015). The photo above shows the test mouldings alongside the mid- season car. 1:43 resincast releases of the late season car are also due for both Alonso (EBB45328) and Button (EBB45329). -

The Golden Age of Auto Racing Revisited Part 1 © October 22, 2014 Page 1 October 22, 2014
The Golden Age of Auto Racing Revisited Part 1 © October 22, 2014 Page 1 October 22, 2014 AONE PIZZA AND A MOVIE: The Golden Age of Auto Racing Revisited Part I -- 1948 through 1959 ©* By Phillip Bostwick Following the enthusiastic response to the showing of the motor racing film Rush at the Josiah Smith Tavern in Weston, Massachusetts last winter, AONE officers invested in additional movie and sound equipment and decided to host two motor racing films during the late fall and winter of 2014-2015. The dates for this winter’s “AONE Pizza and a Movie” events, and the movies to be shown, are: 1. Saturday, November 15, 2014 at 4:00 p.m. The Racers, a 1955 film starring Kirk Douglas, Bella Darvi, Gilbert Roland, Cesar Romero, Lee J. Cobb, and Katy Jurado. This movie is a few minutes short of two hours long and pizza will be brought in at the end of the film for an intermission. During the pizza break some excerpts from my collection of motor racing videos will be shown.† This thirty- eight minute special feature will show movies of some 1950s sport car races and some Formula One races in Europe during the fifties. 2. Saturday, January 10, 2015 at 4:00 p.m. Grand Prix, a 1966 film starring James Garner, Eva Marie Saint, Yves Montand and Toshiro Mifune-- directed by John Frankenheimer. This film is a few minutes short of three hours long with an intermission during the film. Pizza will brought in during that intermission. Following the film a short special will be shown which portrays how James Garner and the other movie stars were taught to -

Maser Story Template Blio AC
Maserati: In Search of the Road Cars By S. Scott Callan VELOCITY GROUP All Rights Reserved 2012 2014 2 INTRODUCTION well placed. The FE was neither a spindly and anemic voiturette, nor merely a reduction of IF’s 8liter, side valve, chain driven cars. It was an en tirely new category of car. Its chassis was Our focus here is on the road cars that light, but constructed in the robust Ital were to take Maserati to the public. It’s a ian manner. It’s engine was a single over classic redemption tale. From its compe head cam design, displacing 1208cc with tition focus and foundation it ascended shaft drive. With fenders and lights, a the international automotive firmament. road car, without, a racer. Its style & performance established a It is this latter sentence that defines the mythic reputation on the road, the cars to come from the young man at the printed page and in conversation. Fifty controls. Cars that went from circuit to years on, as the industrial sector shud road, pit to garage, with a swiftness that dered, factors external and internal left little time to reshape engineering or weighted its descent. And with the new temperament. To stand next to an early Century, resurrection. sixties 3500 coupe idling is visceral me As all industrial tales it is a complexity chanical intensity that soon has you rub of characters and event, engineering and bing the hairs on your arm as if they style, manufacturing and capital. have become possessed by static electric Recently I came across an old photo ity. -

Der Dreizack Der Dreizack
DAS MAGAZIN DES DEUTSCHEN MASERATI-CLUB e.. V.. DERDER DREIZDREIZAACKCK 1 /2016 · Ausgabe 50 www.deutschermaseraticlub.de DRUCK & MEDIEN SERVICE GmbH · Beratung · Konzeption · Design · Vorstufe · Web to print · UV-Direktdruck · Spezialdruck .wa-p.net · Offsetdruck · Digitaldruck · Siebdruck · Verpackungsdruck · Großformatdruck · Weiterverarbeitung · Veredelung · Werbemittel · Foliengrafik · Licht- & Werbetechnik · Mailing FASZINIERENDE · Logistik Pfälzer Str. 78 DRUCK 46145 Oberhausen Telefon: 02 08 / 62 95 4-0 Telefax: 02 08 / 62 95 4-44 e-mail: [email protected] ERLEBNISSE Internet: www.wa-p.net www.wa-p.net ANZEIGE_LINKE_SEITE.indd 1 27.04.16 15:50 INHALT 03 INHALT 04 IMPRESSUM 05 EDITORIAL/GRUSSWORT MERCATO VERANSTALTUNGEN 06 Auktionsergebnisse 48 Retromobile 08 Mercato I 52 Bremen 10 Mercato II LOCALITÀ DER CLUB 53 Curbs Club Cologne 12 Neujahrstreffen 13 Monatstreffen München Februar PICCOLO 14 Monatstreffen März 54 La Strada 1:18 16 Grande Tour des Alpes 18 Gelandet in Genf ARTE 20 Techno Classica 56 Ein neues Sammelgebiet IN MEMORIAM 26 Maria Teresa de Filippis NUEVO 36 Der Dicke 44 Maserati in Wuppertal 45 Maserati Fahrerkurse 46 Modena... adé 3 IMPRESSUM Ehrenmitglieder: Rolf Deichmann Peter Kaus Paul Pietsch † Maria-Theresa de Fillippis † Kurt Kiefer † DER DREIZACK Der Dreizack ist das offizielle Magazin des Deutschen Maserati-Club e.V. Herausgeber: Deutscher Maserati-Club e.V. (DMC) www.deutschermaseraticlub.de Sitz: Frankfurt am Main Vorstand: Manfred R. Just – Präsident c/o Agileum Verlag GmbH Landsberger Str. 480a · 81241 München Tel. 089-82073727 · [email protected] Stellvertreter: Wolfgang Karl – Vizepräsident Im Vogelsang 20 · 53179 Bonn Tel. 0228-362558 · Mobil 0178-4582454 · w.w.karl©t-online.de Schatzmeister: Hartmut Arens Grüne Schanze 5 · 15745 Wildau Mobil 0173 - 9 31 21 21 · Fax 0 33 75 - 5 26 16 37 [email protected] Club-Sekretariat: Manfred Meritz St.-Augustinus-Straße 54 · 53175 Bonn Tel.