Parco Sempione Guida Arbusti-Parte 1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Living the Unique
ELLE DECOR ITALIA FOR DOMUX HOME ELLE DECOR ITALIA PER DOMUX HOME LIVING THE UNIQUE Living in the Velasca Tower, an architectural icon in the heart of Milan. In unique residences with a view of the Duomo and the new city skyline. Flaunting an unparalleled charm ELLE DECOR ITALIA FOR DOMUX HOME Living in the heart of MILAN, in an icon of ARCHITECTURE: LIVING IN a building that symbolises the city, slap bang in the centre and a stone’s throw THE VELASCA away from the Duomo. Not just an exclusive structure. But the TOWER ultimate symbol of ITALIAN flair and style A glimpse of the foyer on the ground floor, surrounded by custom-designed fine wood pannelling and a number of enormous chandeliers, all by BBPR. Opposite page, a striking shot of the Velasca Tower, the 106-metre tall building designed by Belgiojoso, Banfi, Peressutti, Rogers and built between 1956 and 1958. ELLE DECOR ITALIA FOR DOMUX HOME Functionality, comfort, prestige. The VELASCA TOWER, the unmistakeable architectural mark of Milan, interprets the style of contemporary living Designed in the 1950s by BBPR, one of the masters of Italian 20th century architecture, the Velasca Tower is a building with both a location and dimensions – 106 metres in height with a full view of the Milanese skyline– that display decidedly spellbinding characteristics when it comes to functionality, comfort and prestige. Stretching along Via Larga, Corso Italia, Corso di Porta Romana, the spectacular silhouette of the building has always attracted and fascinated passers-by who can appreciate its unusual, engaging shape even more. -

LEZIONE 9 – Dal Cordusio Al Castello Sforzesco (DIA 1)
LEZIONE 9 – Dal Cordusio al Castello sforzesco (DIA 1) ( DIA 2) Il nuovo itinerario di Milano che iniziamo oggi parte da piazza Cordusio, prosegue per via Dante, per raggiungere infine il castello sforzesco con le sue gallerie d’arte. Usciti poi dal castello, inizieremo la visita del Parco Sempione, il più grande giardino pubblico all’interno delle mura spagnole, con l’acquario, l’Arena, l’arco della Pace, e il palazzo dell’Arte. Ritorneremo poi in via Dante attraverso via Boccaccio, la stazione delle Ferrovie Nord Milano, il teatro e il palazzo Dal Verme. Piazza Cordusio ( DIA 3) ) è una delle più importanti piazze milanesi, anche per funzione viabilistica e strategiche. È da sempre centro storico e nevralgico della città, di elevato rilievo storico e artistico. Crocicchio già in epoca imperiale, il Cordusio divenne importante con l’avvento dei Longobardi. Infatti, trent’anni dopo la distruzione di Milano (538-539) ad opera degli Ostrogoti, scende in Italia nel 569, il re dei Longobardi, Alboino. Da allora l’area divenne Langobardia, e in seguito Lombardia. Con la scomparsa di Alboino nel 572, la Provincia venne divisa fra i tre generali (che divennero duchi). Ad Albino toccò la “desolata Milano”. Il suo palazzo, che sorgeva nell’odierna piazza, era detto “De curte ducis” (o “Curia ducis“, ossia la corte dei duchi lombardi), da cui per corruzione “Cortedoxi“, quindi “Corduce” e infine “Corduso” o “Cordusio“. La corte ducale venne subito soppiantata dal nuovo palazzo del Broletto vecchio (Palazzo Reale) e il palazzo al Cordusio venne smembrato e probabilmente attraversato dalla contrada delle Galline. -
Welcome to Milan
WELCOME TO MILAN WHAT MILAN IS ALL ABOUT MEGLIOMILANO MEGLIOMILANO The brochure WELCOME TO MILAN marks the attention paid to those who come to Milan either for business or for study. A fi rst welcome approach which helps to improve the image of the city perceived from outside and to describe the city in all its various aspects. The brochure takes the visitor to the historical, cultural and artistic heritage of the city and indicates the services and opportunities off ered in a vivid and dynamic context as is the case of Milan. MeglioMilano, which is deeply involved in the “hosting fi eld” as from its birth in 1987, off ers this brochure to the city and its visitors thanks to the attention and the contribution of important Institutions at a local level, but not only: Edison SpA, Expo CTS and Politecnico of Milan. The cooperation between the public and private sectors underlines the fact that the city is ever more aiming at off ering better and useable services in order to improve the quality of life in the city for its inhabitants and visitors. Wishing that WELCOME TO MILAN may be a good travel companion during your stay in Milan, I thank all the readers. Marco Bono Chairman This brochure has been prepared by MeglioMilano, a non-profi t- making association set up by Automobile Club Milan, Chamber of Commerce and the Union of Commerce, along with the Universities Bocconi, Cattolica, Politecnico, Statale, the scope being to improve the quality of life in the city. Milan Bicocca University, IULM University and companies of diff erent sectors have subsequently joined. -

Parco Sempione
Sesto San Giovann FSi Cormano SESTO SAN GIOVANNI BRESSO PARCO NORD Cormano Brusuglio Sesto Rondò TANGENZIALE NORD VIALE FULVIO TESTI RHO Comasina Bruzzano NOVATE Bignami 500 m A8 MILANO LAGHI A4 TORINO MILANO 500 m Sesto Marelli Rho A.V./S.F.R. Affori FNM Ponale Affori FNM PARCO NORD Cologno Sud VIA GIUDITTA PASTA Rho Fiera Quarto Oggiaro VIALE MONZA VIA ARGANINI VIA SBARBARO BIGLIA DEI CONTI VIA BRUSUGLIOVIA CHIANCIANO VIALE ESPERIA VIALE FULVIO TESTI Villa San Giovanni VIA ZANOLI Bicocca VIA PELLEGRINO ROSSI TEATRO VIA GREGOROVIUS ARCIMBOLDI A4 TORINO MILANO VIA VOCHIERI VIA ARMELLINI VIA E. MAJORANA VIA MONETA VIA Affori Centro VIA CAMOVALI VIA RACCONIGIMONTEROTONDO VIA SEMERIA VIA CHIASSERINI VIA VIA DON CARLO PORRO VIA GILINO Greco VIA BALZAC POZZUOLI VIA VIA PASTRO VIA CISLAGHI MPANA CORRADO VIA GRIOLI CA VIA SCIALOIA VIA BETTINI VIA CIRI VIA REBORA VIA DEI VIA Pirelli VIA ZAMBRINI VIA PONTE NUOVO VIA COZZI DUMAS VIA PEDRONI È VIA DEMONTE VIA BREDA VIA RUCELLAI I ZZIN VIA GIROLAVIA SANTHIÀ Precotto VIA LINATI A VIA DON LUIGI GUANELLA COR VIA PAVESE VIA VIA VIPITENO VIA APELLE VIA BAZZARO VIA TÜKORI VIA VIGNATI VIA VIA VAL GARDENA VIA SCARSELLINI VIA FRATELLI BRESSAN VIA POMPEO VIA CIALDINI VIA VAL DI FIEMME VIA G. B. VIA SAN BASILIO PALLETTA VIA MONCALIERI VIA VAL DI NON VIA BAVENO Cascina Gobba Pero VIA VAL MARIA VIALE DELL’INNOVAZIONE VIA EMILIO DE MARCHI VIA MAMBRETTI MAIRA VIA ERODOTO PIAZZALE B. GRAZIOLI VIA SALVATORE PIANELL MARTESANA VIA VAL CAMONICA VIA DEL RICORDO VIA CANDOGLIA VIA CHERASCO VIA I VIA EMILIO N I DE MARTINO L VIA TRIBONIANO VIA BELLAZZI VIA FRACASTORO VIA DON VIA VIA BREDA VIA CARLO MORESCHI VIALE CÀ GRANDA L VIA CAROLI VIA ARISTOTELE CIRENEI VIA PALIZZI VIA DON G. -
City Guide Milano for Special Needs Travelers Per Viaggiatori Con Mobilità Ridotta
where® GuideS CITY GUIDE MILANO FOR SPECIAL NEEDS TRAVELERS PER VIAGGIATORI CON MOBILITÀ RIDOTTA FRIENDLY AIRPORTS FOR A FRIENDLY CITY THE CITY OF EXPO Il progetto Where Milan è patrocinato da INDEX / SOMMARIO Milan: a city to be LANDMARKS / LUOGHI DI INTERESSE Duomo, the symbol of Milan discovered and experienced Il Duomo, simbolo di Milano p. 3 Although Italy boasts a plethora of ‘art cities’, few people Galleria, the “living room” of the Milanese La Galleria, il “salotto” dei Milanesi p. 4 are likely to list Milan as one of them. Known as the capital of fashion, design and business, the city also hosts an Teatro alla Scala and its square unexpected treasure trove of artistic marvels. As well Il Teatro alla Scala e la sua piazza p. 4 as famed and fabled masterpieces and monuments, The Castle in the heart of Milan Milan is also home to the Duomo, La Scala Opera House, Il Castello nel cuore di Milano p. 6 Leonardo’s Last Supper, Castello Sforzesco, imposing “The Last Supper” and Santa Maria delle Grazie Romanesque churches, museums brimming over with “L’Ultima Cena” e Santa Maria delle Grazie p. 6 priceless artworks as well as the recent introduction of Porta Nuova, a new exclusive urban space some amazing contemporary architecture. This guide aims Porta Nuova, un distretto all’avanguardia p. 8 to show you that side of Milan, and lots more besides, San Siro Stadium, temple of football i.e. an accessible Milan. On the pages that follow you Stadio San Siro, tempio del calcio p. 8 will find a collection of must-visit museums and tourist attractions that are accessible to everyone, plus a series MUSEUMS / MUSEI of useful information detailing how to get around Expo Palazzo Reale p. -
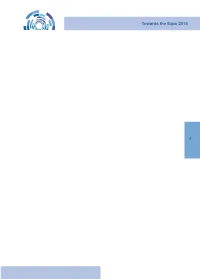
Towards the Expo 2015
Towards the Expo 2015 1 Towards the Expo 2015 An Expo is a large international event that aims at the enrichment of human knowledge and technological progress, to promote cooperation and dialogue with international press. Given the importance of these major events, for almost a century now the need has arisen to standardise some aspects, such as duration, frequency and above all quality. The Bureau International des Expositions (BIE), established in 1928 with the International Convention of Paris is the international organisation responsible for establishing the parameters that control the Expo; the objective of the BIE is therefore to guarantee continuity of these events and maintain the level of international prestige earned over the years, selecting venues and dates and organising new Expos. The members of this organisation, with official headquarters in Paris, are all the States that have signed the convention. There are two different types of Expo: "Universal Expositions" (World Expo) and "International Expositions" (International Expo). The Expositions in the first category involve topics that concern the whole of humanity and therefore are global in nature. States, International Organisations, NGOs, Companies and other institutions can participate in these events, there is no limit to the size of the Exposition venue, and participants arrange the set-up of their own pavilions. Since 1996 these events have lasted six months and take place every five years. A Universal Expo will take place in Milan in 2015. 122 On the other hand the “International Expositions" take place in the period between the two Universal Expos and last for three months. The possible participants are the same as for a Universal Expo while the theme is more specific. -

Milan and the Lakes Travel Guide
MILAN AND THE LAKES TRAVEL GUIDE Made by dk. 04. November 2009 PERSONAL GUIDES POWERED BY traveldk.com 1 Top 10 Attractions Milan and the Lakes Travel Guide Leonardo’s Last Supper The Last Supper , Leonardo da Vinci’s 1495–7 masterpiece, is a touchstone of Renaissance painting. Since the day it was finished, art students have journeyed to Milan to view the work, which takes up a refectory wall in a Dominican convent next to the church of Santa Maria delle Grazie. The 20th-century writer Aldous Huxley called it “the saddest work of art in the world”: he was referring not to the impact of the scene – the moment when Christ tells his disciples “one of you will betray me” – but to the fresco’s state of deterioration. More on Leonardo da Vinci (1452–1519) Crucifixion on Opposite Wall Top 10 Features 9 Most people spend so much time gazing at the Last Groupings Supper that they never notice the 1495 fresco by Donato 1 Leonardo was at the time studying the effects of Montorfano on the opposite wall, still rich with colour sound and physical waves. The groups of figures reflect and vivid detail. the triangular Trinity concept (with Jesus at the centre) as well as the effect of a metaphysical shock wave, Example of Ageing emanating out from Jesus and reflecting back from the 10 Montorfano’s Crucifixion was painted in true buon walls as he reveals there is a traitor in their midst. fresco , but the now barely visible kneeling figures to the sides were added later on dry plaster – the same method “Halo” of Jesus Leonardo used. -

Milano-100-Lieux-A-Visiter.Pdf
Comune di Milano Touring Club Italiano Settore Politiche del Turismo Corso Italia, 10 e Marketing territoriale 20122 Milano via Dogana, 2 Direzione Centro Studi 20121 Milano Maria-Chiara Minciaroni Direttore Matteo Montebelli Massimiliano Taveggia Massimiliano Vavassori Jacopo Zurlo Servizio Sviluppo e Monitoraggio del Turismo Sergio Daneluzzi Servizio Digital e Web Marketing Patrizia Bertocchi www.turismo.milano.it Milan Progetto grafico Crediti fotografici Alessandro Gandini, Milka Gandini Arcidiocesi di Milano; Mauro Colella; Gandini&Rendina grafica e pubblicità srl Comune di Milano (Galleria d’Arte Moderna, Biblioteca Comunale Centrale “Palazzo Impaginazione e digitalizzazione Sormani”); R. Longoni; Giorgio Majno; Gandini&Rendina grafica e pubblicità srl Franco Mascolo; Museo Poldi Pezzoli; Icone e mappe Navigli Lombardi s.c.a.r.l.; Andrea Scuratti; Gandini&Rendina grafica e pubblicità srl Václav Šedý; Veneranda Biblioteca Ambrosiana; VRWAY Communication - Giuseppe Pennisi Copertina Comune di Milano LIEUX A VISITER 100 LIEUX A VISITER THEMES Bibliothèques Parcs et jardins Monuments historiques Places Edifices religieux Portes Installations sportives Points de vue panoramiques Monuments de l’Antiquité Espaces d’expositions Musées Théâtres et auditoriums Canaux Villas Palais Sites remarquables signalés par le Touring Club Italiano www.touringclub.it 100 LIEUX A VISITER THEMES Bibliothèques Edifices religieux Palazzo dell’Ambrosiana - Biblioteca e Pinacoteca Duomo di Milano Ca’ Granda Università degli Studi di Milano Chiesa di Santa Maria Annunciata in Camposanto Palazzo Moriggia Museo del Risorgimento (Palazzo della Veneranda Fabbrica) Castello Sforzesco Chiesa di Sant’Alessandro (Piazza Sant’Alessandro) Palazzo dell’Arte Chiesa di Santa Maria presso San Satiro Museo Civico di Storia Naturale Chiesa di Santa Maria dei Miracoli Conservatorio di Musica “G. -

Itineraries Through Milan's Architecture
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MILANO DELLA PROVINCIA DI MILANO /types form, function, meaning in architecture High-rise Milan Fulvio Irace, Federico Ferrari Itineraries through Milan’s architecture Modern architecture as a description of the city “Itineraries through Milan’s Architecture: Modern Architecture as Description of a City” is a project by The Order of Architects of the Province of Milan, organized by its Foundation Scientific Coordinator: Maurizio Carones Managing Director: Paolo Brambilla Editorial Staff: Alessandro Sartori, Stefano Suriano General Manager: Giulia Pellegrino Press Office Ferdinando Crespi “High-rise Milan” Federico Ferrari, Fulvio Irace edited by: Alessandro Sartori, Stefano Suriano, Barbara Palazzi back cover: Studio BBPR, Velasca Tower, longitudinal section, 1951-1958 © BBPR Archive For copyrights regarding any unidentified iconographic materials, please contact the Foundation of the Order of the Architects, Planners, Landscape Architects and Conservators of the Province of Milan www.ordinearchitetti.mi.it www.fondazione.ordinearchitetti.mi.it High-rise Milan Federico Ferrari The high-rise building has always represented one of the themes par excellence of the modernity. The suggestion exercised by the American examples has been one of the strong suits of the Modern Movement, at least since the celebrated journey of Le Corbusier in the United States. Mesmerised by the dream of the vertical metropolis that would free man from the suffocating density of the traditional city, the Swiss architect pushed humanity to embrace without hesitation the skyscraper typology. A symbolic representation of a “drive toward the sky,” as the Promethean effort to annul the restrains of the gravity force, “the skyscraper can be considered as the model of the building magnificence typical of the homo faber of the twentieth century”(1). -

January 2020
MILAN CITY GUIDE ® JANUARY 2020 WWW.WHEREMILAN.COM SERRAVALLE DESIGNER OUTLET The only sales that matters from 4th January Surprising 米兰旅行免费指南 January ALL YOU CAN DO IN THE CITY 扫码使用体验 米兰小程序 SIGHTSEEING | MUSEUMS | SHOPPING | DINING | ENTERTAINMENT | MAPS SERRA0051_07_AW19_Serravalle_Press_DPS_Where Milan_414x277mm_AW.indd All Pages 13/12/2019 14:57 Client - McAG Type Area - N/A Initials - GR Outlet - Serravalle Bleed - 3mm Scale - 100 Ad Type - Press Date - 13–12–2019 Effective DPI - 300 Publication - Where Milan File Name -SERRA0051_07_AW19_Serravalle_Press_DPS_Where Milan_414x277mm_AW Size - 414x277mm DISCOVER Milan January 2020 Riccardo Muti 12 INSIDER TIPS the guide 26 SHOPPING An iconic sign in gold leaf on a black background has marked the presence of the Borsalino brand in the heart of the Galleria for over 136 years. 48 DINING Enrico Bartolini al Mudec Welcome to Iyo Aalto, a tribute to the Land of the Rising Sun, ENJOY located in Porta ENTERTAINMENT 54 Camparino Nuova district. in Galleria 54 ENTERTAINMENT The historic Camparino in Galleria has re-opened after a meticulous 8 HOT DATES structural and conceptual restyling. 56 SIGHTSEEING MILAN CITY GUIDE ® & MUSEUMS Contents The Basilica di JANUARY 2020 WWW.WHEREMILAN.COM SERRAVALLE DESIGNER OUTLET Sant’Eustorgio, the The only sales that matters from 4th January ancient headquarters 6 TOP IN TOWN 19 NEW OPENINGS of Milan’s Domenican Discover the city, starting Keep up-to-date with Order, hosts the Portinari from its main landmark the latest luxury openings Chapel, a masterpiece of Surprising attractions and several in the city. Lombard Renaissance. 米兰旅行免费指南 January ALL YOU CAN DO IN THE CITY not to be missed events in 2020. -

EVENTI EVENTS FEBBRAIO \ FEBRUARY 2010 La Triennale Di Milano ROY LICHTENSTEIN Meditaɵons On
FEBBRAIO \ FEBRUARY 2010 EVENTI 350 EVENTS La Triennale di Milano ROY LICHTENSTEIN MeditaƟ ons on Art © Estate of Roy Lichtenstein of Roy © Estate 30° 201018-21 febbraio BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO Travel instinct. 1+1 1 PRE-REGISTRATO + scopri come su 1 INGRESSO GRATUITO www.bit.fieramilano.it O INDICE/INDEX BENVENUTI 4 WELCOME SPECIALE BIT 2010 7 BIT 2010 ARTE 16 ART FOTOGRAFIA 23 PHOTOGRAPHY VISITE GUIDATE 26 GUIDED TOURS TEATRO ALLA SCALA 29 SCALA OPERA HOUSE MUSICA CLASSICA 32 CLASSICAL MUSIC MUSICA NELLE CHIESE 40 MUSIC IN THE CHURCHES MUSICA JAZZ 41 JAZZ MUSIC MUSICA LIVE 43 LIVE MUSIC TEATRO 47 THEATRE BALLETTO 58 BALLET CINEMA 59 CINEMAS FIERA MILANO 60 TRADE FAIRS IN MILAN FIERE & MERCATI 62 FAIRS & MARKETS SPORT & TEMPO LIBERO 67 SPORTS & LEISURE SAGRE E FOLCLORE 69 FOLK EVENTS = orari/hours = chiusura/closed = prezzo/price = informazioni/informa on = inaugurato questo mese/new 3 BENVENUTI Proge ed inizia ve per un futuro migliore. Plans and ini a ves for a be er future. gni giorno che spunta, desidera il nuovo” (Fr. Bodenstedt) e di sicuro, con l’inizio del 2010, ognuno di noi ha fa o proposi , proge ed ha delle “Oaspe a ve per il nuovo anno. Per quanto riguarda la Provincia di Milano, anche in questo numero di MilanoMese, vi presen amo occasioni di ritrovo, di intrat- tenimento culturale, sociale ed inizia ve di valorizzazione del nostro territorio. Tra gli interven concre che abbiamo in ques mesi a uato ci sono nuove piste ciclabili nel territorio della Provincia e proge per migliorare la viabilità, inoltre ripar rà a maggio anche un servizio di trasporto sui Navigli e sono al vaglio tu a una serie di proge per la riqualifi cazione del patrimonio edilizio della Provincia. -

Light Nova | Lighting Light Nova Is One of Neri’S Most Innovative Products in Terms of Lighting Performance and Design
Milano (Italia) | Light Nova | Lighting Light Nova is one of Neri’s most innovative products in terms of lighting performance and design. Designed by our team and tested in our labs, it combines a vintage look with the highest quality LED technology. Light Nova rappresenta l’evoluzione stilistica e illuminotecnica più innovativa del 2014-2015 in Neri. Una forma contemporanea con riferimenti alla storia e una tecnologia LED di alta qualità, progettata e verificata nei laboratori Neri. Milano (Italia) | Light Nova | Lighting Milano (Italia) | Light Nova | Lighting Milano (Italia) | Light Nova | Lighting Milano (Italia) | Light Nova | Lighting Light Nova Expo 2015 Milano (Italia) | Light Nova | Lighting Light Nova Expo 2015 Light Nova has been chosen by A2A to light the streets of Milan by replacing the old suspended luminaire catenary mounted, installed under colonnades or on posts. 8000 pieces had been installed since now in Milan getting ready for the Expo 2015. Light Nova è stato scelto da A2A per l’illuminazione delle vie di Milano in sostituzione ai vecchi corpi illuminanti a sospensione applicati su tesata al centro strada, su pastorali o mensola e sotto i portici. Sono 8000 gli esemplari di Light Nova che illuminano ora Milano per Expo 2015. Milano (Italia) | Light Nova | Lighting Milano (Italia) | Light Nova | Lighting Light Nova in Milan Milano (Italia) | Light Nova | Lighting Light Nova in Milan Light Nova now lights the most prestigious places in Milan from the colonnade of Piazza Duomo to Castello Sforzesco, from the main train station to Arco della Pace, from Parco delle Basiliche di Sant’Eustorgio e San Lorenzo to Parco Sempione, from Museo del Novecento to Foro Bonaparte and Porta Garibaldi.