11692687.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rome and Imperialism
1 Rome and Imperialism expansion, so as to avoid importing con- 2 notations of competing hegemonies led by 3 modernising nation states (Veyne 1975): 4 those who follow Lenin’s notion of impe- 5 Rome in the history of rialism as a distinct stage of capitalism 6 imperialism (1934) would also have to reject the label as 7 Rome has long occupied a central place in it applied to Rome. 8 the theorisation of empire. One reason is that In practice it is not feasible to dispense with 9 imperial symbols and language – eagles, fas- the labels ‘empire’ and ‘imperialism’, as simi- 10 ces, laurel wreaths, and the Latin titulature of lar problems face any alternative terminol- 11 empire – have been repeatedly appropriated ogy. The most thoughtful recent approaches 12 in the Western tradition by expanding powers treat Rome as one of number of similar 13 and states. The Frankish King Charlemagne political entities often termed early empires. 14 had himself crowned emperor by the Pope Depending on the focus of the analysis 15 in Rome in 800. The title Kaisar (Caesar) was these are often qualified as tributary empires 16 used by the rulers of successive German (in relation to their political economy) or 17 emperors in the Middle Ages, and Czar by pre-capitalist or pre-industrial if their eco- 18 various Eastern European powers up to and nomic life or technology seems more impor- 19 including the rulers of Russia. Medieval tant. Broadly similar to Rome would be the 20 appropriations related as much to the contem- sequence of Chinese empires that began in 21 porary presence of the emperors of Byzantium 221 BCE with the creation of the Qin dynasty, 22 (who continued to be Caesars and to rule a a series of empires based on the Iranian pla- 23 Roman Empire into the 15th century) as to any teau including those of the Achaemenid, 24 close connection with earlier periods. -

Calendario Romanistico (Ultimo Aggiornamento : 19 Novembre 2016)
Calendario romanistico (ultimo aggiornamento : 19 novembre 2016) A cura di Enrico Sciandrello 03.12.2016 Bologna “L’intelligenza della storia. Seminario per Aldo Schiavone”: interventi di Maria Cecilia d’Ercole (Il “mestiere dello storico”), Jean-Louis Ferrary (Antichistica e storiografia giuridica), Massimo Brutti (La storia dei giuristi), Ernesto Galli della Loggia (Impegno politico e cultura nell’Italia contemporanea), Roberto Espo- sito (Filosofia e diritto romano). Palazzo Malvezzi, Sala delle Armi. 02.12.2016 Trento Letture romanistiche ELR: discussione del volume di Julia Gokel, ‘Sprachliche Indizien für inneres System bei Q. Cervidius Scaevola’ con Valerio Marotta. Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza. 01-02.12.2016 Parma Per l’Associazione di Studi Tardoantichi Convegno su “Miseratio e perdono in età tardoantica: virtus o vitium? Prospettive storiche, giuridiche e sociali e realtà territoriale”: interventi (giovedì 1) di Adriaan Johan Boudewijn Sirks (Miseri- cordia nella Gallia del V e VI secolo), Elio Dovere (La remissio tributi nella Hi- storia di Evagrio sec. V), Serena Palma (La visione di miseratio e remissio in Cipriano), Laura Solidoro (Perdono e riabilitazione delle prostitute), Lucietta Di Paola (Alcune riflessioni sulla lenitas imperiale e sui suoi effetti in età tardoanti- ca), Ugo Criscuolo (Miseratio pauperum nel Tardoantico), Letteria De Salvo (Colpa e indulgenza [amartema e synchoresis]: lessico cristiano o burocratico? A proposito di Eus. VC 2. 24-42), Maria Elvira Consoli (Concezione e -

Quod Omnium Nationum Exterarum Princeps Sicilia
Quod omnium nationum exterarum princeps Sicilia A reappraisal of the socio-economic history of Sicily under the Roman Republic, 241-44 B.C. Master’s thesis Tom Grijspaardt 4012658 RMA Ancient, Medieval and Renaissance Studies Track: Ancient Studies Utrecht University Thesis presented: June 20th 2017 Supervisor: prof. dr. L.V. Rutgers Second reader: dr. R. Strootman Contents Introduction 4 Aims and Motivation 4 Structure 6 Chapter I: Establishing a methodological and interpretative framework 7 I.1. Historiography, problems and critical analysis 7 I.1a.The study of ancient economies 7 I.1b. The study of Republican Sicily 17 I.1c. Recent developments 19 I.2. Methodological framework 22 I.2a. Balance of the sources 22 I.2b. Re-embedding the economy 24 I.3. Interpretative framework 26 I.3a. Food and ideology 27 I.3b. Mechanisms of non-market exchange 29 I.3c. The plurality of ancient economies 32 I.4. Conclusion 38 Chapter II. Archaeology of the Economy 40 II.1. Preliminaries 40 II.1a. On survey archaeology 40 II.1b. Selection of case-studies 41 II.2. The Carthaginian West 43 II.2a. Segesta 43 II.2b. Iatas 45 II.2c. Heraclea Minoa 47 II.2d. Lilybaeum 50 II.3. The Greek East 53 II.3a. Centuripe 53 II.3b. Tyndaris 56 II.3c. Morgantina 60 II.3d. Halasea 61 II.4. Agriculture 64 II.4a. Climate and agricultural stability 64 II.4b. On crops and yields 67 II.4c. On productivity and animals 70 II.5. Non-agricultural production and commerce 72 II.6. Conclusion 74 Chapter III. -

A COMPANION to the ROMAN ARMY Edited By
ACTA01 8/12/06 11:10 AM Page iii A COMPANION TO THE ROMAN ARMY Edited by Paul Erdkamp ACTA01 8/12/06 11:10 AM Page i A COMPANION TO THE ROMAN ARMY ACTA01 8/12/06 11:10 AM Page ii BLACKWELL COMPANIONS TO THE ANCIENT WORLD This series provides sophisticated and authoritative overviews of periods of ancient history, genres of classical lit- erature, and the most important themes in ancient culture. Each volume comprises between twenty-five and forty concise essays written by individual scholars within their area of specialization. The essays are written in a clear, provocative, and lively manner, designed for an international audience of scholars, students, and general readers. Ancient History Published A Companion to the Roman Army A Companion to the Classical Greek World Edited by Paul Erdkamp Edited by Konrad H. Kinzl A Companion to the Roman Republic A Companion to the Ancient Near East Edited by Nathan Rosenstein and Edited by Daniel C. Snell Robert Morstein-Marx A Companion to the Hellenistic World A Companion to the Roman Empire Edited by Andrew Erskine Edited by David S. Potter In preparation A Companion to Ancient History A Companion to Late Antiquity Edited by Andrew Erskine Edited by Philip Rousseau A Companion to Archaic Greece A Companion to Byzantium Edited by Kurt A. Raaflaub and Hans van Wees Edited by Elizabeth James A Companion to Julius Caesar Edited by Miriam Griffin Literature and Culture Published A Companion to Catullus A Companion to Greek Rhetoric Edited by Marilyn B. Skinner Edited by Ian Worthington A Companion to Greek Religion A Companion to Ancient Epic Edited by Daniel Ogden Edited by John Miles Foley A Companion to Classical Tradition A Companion to Greek Tragedy Edited by Craig W. -

PDF Hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen
PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/29339 Please be advised that this information was generated on 2021-09-29 and may be subject to change. THE CORN SUPPLY OF THE ROMAN ARMIES DURING THE THIRD AND SECOND CENTURIES B.C.1 Introduction A major role in the corn supply of the Roman armies, from at least the third century B.C. on, is ascribed to large scale contractors, who took care of all aspects of organization, administration and execution. In Badian’s influential study of these private entrepreneurs, it is supposed that the feeding of the Roman armies exceeded the capabilities of the Roman governmental apparatus; as a result, the state in Republican times had to rely on private enterprise.2 The role given to private entrepreneurs assumes that private trade was capable of supplying and distributing huge amounts of corn without much difficulty. On the other hand, the capabilities of the Roman governmental structure seem very limited. The question whether indeed it was private business and not the Roman state itself that managed the corn supply of the Roman armies is important for our understanding of the Roman wars, the state and private trade in this period. It is the purpose of this paper to show that the evidence furnished for the role of large scale contractors in the corn supply of the armies is inadequate. The sources provide ample evidence of other means the Roman government had to acquire corn for its armies. -

Encyclopaedia Britannica, 11Th Edition, Volume 5, Slice 5 - "Cat" to "Celt"
Encyclopaedia Britannica, 11th Edition, Volume 5, Slice 5 - "Cat" to "Celt" By Various English A Doctrine Publishing Corporation Digital Book This book is indexed by ISYS Web Indexing system to allow the reader find any word or number within the document. Transcriber's notes: (1) Numbers following letters (without space) like C2 were originally (2) Characters following a carat (^) were printed in superscript. (3) Side-notes were relocated to function as titles of their respective (4) Macrons and breves above letters and dots below letters were not (5) [oo] stands for the infinity symbol. (6) The following typographical errors have been corrected: Article CATALONIA: "There is much woodland, but meadows and pastures are rare." 'There' amended from 'These'. Article CATALYSIS: "It seems in this, as in other cases, that additional compounds are first formed which subsequently react with the re-formation of the catalyst." 'additional' amended from 'addition'. Article CAVALRY: "... and as this particular branch of the army was almost exclusively commanded by the aristocracy it suffered most in the early days of the Revolution." 'army' amended from 'arm'. Article CECILIA, SAINT: "It was long supposed that she was a noble lady of Rome 594 who, with her husband and other friends whom she had converted, suffered martyrdom, c. 230, under the emperor Alexander Severus." 'martyrdom' amended from 'martydom'. Article CELT: "Two poets of this period, whom an English writer describes as 'the two filthy Welshmen who first smoked publicly in the streets,' -
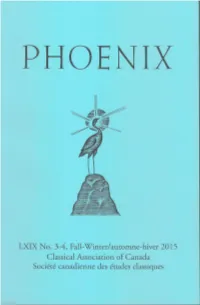
Qt5tg9d6n1 Nosplash 4B5de97
COOPERATION AND CONFLICT BETWEEN GOVERNOR AND POLEIS IN THE VERRINES Laura Pfuntner i. reading the VERRINES from a sicilian perspective In august 70 b.c., in his first appearance as a prosecutor, Cicero presented his case against Gaius Verres, governor of Sicily from 73 to 71, in the quaestio de repetundis in Rome.1 Cicero did not have the chance to complete his prosecution, however, since Verres abandoned his defense after the first hearing of the case and went into exile in Massilia. Cicero’s success against Verres undoubtedly enhanced his reputation as an orator, and he capitalized upon it by publishing the speech (the Divinatio in Caecilium) that had won him the right to prosecute, his speech from the first hearing, and five speeches he represented as the ones he had given in the second hearing, though it had not taken place. The speeches purporting to be from the second hearing of Verres’ trial are the longest works in the surviving Ciceronian corpus,2 and they are valuable sources for many aspects of late republican history and culture. As he describes Verres’ alleged crimes as governor in the second, third, fourth, and fifth speeches of this second actio, Cicero also provides a detailed account of many aspects of life in Roman Sicily.3 Mostly, and most naturally, scholars have read the speeches from a Roman perspective: as examples of Cicero’s development as an orator, and for the insight they provide into the political climate of the late 70s b.c.4 When scholars consider the Sicilians who populate the second set of Verrine orations, it is also usually from the perspective of Rome, with an emphasis on their patronage relationships with Roman senators and magistrates.5 The All parenthetical citations in the text and footnotes refer to the second actio of Cicero’s In Verrem, unless otherwise noted. -

Alonso Jjurp 2013
Zurich Open Repository and Archive University of Zurich Main Library Strickhofstrasse 39 CH-8057 Zurich www.zora.uzh.ch Year: 2013 Customary law and legal pluralism in the Roman Empire: The status of peregrine law in Egypt: Customary law and legal pluralism in the Roman Empire Alonso, José Luis Abstract: As we know since Ludwig Mitteis, Egypt’s incorporation to the Roman Empire brought little change to the legal practice of the local population. Since the province lacked autonomous courts, this would not have been possible without the consistent endorsement of this ’peregrine’ law by the Roman jurisdiction - an endorsement fully confirmed by the abundant available evidence. The political rationale behind this Roman attitude is clear enough, and entirely consistent with the general imperial policy of minimum intervention. And yet, within the Greco-Roman political tradition, that required a civitas for the existence of a ius civile, the legal status of this peregrine law - in a province that lacked civitates proper until 200 ce, and whose inhabitants were mostly peregrini nullius civitatis - is a theoretical puzzle. Hans Julius Wolff has maintained that it was, strictly speaking, no law at all: the fall of thePtolemies deprived it of all its binding force, as the occasional instances of Roman rejection (notably in P. Oxy. n 237, the famous petition of Dionysia) would corroborate; from the point of view of the Roman jurisdiction, there was in Egypt, Wolff argued, a legal vacuum to be filled at discretion. Joseph Mélèze Modrzejewski, instead, has insisted on the pertinence here of the notion of customary law: the local legal traditions, as well as the Ptolemaic legislation, were reduced to customary law, persisted as a merely tolerated mos regionis. -
![[Type the Document Title]](https://docslib.b-cdn.net/cover/1844/type-the-document-title-3301844.webp)
[Type the Document Title]
AUGUSTUS AND THE ROMAN PROVINCES OF IBERIA Thesis submitted in accordance with the requirements of the University of Liverpool for the degree of Doctor in Philosophy by David Griffiths September 2013 To my parents. Table of Contents List of figures ........................................................................................................................... iii Abstract ...................................................................................................................................... v Acknowledgements .................................................................................................................. vii Introduction ................................................................................................................................ 1 Chapter 1: Militarism and the princeps: The Cantabrian War and its meaning for Augustus ... 6 1.1 The campaigns ................................................................................................................. 6 1.2 The motives for the campaigns ...................................................................................... 13 1.3 The political context of the war ..................................................................................... 18 1.4 The contemporary literary treatment of the war ............................................................ 27 1.5 The ghost of Antonius .................................................................................................... 33 1.6 The autobiography ........................................................................................................ -
Cambridge University Press 978-1-108-42901-6 — Institutions And
Cambridge University Press 978-1-108-42901-6 — Institutions and Ideology in Republican Rome Edited by Henriette van der Blom , Christa Gray , Catherine Steel Index More Information Index Accius, L. Aquillius, M’. (cos. 129 bc), 42 author of fabula praetexta entitled Brutus, Aquillius, M’. (cos. 101 bc), 308 275–6 Arruntius, L. (cos. 22 bc), 82 Aemilius Lepidus, M. (cos. 78 bc), 109 Asconius Pedianus, Q. (Roman historian), Aemilius Lepidus, M. (triumvir), 168 172, 215 Aemilius Philemon, M. (freedman on assassination of Clodius and its of M. Lepidus), 121 aftermath, 121 Aemilius Scaurus, M. (pr. 56 bc), 72 on C. Cornelius’ dismissal of contio Alexander the Great (67 bc), 243 likeness of Pompeius to, 75 on C. Manilius’ occupation of Capitol (67 bc), Annaeus Florus, L., 59, 196 240–3 Annaeus Lucanus, M. on Cato, 169 on Sulla’s surname Felix, 297 Asinius Pollio, C. (cos. 40 bc), 89 Annaeus Seneca, L. (the Younger) Ateius Capito, C. (tr. pl. 55 bc), 165 on Sulla’s abuse of felicitas, 297 incident concerning falsification of auspices Annius Luscus, T. (cos. 153 bc) (55 bc), 183–202 attack on Ti. Sempronius Gracchus, 39 political motives, 185 Annius Milo, T. (pr. 55 bc), 306 Atilius Serranus Gavianus, Sex. (tr. pl. 57 bc), 84 murder of Clodius and indictment, 121–2 Augustus, 145, 213, see also ‘Octavian’ trial of, 165–74, 177–8 Aurelius Antoninus Augustus, M. Antistius Rheginus, C. (legate of Caesar in (emperor, 161–180 ad), 75 Gaul), 81 Aurelius Cotta, L. (cos. 144 bc), 42 Antonius Hybrida, C. (cos. 63 bc), 217 Aurelius Cotta, C. -

Sicily and the Imperialism of Mid-Republican Rome : (289-191BC)
SICILY AND THE IMPERIALISM OF MID- REPUBLICAN ROME : (289-191BC) John Serrati A Thesis Submitted for the Degree of PhD at the University of St Andrews 2001 Full metadata for this item is available in St Andrews Research Repository at: http://research-repository.st-andrews.ac.uk/ Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10023/11102 This item is protected by original copyright L Sicily and the Imperialism of mid-Republican Rome (289-191 BC) John Serrati Ph.D. Ancient History 19 January 2001 i) I, John Serrati, hereby certify that this thesis, which is approximately 96,000 words in length, has been written by me, that it is the record of work carried out by me and that it has not been submitted in any previous application for a higher degree. Signature of Candidate ii) I was admitted as a research student in October 1995 and as a candidate for the degreeofPh.D. in Ancient History in October 1996; the higher study for which this is a record was carried out in the University of St. Andrews between 1995 and 2001. iii) I hereby certify that the candidate has fulfilled the conditions of the Resolution and Regulations appropriate for the degree ofPh.D. in the University of St. Andrews and that the candidate is qualified to submit this thesis in application for that degree. F:-·;T,',,:.-~TD Signature of Supervisor ... .tt,"·.· .:.:.~~::;.L~~J Date ..I.'1.b.J~.~ .. "'"-...... .,r-'" In submitting this thesis to the University of St. Andrews I understand that I am giving permission for it to be made available for use in accordance with the regulations of the University Library for the time being in force, subject to any copyright vested in the work not being affected thereby. -

Some Minor Magistrates of the Roman Republic a Political History of the Quaestorship and the Aedileship
Some Minor Magistrates of the Roman Republic A Political History of the Quaestorship and the Aedileship Andrew Swidzinski McGill University Montréal October 2009 A thesis submitted to McGill University in partial fulfilment of the requirements of the degree of Masters of Arts. © Andrew Swidzinski, 2009. 1 Library and Archives Bibliothèque et Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de l’édition 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa ON K1A 0N4 Ottawa ON K1A 0N4 Canada Canada Your file Votre référence ISBN: 978-0-494-66367-7 Our file Notre référence ISBN: 978-0-494-66367-7 NOTICE: AVIS: The author has granted a non- L’auteur a accordé une licence non exclusive exclusive license allowing Library and permettant à la Bibliothèque et Archives Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par télécommunication ou par l’Internet, prêter, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des thèses partout dans le loan, distribute and sell theses monde, à des fins commerciales ou autres, sur worldwide, for commercial or non- support microforme, papier, électronique et/ou commercial purposes, in microform, autres formats. paper, electronic and/or any other formats. The author retains copyright L’auteur conserve la propriété du droit d’auteur ownership and moral rights in this et des droits moraux qui protège cette thèse. Ni thesis. Neither the thesis nor la thèse ni des extraits substantiels de celle-ci substantial extracts from it may be ne doivent être imprimés ou autrement printed or otherwise reproduced reproduits sans son autorisation.