“La Via Dell'acquaˮ in Valle Morobbia Di Graziano Tarilli
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Annexiv-Waste Management in Switzerland and Ticino
ANNEX IV - WASTE MANAGEMENT IN SWITZERLAND AND TICINO SWITZERLAND The Swiss Confederation, commonly known as Switzerland, is a federal republic made up of 26 cantons. Its capital is Bern and its population is about 8 million people. It is situated in Western Europe, bordered by Germany, Austria, Italy, France and Lichtenstein. Four official languages are spoken in Switzerland: German, French, Italian and Romansh. Other demographic characteristics of Switzerland are presented schematically in figure 1 and table 2. Politically, the Swiss Confederation is composed as follows. The federal constitution adopted in 1848 established the legal foundations of the country. This is one of the oldest constitutions in the world (Federal Chancellery, 2013). The federal constitution established the country as a direct democracy; therefore, citizens have the right to intervene in parliamentary decisions. Three levels of government exist: federal, cantonal and municipal. At the federal level, the parliament has the legislative power, the Federal Council is the executive and the Federal Court has judicial power. The parliament is composed of both the Council of States and the National Council, with 200 representatives in total. The Council of States has 46 representatives - two for each canton and 1 for half-canton. The National Council’s representatives are elected proportionally to the population of each canton. Modalities of election of the representatives vary within each canton. Switzerland is a very economically active and rich country. It has the fifth highest GDP per capita in the world (World Bank, 2013), and the majority of its businesses are from the tertiary sector. The most developed sectors in Switzerland are pharmaceutical and financial (with Zurich, Geneva and Lugano being the three biggest financial centres). -

Bollettino-15Luglio.Pdf
1 INDIRIZZI Prevosto: don Angelo Ruspini, Via Berta 1, Giubiasco 091.840.21.01 Vicario: don Juan Pablo Bravo Venegas, Via Berta 1, Giubiasco 091.840.21.02 Diacono: don Giorgio Ulrich, Viale 1814, 6512 Giubiasco 091.840.26.53 Angolo d’Incontro, Via S. Jorio 3, Giubiasco 091.840.21.04 Segreteria parrocchiale, Casella postale, Giubiasco 091.840.21.00 - Fax 091.840.21.03 - Orari di apertura – periodo estivo martedì e giovedì dalle 8.00 alle 11.00 www.parrocchia-giubiasco.ch ORARI DELLE CELEBRAZIONI GIUBIASCO VALLE MOROBBIA Eucaristia giorni feriali Eucaristia giorni feriali ore 9.00 martedì e venerdì Pianezzo: giovedì ore 9.00 ore 17.00 lunedì, mercoledì, giovedì (da fine agosto a fine giugno) precede il Rosario Carena: venerdì ore 17.30 (per la Parrocchia di S. Antonio) Primo venerdì del mese ore 16.30 adorazione Eucaristica Eucaristia giorni festivi e domeniche ore 17.00 Eucaristia in chiesa parr. S. Antonio: alternativamente * sabato ore 19.30 domenica ore 9.30 Eucaristia sabato e vigilia giorni festivi Pianezzo: domenica ore 10.45 ore 16.15 Eucaristia in casa Aranda ore 17.30 Eucaristia in chiesa parr. Eucaristia giorni feriali – periodo estivo (da fine giugno a fine agosto) Eucaristia giorni festivi Carena: venerdì ore 19.30 ore 8.00 Eucaristia in San Giobbe ore 9.00 Eucaristia in chiesa parr. Eucaristia giorni festivi – periodo estivo ore 10.30 Eucaristia in chiesa parr. Pianezzo: sabato o vigilia ore 19.30 ore 20.00 Eucaristia in Collegiata S. Antonio: domenica o festa ore 9.30 Eucaristia giorni festivi – periodo estivo ore 8.00 Eucaristia in San Giobbe Sacramento della Riconciliazione ore 11.00 Eucaristia in chiesa parr. -

Elenco Progetti
FONDAZIONE Archivi Architetti Ticinesi Fondo 037 - Architetti Alberto Camenzind e Bruno Brocchi Progetto Mappa Disegni Data Oggetto Luogo Committente Contenitore 78 15 82 1959 Casa unifamiliare a Montarina Lugano Walti S9 (f) 79 15 2 1959 Tomba Bellinzona Canova 80 15 7 1959 Concorso scuola Gersau Canton Svitto S10(f) 81 16 12 1960 Concorso palazzo del Governo Altdorf Canton Uri S10 (f) 82 16 5 1960 Proposta di trasferimento arsenale Altdorf Canton Uri 83 16 18 1965 Palazzo del Governo alla Winterbergstrasse Altdorf Canton Uri S10(f) 84 16 18 1968 Palazzo del Governo al comparto Palestra Altdorf Canton Uri S10(f) 85 16 9 1963 Edificio per la polizia Altdorf Canton Uri S10 86 16 35 1959 Funivia di Porto Ronco Ronco sopra Ascona-Al S10(f) 87 16 26 1957 Case monofamiliari triangolari e ortogonali Biasca Officine idroelettriche 88 17 57 1960 Casa del personale Biasca Officine idroelettriche 89 17 30 1953 Sistemazione terrazza palazzo Gargantini Lugano Balestra 90 17 4 1955 Trasformazione ufficio palazzo Gargantini Lugano Balestra S10(f) 91 18 36 1949 Società di Banca Svizzera: proposte di trasforma Chiasso Bankverein S10(f) 92 18 13 1959 Società di Banca Svizzera: riattazione atrio tesoro Chiasso Bannkverein 93 0 0 1958 Esposizione 50 anni di architettura S10 94 18 4 1958 Proposte di edificazione Castagnola Fratelli Bernasconi 95 18 3 1959 Concorso Banca Popolare Svizzera Lugano Banca Popolare Svizzera 96 18 35 1958 Dogana Commerciale Chiasso Confederazione S9 96 19 73 1958 Dogana commerciale Chiasso Confederazione 96 20 92 1958 Dogana Commerciale Chiasso Confederazione 96 21 100 1958 Dogana Commerciale Chiasso Confederazione Pagina 1 di 6 Progetto Mappa Disegni Data Oggetto Luogo Committente Contenitore 97 22 33 1959 Casa unifamiliare Lugano Morosoli 98 22 107 1960 Casa unifamiliare Figino Ing.Geo Mantegazza 99 23 11 1964 Proposta di nuova entrata Figino Antonio Mantegazza 100 23 48 1959 Casa di vacanza Novaggio Dr. -

Bulle Historic Tour
1 Orchestrion (1913) The only example of its kind in the world, the Soléa is an orchestrion (mechanical orchestra) built in 1913 for the café-restaurant Le Fribourgeois by the firm Weber in Waldkirch (Germany). Demonstration on request. This photo was taken inside the café Le Fribourgeois in 1913 and was commissioned by the firm Charrière et Cie. It shows an initial version of the smaller orchestrion that was replaced shortly afterwards by the current instrument. © Alfred Husser Musée gruérien, Bulle. The café Le Fribourgeois was designed according to plans drawn up in 1898-1899 by the architect Frédéric Broillet. The Le Solea orchestrion was built in Waldkirch (Germany) at the Weber Frères factory. It was sold and installed in Le Fribourgeois in 1913-1914 by the firm Charrière & Cie, from Bulle, which represented various manufacturers of harmoniums, player-pianos and orchestrions in the canton. The instrument was restored in 1977–78 by Les Frères Baud in L’Auberson. The oak cabinet measuring 4 metres long, 2.50 metres high and 1.10 metres wide houses a 52-note Feurich piano, 4 sets of 28 pipes – flutes, violin, baritone and “Gedeck”, a 28-note xylophone, a bass drum, a side drum, a tambourine, a triangle and castanets. In the bottom section, three pairs of bellows activated by an electric motor inflate two regulator reservoirs that supply the windchests. Rolls of perforated paper 36 cm wide, driven by a guide roller, are held against a metal bar commonly known as a “flat flute” with 88 apertures, each corresponding to a note or a function. -

Company Profile and Our References
OmniBus Engineering Intelligent Building Company O.E. OmniBus Engineering develops products and services in the field of Building Automation, Supervision, and Access Control. Founded in 2001, the company may count on the profound experience of its founders and partners, using the most innovative technologies. 2 O.E. OmniBus Engineering SA - Company Profile Company OmniBus is based on four principles: 1. Technology; 2. Product quality and reliability; 3. Flexibility and customization of solutions; 4. Customer Care. The solutions offered by OmniBus allow the: 1. Optimization of resources; 2. Cost reduction; 3. Increase in productivity; 4. Increased comfort. OmniBus addresses: Professional Studies of Engineering and Architecture; Construction companies; Real estate managing companies; Individual clients. 3 O.E. OmniBus Engineering SA - Company Profile Products and Services Flexibility and Expertise to cover every need. Three operational areas able to Solution for building automation provide solutions with various levels of intervention and complexity with the objective to always guarantee the best service. The world of access control Visualization and supervision systems 4 O.E. OmniBus Engineering SA - Company Profile Products and Services Solution for building automation • Efficiency with distributed control • Technology standards LonWorks® • System efficiency and optimization • Integration of AC and weather conditions • Customized management of functionality 5 O.E. OmniBus Engineering SA - Company Profile Products and Services Control Modules Commands Interfaces In summary: 1. Control of every type of lighting and shading systems; 2. Control functionality of digital and mechanical systems; 3. Interfaces for multimedia, weather stations, and peripheral devices; 4. Customizing of functionality to specific needs. 6 O.E. OmniBus Engineering SA - Company Profile Products and Services Control Modules Digital actuators to control lights on/off. -

Bollettino-21Febbraio.Pdf
1 Indirizzi utili Prevosto: don Juan Pablo Bravo Venegas, Via Berta 1, Giubiasco 091.840.21.01 o indirizzo mail: [email protected] Vicario: don Filippo Arcari, Via Berta 1, Giubiasco 091.840.21.02 o indirizzo mail: [email protected] Diacono: don Giorgio Ulrich, Viale 1814, 6512 Giubiasco 091.840.26.53 Segreteria parrocchiale: casella postale, Giubiasco 091.840.21.00 o indirizzo mail: [email protected] o orari: dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 11.00 Sito web parrocchiale: www.parrocchia-giubiasco.ch Orari delle celebrazioni Orari delle celebrazioni a Giubiasco in Valle Morobbia Eucaristia nei giorni feriali Eucaristia giorni feriali martedì e venerdì: ore 09.00 Pianezzo: martedì ore 09.00 giovedì e mercoledì: ore 17.00 Carena: venerdì ore 17.30 il lunedì non si celebra l’Eucaristia (per la Parrocchia di S. Antonio) Ogni primo venerdì del mese Eucaristia nei giorni festivi Adorazione Eucaristica: ore 16.30 S. Antonio: alternativamente* Eucaristia in chiesa parrocchiale: ore 17.00 o sabato: ore 17.30 o domenica: ore 09.30 Eucaristia il sabato e la vigilia dei giorni festivi Pianezzo: domenica ore 10.30 in casa Aranda: ore 16.15 in chiesa parrocchiale: ore 17.30 Eucaristia giorni feriali durante il periodo estivo (da fine giugno a fine agosto) Eucaristia nei giorni festivi Carena: venerdì ore 19.30 in San Giobbe: ore 08.00 Lôro San Rocco: martedì 19.30 (quindicinale) in chiesa parrocchiale: ore 10.30 in Collegiata: ore 20.00 Eucaristia giorni festivi durante il periodo estivo Eucaristia nei giorni festivi Pianezzo: sabato o vigilia ore 19.30 durante il periodo estivo S. -

Claro Pizzo 2020 Pagina 1/3
Claro Pizzo 2020 Pagina 1/3 (10) Uomini Posizione Nome Anno Luogo Squadra Tempo Distacco Pett. 1. Elazzaoui Elhousine 1992 Bedano Team Salomon 1:15.40,4 63 2. Delorenzi Roberto 1997 Sigirino Pini Factory Racing Team 1:17.07,9 +1.27,5 62 3. Marti Werner 1989 Grindelwald Grindelwald La Sportiva 1:18.49,0 +3.08,6 286 4. Delorenzi Marco 1999 Sigirino Pini Factory Racing Team 1:23.10,9 +7.30,5 61 5. Fontana Daniele 1999 Mesocco 1:23.12,8 +7.32,4 79 6. Dalcolmo Nico 1996 Klosters Scott Running 1:25.05,6 +9.25,2 77 7. Cairoli Andrea 1973 Lodrino Team Gotthard SkiMo 1:26.05,2 +10.24,8 285 8. Sboarina Gabriele 1990 Preonzo Dynafit 1:27.16,2 +11.35,8 287 9. Pervangher Mirco 1977 Prato (Leventina) Team Gotthard Skimo 1:30.15,7 +14.35,3 80 10. Malaguerra Fiorenzo 1977 Augio Team Merenderi 1:33.30,9 +17.50,5 76 11. Gazzola Marco 1971 Claro Team Hoka One One Switzerland 1:33.34,4 +17.54,0 54 12. Massera Fabio 1968 Isone SAIM Isone-Medeglia 1:34.11,4 +18.31,0 66 13. Mesman Jurgen 1986 Wabern 1:34.15,5 +18.35,1 115 14. Zanini Fausto 1990 Bignasco BIEMME 1:34.52,3 +19.11,9 90 15. Rossetti Edo 1972 Camorino SFG Locarno 1:34.57,8 +19.17,4 87 16. Cambiaggio Filippo 1988 I-Cannobio (VB) Z-Bike 1:35.30,2 +19.49,8 82 17. -
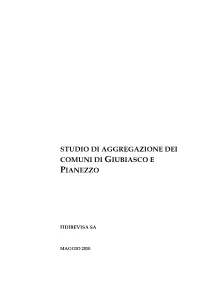
Studio Di Aggregazione Dei Comuni Di Giubiasco E Pianezzo
STUDIO DI AGGREGAZIONE DEI COMUNI DI GIUBIASCO E PIANEZZO FIDIREVISA SA MAGGIO 2010 I N D I C E PREMESSA .......................................................................................................... 3 PARTE I: DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE GEO-POLITICA E FINANZIARIA DEI COMUNI APPARTENENTI AL COMPRENSORIO DI STUDIO ................................................................. 4 1 ANALISI DEL TERRITORIO ..................................................................... 4 1.1 RAPPRESENTAZIONE GEOGRAFICA ..................................................... 4 1.2 ALTITUDINE, SUPERFICIE EDIFICABILE E DENSITÀ DELLA POPOLAZIONE ...................................................................................... 6 2 ANALISI DEMOGRAFICA ........................................................................ 8 2.1 SVILUPPO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ...................................... 8 2.2 EVOLUZIONE DELLA POPOLAZIONE PER CLASSI D’ETÀ ..................... 9 3 ANALISI DELL’ATTIVITÀ ECONOMICA .......................................... 12 3.1 OCCUPAZIONE .......................................................................................... 12 3.2 ADDETTI PER SETTORE D’ATTIVITÀ E SETTORI ECONOMICI PREPONDERANTI ................................................................................ 13 4 ANALISI FINANZIARIA .......................................................................... 15 4.1 QUALCHE DATO SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLE REGIONI TICINESI .............................................................................. -

Urbass Fgm Dr
Beraten. Planen. Steuern. urbass fgm Dr. Arch. Fabio Giacomazzi Monitoraggio Asse S. Gottardo - Fase A (MAG-A) Rapporto metodologico 3. Oktober 2017 Bericht-Nr. 2060.884-0.8 Rapp Trans AG | Ein Unternehmen der Rapp Gruppe Max-Högger-Strasse 6 | CH-8048 Zürich | T +41 58 595 72 30 | www.rapp.ch Seite 2 | MAG-A Rapporto metodologico Mandanti Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, Ufficio federale dei trasporti UFT, Ufficio federale delle strade USTRA, Ufficio federale dell’ambiente UFAM, Canton Ticino, Canton Uri Direzione del progetto (ARE) Ulrich Seewer (Vicedirettore), Aurelio Vigani (Capoprogetto) Gruppo di accompagnamento Gilles Chomat, ARE; Helmut Honermann, ARE; Mélanie Attinger, UFT; Matthias Wagner, UFT; Jörg Häberli, USTRA; Nikolaus Hilty, UFAM; Paolo Poggiati, Canton Ticino; Ruth Nydegger, Canton Ticino; Ronnie Moretti, Canton Ticino; Daniel Pittet, Canton Ticino; Marco Achermann, Canton Uri; Franziska Büeler, Canton Uri; Roger Brunner, Canton Uri; Christophe Siegenthaler, UST; Annette Spoerri, SECO; Simon Coray, Programma San Gottardo 2020; Patrick Buetzberger, FFS; Philipp Buhl, FFS; Stefan Lüthi, BHP – Brugger und Partner AG Mandatari Name E-Mail Telefono Gianni Moreni [email protected] 058 595 72 42 Paolo Todesco [email protected] 058 595 72 33 Lucas Meyer de Freitas [email protected] 058 595 72 35 Fabio Giacomazzi [email protected] 091 751 90 09 Elke Schimmel [email protected] 041 469 44 69 Agostino Clericetti [email protected] 091 913 91 00 Elaborazione di questa versione Versione Data Status/Änderung/Bemerkung File 0.1 21.09.16 Prima Bozza MAG-A_Rapporto metodologico intermedio_Rapp_V0.2_210916 0.2 07.10.16 Bozza rivista MAG-A_ Rapporto conclusivo intermedio_Rapp_V0.2_071016 0.3 23.06.17 Versione finale MAG-A_ Bozza Rapporto conclusivo_Rapp_V0.3_230617 0.4 03.10.17 Versione finale rivista MAG-A_ Bozza Rapporto conclusivo_Rapp_V0.4_031017 Rapp Trans AG | Ein Unternehmen der Rapp Gruppe 3. -

62.203 Bellinzona - Giubiasco - Camorino - S
ANNO D'ORARIO 2020 62.203 Bellinzona - Giubiasco - Camorino - S. Antonino (Linea 3) Stato: 6. Novembre 2019 Lunedì–venerdì, salvo i giorni festivi generali, salvo 6.1., 19.3., 1.5., 11.6., 29.6., 8.12. nonché 2.1., 10.4. 3001 3003 3007 3009 3011 3017 3019 3021 Bellinzona, Stazione 5 38 6 08 6 38 7 08 7 38 8 08 8 38 9 08 Bellinzona, Piazza Orico 5 43 6 13 6 43 7 13 7 43 8 13 8 43 9 13 Bellinzona, P. Indipendenza 5 46 6 16 6 46 7 16 7 46 8 16 8 46 9 16 Bellinzona, Isolabella 5 48 6 18 6 48 7 18 7 48 8 18 8 48 9 18 Giubiasco, Tre Castelli 5 50 6 20 6 50 7 20 7 50 8 20 8 50 9 20 Giubiasco, Piazza 5 55 6 25 6 55 7 25 7 55 8 25 8 55 9 25 Giubiasco, Stazione 5 57 6 27 6 57 7 27 7 57 8 27 8 57 9 27 Giubiasco, Stazione 6 00 6 30 7 00 7 30 8 00 8 30 9 00 9 30 Camorino, Ufficio Circolazione 6 03 6 33 7 03 7 33 8 03 8 33 9 03 9 33 Camorino, Pro Quadri 6 07 6 37 7 07 7 37 8 07 8 37 9 07 9 37 S. Antonino, Posta 6 10 6 40 7 10 7 40 8 10 8 40 9 10 9 40 S. Antonino,Centri Commerciali 6 45 7 15 7 45 8 15 8 45 9 15 9 45 3023 3027 3029 3031 3033 3037 3039 3041 Bellinzona, Stazione 9 38 10 08 10 38 11 08 11 38 12 08 12 38 13 08 Bellinzona, Piazza Orico 9 43 10 13 10 43 11 13 11 43 12 13 12 43 13 13 Bellinzona, P. -

62 Ticino E Mesolcina
www.fahrplanfelder.ch 2021 1 Region 62.000 Regione Ticino e Mesolcina Liniennetz Bellinzona Osogna– Monastero S. Maria Sauru (Pizzo di Claro) Scubiago sopra Claro Biasca San Nazzaro Gnosca– Lodrino– Biasca LUMINO Bellinzonese Bivio Lumino Bivio per Scubiago Ponton 20 21 21 Claro CappellettaLumino, PaeseAl Dazio Ponton 200 210 214 Mesocco 222 Claro, Paese 171 San Bernardino–Coira CLARO Sud Via S. Bernardino 213 Moleno 221 Cassero 221 Linea regionale Nord Alle Cave Polveriera Nord Basilea / Zurigo Linea locale/urbana PREONZO Preonzo, Paese 8 Polveriera 21 Airolo– Fermata in una sola Preonzo, Piazza Via Orbello direzione Bivio per Claro Via CantonaleRotondello 210 Capolinea Cusnà 171 Ponte Pacciaredo Gnosca, Centro CASTIONE Fermata apre nel 2021 Casa Comunale GNOSCA Rifugio Animali Linea ferroviaria 214 ARBEDO Castione, Chiesa Impianto a fune non incluso San Carpoforo Stazione 221 Carmagnola nel perimetro della CTA Burgaio al Maglio Zone abbonamenti CTA GORDUNO Molinazzo 21 Alla Rivetta al Ramone Scuola Media 2 210 Zone biglietti CTA Casa Greina Via Gerretta S. Anna Via Vallone S. Paolo Posta 21 31 Area attribuita a due zone tariali CTA Parco Giochi 210 310 al Persico Confine della zona CTA Bivio Galbisio Ocina FFS CTA: Comunità tariale Arcobaleno dalla Bett Lusanico Validità dal 13 dicembre 2020 Piazza Via Monte Gaggio Viale G. MottaMesolcina 214 Carasso 222 Scuola ARTORE 221 171 Media 1 Scuole Bellinzona, Stazione Via Lepori 221 Via Mirasole Via Malmera Bagno Pubblico 2 3 1 4 Pichitt Artore, Paese 222 Pian Lorenzo Bramantino Castello Montebello Viale Portone 20 Via Vela Castello Sasso Corbaro Espocentro 311 200 BELLINZONA 5 Ospedale 2 221 Von Mentlen Piazza Orico Belsoggiorno S. -
![Bayer Switzerland 2019 [CHF] Individual Named Disclosure](https://docslib.b-cdn.net/cover/1010/bayer-switzerland-2019-chf-individual-named-disclosure-4181010.webp)
Bayer Switzerland 2019 [CHF] Individual Named Disclosure
Bayer Switzerland 2019 [CHF] Individual Named Disclosure ‐ one line Donations and Contribution to costs of Events Fees for services and consultancy Total per HCP Grants Full‐Name HCx ID Principal Practice City of Principal Zip Code Donations and Events ‐ Events ‐ Events ‐ Travel & Fee for Fee for Total Address Practice Grants Sponsorship HCP Registration Fees Accommodation Service/Consulta Service/Consulta ncy ‐ Fees ncy ‐ Related Expenses Dr. Raffael À Wengen 1055263028 Tièchestrasse 99 Zürich 8037 0.00 0.00 74.40 1,761.60 0.00 0.00 1,836.00 Dr. Haythem Abbes 1051676484 Avenue du Grand‐ Sion 1950 0.00 0.00 0.00 2,016.30 0.00 0.00 2,016.30 Champsec 80 Dr. Marc Abdelmoula 40758485 Rue Des Alpes 2 Gland 1196 0.00 0.00 276.00 748.35 0.00 0.00 1,024.35 Dr. Linda Abrecht 40720858 Sägestrasse 37a Langnau im 3550 0.00 0.00 988.00 1,818.10 0.00 0.00 2,806.10 Emmental Dr. Rainer Adam 40742150 Neuengass‐ Bern 3011 0.00 0.00 800.00 6,298.00 0.00 0.00 7,098.00 Passage 2 Dr. Astrid Ahler 40537226 Vogesenstrasse Basel 4031 0.00 0.00 0.00 0.00 525.00 0.00 525.00 134 Dr. Friedrich Aigner 40540758 Seilerstrasse 8 Bern 3011 0.00 0.00 0.00 803.20 0.00 0.00 803.20 Dr. Dilara Akhoundova Sanoyan 1060469582 Rämistrasse 100 Zürich 8091 0.00 0.00 66.00 610.70 0.00 0.00 676.70 Dr.